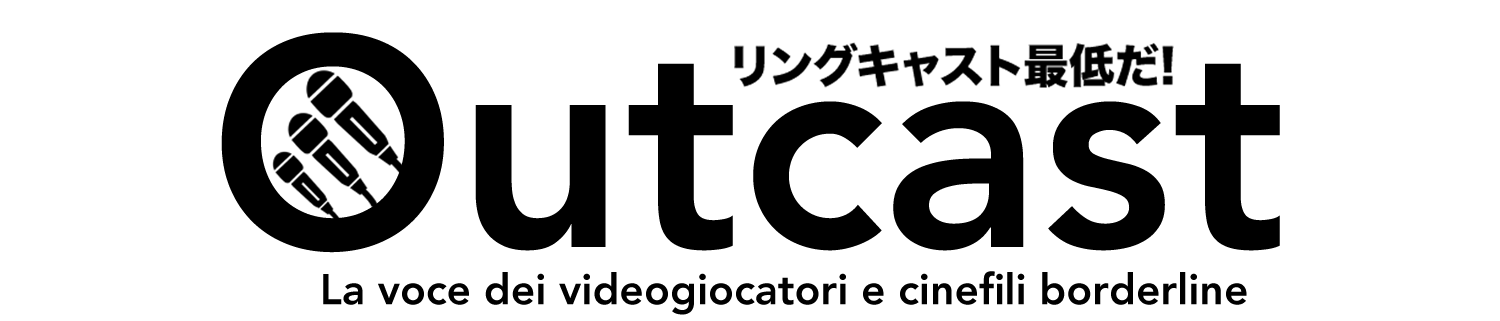Mad World e il marrone che cambiò tutto
Nei videogiochi la comunicazione non è importante, è l’unica cosa che conta, parafrasando un detto in uso ai gobbi.
Da quando i cabinati avevano colori sgargianti e proponevano immagine idealizzate ultradettagliate di quelli che poi erano quattro pixel in croce o uno schema vettoriale astratto a cui si dava valore, colmando il gap della grafica con la suggestione dell’immagine, di navicella spaziale.
Da quando gli attract mode dovevano sparare a cannone luci e colori e farti vedere roba che senza lo srotolare chili di monetine sonanti non avresti mai realizzato.
In principio la distanza che separava il gioco della pubblicità era siderale in termini figurativi, poi questa si è progressivamente riidotta quanto il mezzo videogioco ha iniziato ad avere un linguaggio più potabile per il grande pubblico, avvicinandosi a quello cinematografico, permettendo di ricostruire una narrazione con un montaggio ad arte. Questa distanza la possiamo vedere ancora oggi, se provate a soffermarvi sulle varie riedizioni di giochi vecchi, o su giochi che fanno dell’estetica “vintage” una feature: frammenti confusi di livelli, musica a cannone e slogan strillati che ne propongono le feature.
Sto facendo breve una storia lunga, riducendo una serie di esperienze che andrebbe approfondita meglio, momento per momento, ma non è questo che vuole fare questo pezzo.
I videogiochi, come tutti i prodotti commerciali che devono raggiungere un pubblico enorme, vengono spesso raccontati per ciò che i probabili acquirenti vorrebbero vedere in loro, quindi più di quello che realmente sono, tarando su bacino di utenza, fasce di età, ceto sociale e compagnia cantante.
Così in Italia la guerra Sega-Nintendo si è perpetrata attraverso l’epoca d’oro delle pubblicità, che vedeva contrapposti gli schieramenti Jerry “Ocio, però, sono Giochi Preziosi” Calà a Jovanotti prima della svolta cattocomunista a piedi scalzi, ancora simbolo del cool anni ‘90 e del nuovo che avanza, e in mezzo una serie di volti e voci calcistiche chiamate ad attirare l’attenzione dell’uomo della strada.
Tutto il momento pubblicità video-arte con David Lynch non me lo ricordo, non so nemmeno se da noi è mai arrivato, l’ho riscoperto poi conoscendo Lynch, per me la pubblicità di Playstation era il gabibbo con i CD azzeccati addosso che giocava a Crash con le veline durante striscia la notizia, ma per quanto ne so potrebbe aver diretto Lynch anche quella. Potrebbe essere il motivo per il quale non mi sono mai appassionato alla prima vera mascotte di Sony? Sfido chiunque a metterlo in dubbio.
Sulla carta era un’altra storia, io riviste specializzate per le mani non ne ho mai avute, ma leggevo Topolino e quella comunicazione ammiccante e aggressiva dell’epoca PlayStation 2 - Gamecube l’ho sempre amata, per la capacità di sintesi nel raccontare un mood con una singola immagine impattante che spaccava la rivista.
Capito, Nintendo?
L’epoca dei fatti che voglio raccontare, però, è di poco successiva.
Pensare che Wii sia tra le console più vendute della storia e la sua immagine in Italia venga associata a Giorgio Panariello fa riflettere. È un’associazione figlia degli spot pubblicitari di cui sopra, ma con un’estetica più polish, leggibile, meno giovanilistica, capace di proiettare anche “tua nonna” nel mondo del gaming contemporaneo.
Nintendo Wii era la nuova figata in città.
Era estate ed eravamo tutti più giovani e carichi di speranze, aspettative e tempo libero. Si migrava di casa in casa in occupazioni oziose, ora Dungeons & Dragons, ora Magic, ora qualche importante chiusone su un vecchio Final Fantasy, aspettando le ore più fresche per fare “le vasche” in centro e incontrare altra gente che aveva avuto pomeriggi oziosi e diversi dai nostri.
Da Gabriele giocavamo con una Wii nuova di pacca, a Twilight Princess, ma soprattutto in due a Mario Strikers, che ai miei occhi non più abituati al gaming console, assuefatti ad anni di Total War ed Age of Empires, sembra velocissimo e colorato, super saturo, super pieno, Super Mario (che ormai non toccavo dai tempi di Super Mario 64). Così tanto colore e divertimento senza sbattimenti di litigare con i driver, gli emulatori, le ROM, le ISO e i dischetti che non funzionavano mai per una sessione di gioco intera.
Se non che, lo vedemmo in un passaggio televisivo:
Non so se fu la gravitas suggerita dalla musica, la stucchevole immagine della statua di angelo spaccata o il senso di scala che dava sparare ad un mostro colossale, fatto sta che noi sedicenni guardammo la Wii che ci aveva esaltato fino a due minuti prima come se fosse un rimasuglio dell’infanzia, un dente da latte che avremmo dovuto perdere per mettere giudizio, e rimanemmo impalati davanti a questo trailer. Chi aveva mai preso in considerazione una Xbox prima di tutto ciò? Avevo già giocato ad Halo, ma su pc, quindi non conta, e la prima Xbox nemmeno l’avevo mai vista dal vivo.
Fu segnante.
Nei miei ricordi, Gab e io ci siamo guardati e ci siamo detti “Ua ma che cazz abbiamo fatto fino e mo?” Presi nel mezzo dell’adolescenza, travolti da quella cosa che era così tanto altro rispetto a quello a cui eravamo abituati. Con gli occhi di oggi, non è che i giochi marroni mancassero, Tomb Raider era tutto marrone, la nuova versione di Prince of Persia che amavo alla follia, pure, era marrone, e il suo seguito, Spirito Guerriero, tutto pompato a palette terre e musica metal, ma nella nostra percezione nessuno aveva così ben interiorizzato e reso estetica una paletta cromatica così deprimente, che diventata quindi sinonimo di terrea maturità, lontana dall’astratto mondo di figure e personaggi naif che proponeva Nintendo, in un periodo storico e in un’età della vita che sarebbe dovuta essere la fine dell’infanzia e l’inizio della disperazione.
Negli anni a venire, Gears of War era il titolo da avere. Più di Halo, se possibile, perché godeva di una componente multiplayer locale molto figa e, a partire dal due, la modalità Orda, che da sola faceva vendere il gioco, tanto da diventare il centro di interi pomeriggi o di “Partita a Orda prima di scendere”. Gears, molto più di Halo, ha rappresentato lo spirito di Xbox 360, da un lato perchè il nocciolo della saga, i tre giochi davvero rilevanti, lo abbiamo avuto tutto nell’arco di vita di una sola macchina, una cosa che con i tempi di sviluppo di oggi è impensabile. Dall’altro perché rende fighi gli sparatutto in terza persona con le coperture, che sulla carta sono una rottura di coglioni stratosferica, e infatti tutti e tre i giochi si focalizzano sempre sulla rottura del falso senso di sicurezza dato dalle coperture, con l’aggressività dei nemici tutta rivolta all’aggiramento della copertura, culminando con un terzo capitolo che quindi risulta ancora oggi molto dinamico, attuale e genuinamente divertente da giocare. Sì, se lo chiedete a me, dopo non è stato più divertente, Gears. Sparare ai robot, davvero qualcuno ha pensato che fosse una buona idea far passare mezzo gioco a sparare ai robot? E non apriamo il capitolo open world.
Senza tralasciare il fatto che Gears of War, come pure Unreal Tournament ma forse molto di più di Unreal Tournament, è stato un colossale showfloor di ciò che il motore Unreal poteva fare. Lato nostro giocatori, sapevamo sempre che il logo "UNREAL ENGINE” in avvio era sinonimo di figata. E personaggi tozzi come barili, e una paletta cromatica che oscillava tra il marrone e il grigio (ma se dobbiamo essere sinceri, Bulletstorm me lo ricordo “colorato”).
Ancora oggi, non so battere Raab, il boss finale del primo Gears, da solo. All’epoca ci giocai in co-op locale proprio con Gab, in uno di quei chiusoni storici, probabilmente a seguito di qualche assemblea d’istituto, aneddoto che ancora oggi costituisce una delle pietre angolari della nostra amicizia decennale.
Questo articolo fa parte della Cover Story marrone, che potete trovare riassunta a questo indirizzo qui.