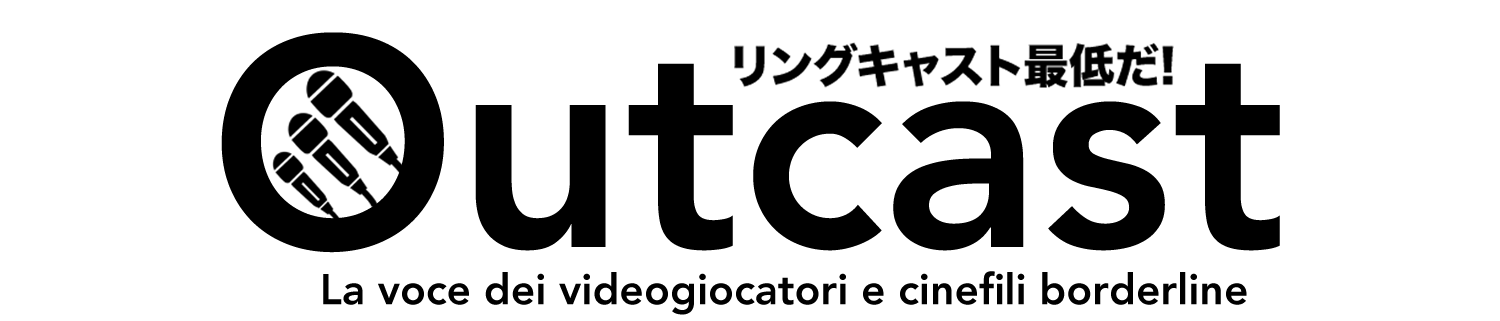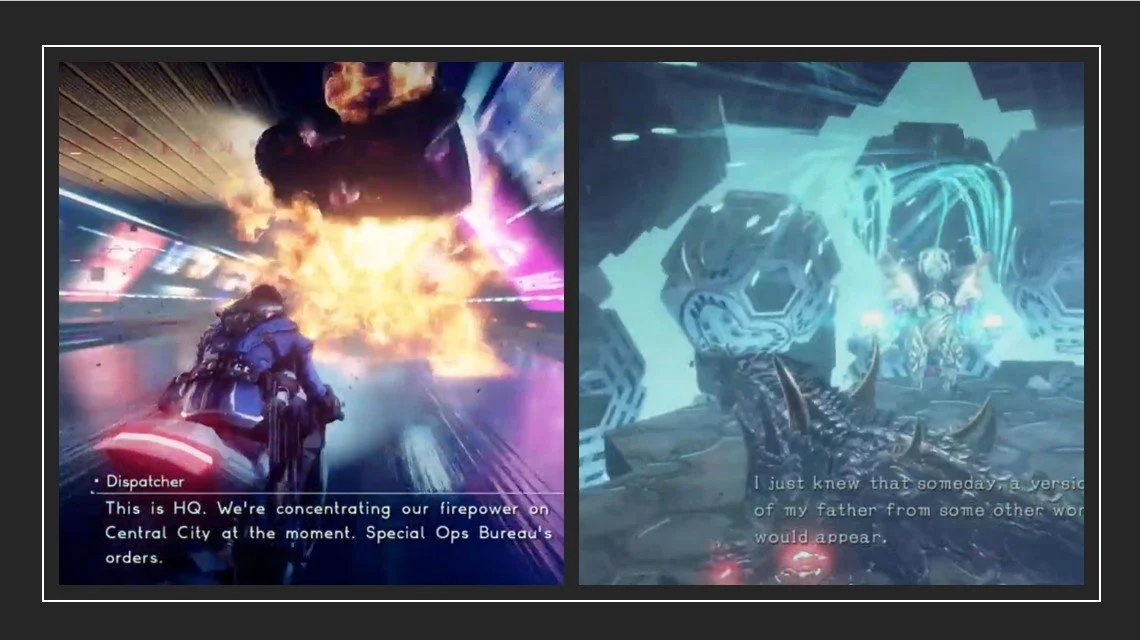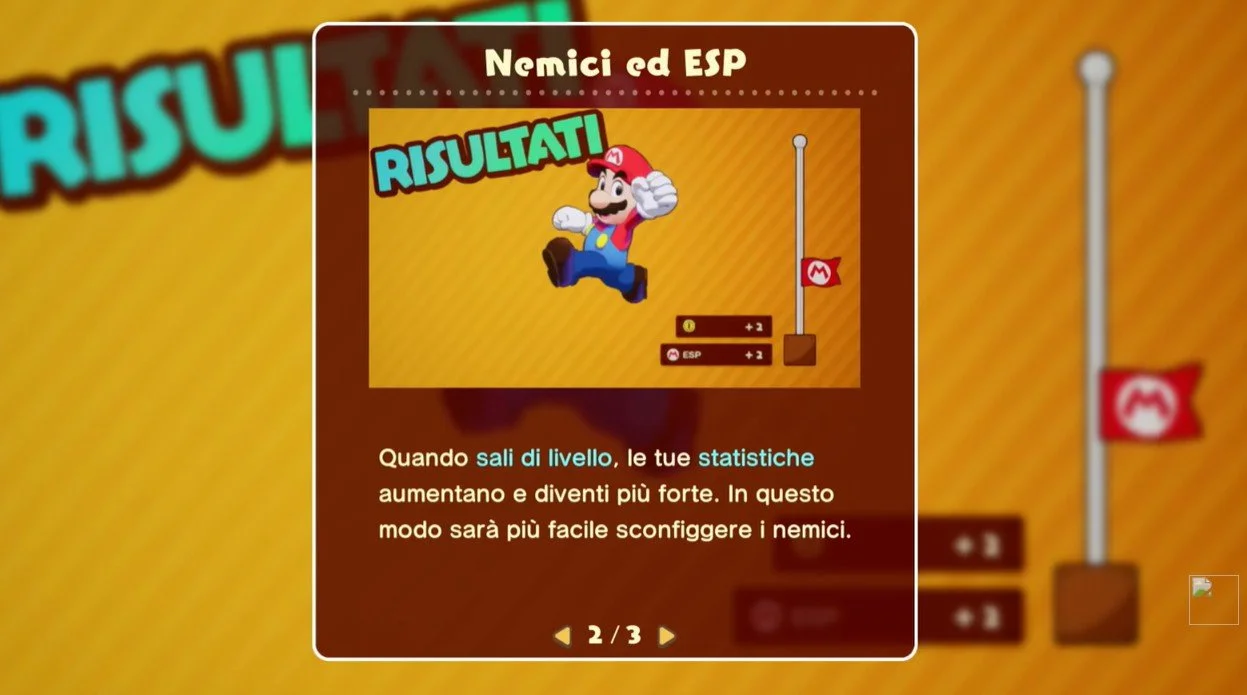Chi ben comincia...
…è il fantasma dell’opera.
Un inizio coinvolgente è essenziale per poter catturare il pubblico. Per esempio, quello di questo articolo non lo è. Utilizzare un’oscura citazione dalle telecronache calcistiche della Gialappa’s Band, buttata lì come un mozzicone di sigaretta, ha un tenue legame con l’argomento, lascia perplessi e probabilmente sarete già saltati al paragrafo successivo, se non direttamente ad un ‘altra pagina.
Il paragrafo successivo è questo, bentornati, L’incipit poco sopra un minimo di senso, invero, ce l’ha: è goffo e prolungato, come l’introduzione di Bayonetta 3.
Per pura causalità, in questi giorni ho provato due giochi Platinum, uno in fila all’altro: Astral Chain e Bayonetta 3 (stranamente avevamo esaurito i giochi per Switch 2). Ora, al di là del fatto che questo fornisca la cifra di quanto io sia rimasto indietro sulle ultime uscite, mi ha fatto apprezzare come i primi minuti di un videogioco, peraltro di prodotti dalla medesima software house, possano essere galvanizzanti o disastrosi.
Astral Chain, diciamocelo, è un casino di gioco. Il suo sistema di controllo è così stratificato che se ci stai lontano dieci minuti già ti sei scordato metà delle combinazioni di tasti essenziali per sopravvivere. Astral Chain però sa come iniziare, oh se lo sa! Dopo un bel filmato che introduce alcune figure chiave e un po’ di mistero (e dove stranamente tutti hanno una tuta anticontaminazione tranne due tizi, va a sapere), ti lancia su una strada a folle velocità in una replica delle sessioni d’intermezzo di Bayonetta. Mette a schermo due indicazioni striminzite per permettere di avere sotto controllo la situazione e poi, una volta appiedato, ti butta nella mischia, dove meni un po’ alla cazzo ma ti senti un grande, un vero bro di zona. Infine, dopo un po’ ti pim-pum-pam-patatrack e fuochi d’artificio, il gioco vero e proprio inizia ed è pure bello, ma qui ci fermiamo.
L’introduzione di Bayonetta 3, sotto l’aspetto del mero impatto, spacca con la “K”. Ha alcune soluzioni estetiche interessanti e un antagonista con una cazzima che levati. Eppure, sbaglia troppo. Lancia in medias res supponendo che il fruitore sia pronto, che sappia cosa sta succedendo da un punto di vista narrativo e che, ludicamente, abbia gli strumenti per affrontare l’avversità postagli di fronte. Non è così. Si tratta di un errore madornale. Primo perché non si crea empatia o emozione per gli eventi a schermo, si è smarriti e anche le interessanti soluzioni estetiche, protratte per troppo tempo, diventano noiose. Secondo (ed è l’aspetto più grave) apparecchia questa lotta in un piano etereo, dove non sai bene dove camminare e dove volare, non vieni istruito su come queste azioni debbano essere svolte, quale tasto pigiare, come orientarti. A un certo punto, colpo di scena, il gioco ti mette ai comandi della protagonista sotto forma di drago e sembra di far sterzare un autoarticolato. Si menano fendenti a vuoto con la grazia di un frigorifero lanciato giù dalle scale e a poco serve che si sia quasi invincibili (i designer stessi sanno di averti messo in una situazione di merda). Poi ho spento.
Due casi simili, guidati dalla stessa filosofia, due risultati opposti. Laddove uno permette di gestire il casino e pompare adrenalina, l’altro genera frustrazione e sbadiglio. Che retromarcia rispetto alla scazzottata sulle ali di un jet in Bayonetta 2.
Platinum vs Platinum.
Così come per la genitorialità, non c’è un modo univoco per interpretare una partenza, per mettere in scena dei buoni primi dieci minuti. Super Mario 64 non sparava alcun fuoco d’artificio, ma faceva leva sulla novità e sulla gioia di potersi muovere in libertà in un ambiente 3D. Metal Gear Solid replicava in tutto e per tutto un film rendendo l’introduzione cinematografica interattiva. God of War 3 sceglieva, come Platinum games, la strada dell’esagerazione e dell’eccesso, con quell’epica scalata dell’Olimpo. Tre esempi diversissimi, tre titoli con ouverture che rimangono scolpite nelle sinapsi.
Non sono qui per fare un elenco di tutte le introduzioni della storia, mi affascinano però quelle che funzionano e il perché: è come vien presentato il mondo di gioco e le sue meccaniche, sono le prime sensazioni viscerali o anche solo quanto ci metta il titolo in questione a fornire controllo e libertà o meglio, è una combinazione di questi fattori.
Un buon metro di giudizio è pensare a un gioco, uno qualsiasi che vi è piaciuto, e immaginarsi di riprenderlo in mano. Se venite colti dallo sconforto alla sola idea di replicarne i primi istanti, allora qualcosa è andato storto.
In Super Mario 64 si giocava ancora prima di premere START.
Negli ultimi anni, l’attenzione dei designer è stata posta pesantemente sule sensazioni iniziali, sull’esperienza delle fasi introduttive. Da un lato gli indie, forti di meccaniche più semplici e durate più contenute, si sono riappropriati di una certa immediatezza; dall’altro le grosse produzioni, vuoi per l’insegnamento del mondo indipendente, vuoi perché coscienti di aver eccessivamente appesantito le loro ouverture, hanno tentato di snellire l’approccio. Ricordate cos’era muovere i primi passi nei mondi digitali all’inizio degli anni 2000, con quella smania di non perdere l’utente e dovergli spiegare tutto? Salta tre volte, muoviti da qui a lì, fai la giravolta, falla un’altra volta…due coglioni così grossi da non poter accavallare le gambe. Erano introduzioni figlie di un medium che aveva perso la sua essenzialità da sala giochi, quei tempi in cui te la cavavi con un attract mode fatto bene e due didascalie sul cabinato (in genere era spara o salta), quella filosofia così ben interpretata da Wario Ware Inc. I giochi nel nuovo millennio, invece, si erano fatti grossi, stratificati, pieni di meccaniche e toccava spiegarle. Erano gli anni di Wii e dell’allargamento del mercato, gli anni di Prince of Persia che “no, non è andata così”, gli anni in cui Nintendo inseriva un secondo DVD in Super Mario Galaxy 2 per illustrarne le funzionalità. Ce la si metteva tutta per prendere per mano il giocatore ma con questo si rischiava di rendere gli incipit soporiferi. E che dire degli anni ’90, che con l’arrivo del CD ci si sentiva in dovere di riempire la memoria a colpi di introduzioni cinematografiche?
Son due approcci diversi, che oggi farebbero storcere il naso, ma mentre il primo era figlio della paura e risultava sostanzialmente goffo, il secondo era, quando ben dosato, espressione di passione e capace spesso di introdurre in maniera galvanizzante al mondo di gioco. Certo, a rivederla oggi, quell’introduzione di Resident Evil, fa sorridere per ingenuità, ma ai tempi funzionava. Ai giorni nostri però ci vuole altro. Si è capito che un videogioco non è un libro, non ha quei tempi dilatati. Non è nemmeno un film, perché richiede interattività. E non è sicuramente un boardgame, perché soffre gli spiegoni. Dunque, si è aperta la strada alla narrazione interattiva e ambientale (anche se ci sarebbe da ridire sull’eccesso di e-mail e foglietti lasciati in giro da NPC grafomani, ma se Dio vuole stiamo capendo anche questo). Si è iniziato a mettere il giocatore al controllo sin dal minuto zero, lasciando ai momenti successivi filmati e illustrazione delle meccaniche. Si sta provando ad abbandonare la giustificazione diegetica delle funzioni dei tasti, che risulta spesso sgraziata. Funziona magnificamente nel caso della richiesta di guardarsi intorno per impostare l’asse X, come succedeva per esempio in Halo, ma risulta pedante se allargata a tutte le altre azioni. In generale è inoltre spesso giustificata narrativamente con un “ti sei dimenticato”, “sei nuovo”, sei fuori forma” che pare che abbiamo sempre a che fare con eroi sprovveduti o ottuagenari. In mancanza di opzioni migliori, un tasto in sovrimpressione sarà meno elegante ma è più efficace e spezza meno il ritmo.
Una delle cose più tediose a cui mi sia sottoposto recentemente è la fase iniziale di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica: lenta, ripetitiva, didascalica… senza contare la cacofonia delle decine di volte in cui si sente ripetere “MARIO!”, “LUIGI!”.
Non sono tuttavia i soli tutorial il cuore delle introduzioni, è una questione di immersione nel mondo, cercando però di evitare lunghe esposizioni. Si dovrebbe fare un bel rogo con tutti quegli NPC prolissi che blaterano per ore come se avessero di fronte un deficiente, ritardando la presa dei comandi. Ugualmente deleteria può essere una fase inziale lenta, fatta di camminate e azioni limitate (la mossa Half-Life era memorabile nel 1998, oggi non se ne può più). È uno dei motivi per cui spesso, negli action game, si parte con protagonisti al massimo delle loro capacità, che poi per un motivo o per l’altro vengono sottratte. È un assaggio della potenza estrema raggiungibile, l’introduzione risulta spettacolizzata, sostenuta dalle abilità del personaggio la cui potenza estrema non rende inoltre il primo approccio problematico da un punto di vista della difficoltà. Lo show è garantito. Questo se ti chiami Astral Chain, un po’ meno se sei Bayonetta 3.
Ripercorrendo mentalmente alcuni degli incipit videoludici che mi sono rimasti impressi, è palese come non esista una ricetta valida per ogni genere e come le migliori pratiche siano mutate con la tecnologia e con le esigenze. Ciò che valeva nei coin-op degli anni ’80 non è replicabile oggi; allo stesso modo, i primi passi in un titolo in VR sono diversi rispetto a un’esperienza su schermo standard e tutto questo senza considerare generi che si rivolgono a una nicchia di appassionati rispetto a prodotti per un pubblico generalista o variabili come il target demografico, l’importanza della storia, la stratificazione delle meccaniche… Addirittura la proliferazione del numero dei tasti sui controller ha un ruolo nell’accessibilità. Le variabili non sono poche e poi oh, noi siamo Outcast, scrivere manuali di game design non è il nostro intento. Il distillato di questo flusso di pensieri è che un buon approccio deve fornire un obiettivo, creare un legame narrativo in maniera intrigante ma più di ogni altra cosa contano le tempistiche. Non si può smaronare un utente troppo a lungo, è deleterio tenerlo a distanza dal pad in contemplazione o interromperlo costantemente. È per questo che le migliori partenze sono quelle che insegnano attraverso l’esperienza (il livello 1-1 di Super Mario Bros. è un manuale di design in movimento), che creano un legame immediato tra controller e schermo e lasciano che il mondo si sveli poco alla volta divertendosi, come in Doom e nel suo reboot del 2016, per esempio. Per tornare all’analogia con il distillato, il processo deve tagliare teste e code e restituire solo il cuore dell’esperienza, onde evitare di guastarne il gusto.
Molti altri potrebbero essere gli esempi, dalla partenza al cardiopalma di Uncharted 2 (pur con una scalata eccessivamente prolungata), al filmato di Oddworld: Abe’s Oddysee che mutava senza soluzione di continuità nel giocato. Tuttavia, come si accennava, stilare una lista non era lo scopo di questa riflessione (ma se volete aggiungerne nei commenti non mi offendo), piuttosto era fare luce su alcuni aspetti che rendono memorabili certi capolavori. Perché è vero che ad un inizio zoppicante si può recuperare, ma richiede benevolenza da parte del pubblico e un certo blasone da parte del titolo in questione. Per tutti gli altri giochi, in un mondo fatto di servizi all you can eat come il Game Pass, coinvolgere immediatamente è essenziale: l’utente che partecipa con trasporto può scusare qualche momento meno riuscito nel prosieguo, ma un inizio maldestro rischia di perderlo per sempre.