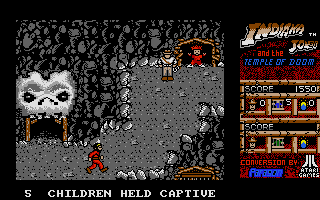Indiana Jones and the Temple of Doom: il Tempio Maledetto che mi ha cresciuto
Prima di Star Wars, prima de Il signore degli anelli, prima dell’ossessione per questo o quel franchise, prima ancora che ricordi il primo ricordo… c’era Indiana Jones. Non ho memoria della prima volta che l’ho visto: è sempre stato lì, come uno di famiglia o come quella cicatrice che ho vicino all’occhio. Forse perché a uno di famiglia piaceva veramente tanto, e appena la TV passava anche solo un frame di un film di Indy, scattava la modalità “visione obbligatoria”. Come la messa cattolica, ma con più fruste. O forse con MENO FRUSTE? Non so, è un po’ che non vado in chiesa in effetti, metti che son cambiate le cose…
Indiana Jones è stata la mia prima vera passione cinematografica. E d’altronde, come poteva non esserlo? I film erano tutti eccezionali e Indiana era troppo figo per non fare breccia nel cuore di un bambino: sarcastico, coraggioso e sfigato quanto basta. L’ultima crociata rimane ancora oggi il mio preferito, seguito da I predatori dell’arca perduta, e infine Il tempio maledetto, più che altro perché mi terrorizzava sul serio.
“You may not like it but this is what peak performance looks like!”
Avendolo rivisto di recente, pur non essendone più così terrorizzato, capisco anche il perché. Pare faccia leva su tutte le mie paure ancestrali… o forse è proprio l’origine delle mie paure ancestrali. Cuori strappati dal petto, carne bruciata, sacrifici umani: sono un convinto sostenitore del fatto che ciò che è dentro al corpo dovrebbe restare dentro al corpo. E poi c’è quella scena della trappola con gli insetti. Talmente radicata nella mia mente da ricordarmi a memoria il punto esatto in cui succede e la battuta che la preannuncia: “Pare di camminare su dei biscotti!” dice Short Round, pochi secondi prima di accendere la luce e rivelare migliaia di scarafaggi e scolopendre. Quel momento l’avevo memorizzato: era il segnale per correre in bagno o coprirmi la faccia con le mani, a scelta. Un’intera collezione di traumi, insomma.
Cuori in fiamme. Non benissimo. Che ora in effetti a pensarci somiglia un po’ a Lino Vairetti degli Osanna.
Parallelamente a tutto questo, a casa avevo un Atari ST, da buon figlio di musicista, e un giorno mi ritrovai nella scatola dei floppy Indiana Jones e il tempio maledetto. Sì, mi ritrovai, ché i giochi in casa mia comparivano in modo spontaneo, apparentemente ordinati via posta o ritirati di persona da un losco piratone dell’epoca (tale MEGAGURU) con sede nel retrobottega di un negozio di souvenir vicino al Vaticano. Vabbè, fatto sta che, visto che stava lì, che fai, non lo provi?
È LUI! È il prigioniero spennacchiotto!
E in realtà ricordo di averci giocato un bel po’. Forse perché la cosa più spaventosa del gioco non erano i nemici, ma i bambini da liberare: inquietanti bambolotti pixellosi, immobili, con questi capelli sparati in testa, prigionieri in gabbie da cui sporgevano come pupazzi indemoniati. Di gran lunga più inquietanti di qualsiasi sacerdote Kali.
Non sapevo, né potevo sapere, che quella era la conversione orripilante di un gioco arcade già discutibile di suo. Ma ai tempi vigeva la regola aurea dell’infanzia: hai quello che hai e te lo puppi. E col tempo, ragioni per pupparmi Indiana Jones e il tempio maledetto le trovai.
Prima di tutto, beh… eri Indiana Jones. Pochi personaggi avevano un’aura così potente. E il tutto in un gioco action! Per dire, avevo anche Indiana Jones e l’ultima crociata, ma quella era un’avventura grafica LucasArts, di gran lunga superiore in ogni aspetto. Però che volete farci: frustare cattivi batte risolvere enigmi, nella testa di un bambino.
Aveva anche delle meccaniche sfiziose. Adoravo spostarmi da una piattaforma all’altra usando quella specie di tronchi (rami? ganci? sarcazzo?) sparsi per i livelli. Pochi momenti sono così impressi nella mia mente come quello in cui ho scoperto che si poteva fare. Mi piaceva anche lo sprite del nemico serpente, quasi simpatico. Mi dispiaceva perfino scacciarlo.
A guardarlo fermo così pare anche bello, ma aspettate di vederlo in movimento.
Ricordo le corse nei carrelli, sicuramente la mia parte preferita del film. E come sempre accade con la memoria, rigiocandoci qualche giorno fa… eh! Diciamo che il design e la velocità non hanno retto benissimo il confronto col tempo. Mamma che monnezza! E poi c’era quella versione cicalino della colonna sonora: ma ai tempi, senza Spotify e senza YouTube, anche solo sentire due note gracchianti era oro colato.
Era un obbrobrio, un classico obbrobrio di quegli anni, ma era il mio obbrobrio. E a pensarci oggi, in mezzo a sequel discutibili e reboot improbabili, quell’orribile gioco su Atari ST ha ancora qualcosa da dire. Tipo: “Eh, magari era brutto forte… ma almeno non c’era Shia LaBeouf che faceva Tarzan con le scimmie!”.