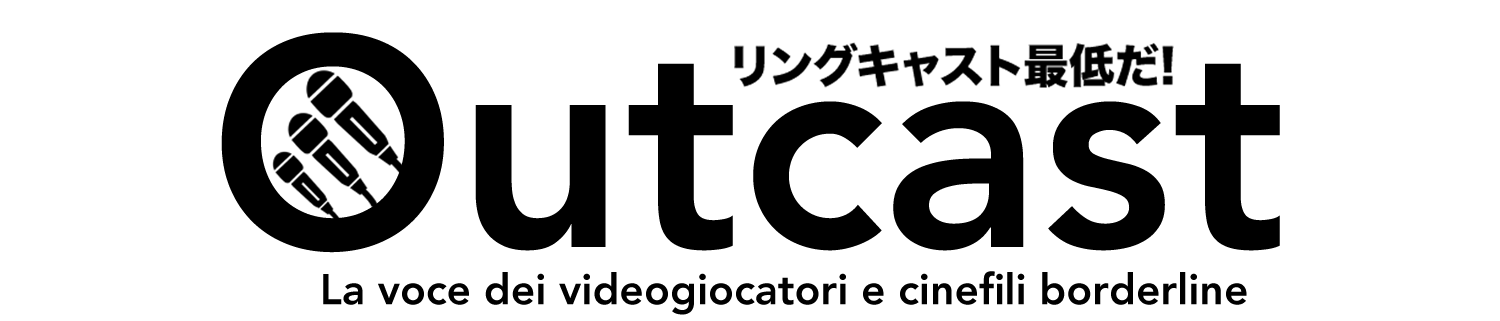Tema, argomento libero: “I videogiochi e io” | Racconti dall'ospizio
Racconti dall’ospizio è una rubrica in cui raccontiamo i giochi del passato con lo sguardo del presente. Lo sguardo di noi vecchietti.
Svolgimento.
La vita di noi bambini dei primi anni Sessanta/metà Settanta era fatta di Lego, piste Polistil e Policar e Bruciapista e Sizzlers della Mattel, giochi in scatola Editrice Giochi, supereroi Baravelli, l’amico Jackson e Big Jim; anche qualche G.I. Joe, che allora era alto 30cm e che noi chiamavamo, rigorosamente, il Gigioe. E pochissima, pochissima TV, un paio di ore al giorno, anche meno. C’era solo la TV dei Ragazzi dalle 17 in poi, quando, letteralmente, cominciavano le trasmissioni di RAI 1. Anzi, della RAI, dato che RAI 2 è arrivata quando ero già alle elementari, e bisognava far modificare il vecchio televisore per vederla. Leggevamo romanzi per ragazzi (tanto Giulio Verne e Alessandro Dumas) e fumetti (tanti Topolino, Corriere dei Piccoli, Uomo-Ragno, Devil e Fantastici Quattro; pochi Superman, anzi, Nembo Kid, e Batman, che trovavo un po’ sciocchini). La RAI ci censurava Scooby-Doo dopo poche puntate, perché “Troppo violento”. Ma, per un bel pezzo della nostra esistenza, niente videogiochi; perché, semplicemente, non esistevano.
Il violentissimo Scooby-Doo.
Avevo undici anni, giugno del 1974, proprio alla fine della quinta elementare, quando con scatoloni di cartone mi sono costruito “un’astronave”, una sorta di precursore di un cabinato (seduto) di Star Wars Atari, a cui non avrei giocato fino al 1985 (come non avrei saputo cosa fosse Guerre Stellari fino al settembre 1977). Mi ci sedevo dentro, avevo pure costruito una cloche e un “pannello di controllo” disegnato coi pennarelli, e sognavo di guerre stellari ancora ben lontane dal venire (ispirato da qualche telefilm di fantascienza di serie B giapponese anni Cinquanta/Sessanta, di quelli che ci rifilavano nelle domeniche d’estate sul nazionale). Avevo anche pensato d’infilarci il televisore portatile in bianco e nero come “schermo”/parabrezza della mia astronave. Ma schermo per proiettarci cosa? Mica avrebbe funzionato con le repliche delle puntate di Joe Petrosino o di Padre Brown; così ho lasciato perdere.
Padre Brown esploratore spaziale.
Quell’estate, come tutte le altre da quando avevo cinque anni nel 1968, siamo andati a Montanera, in provincia di Cuneo, a inseguire come al solito il sogno completamente infondato di mio padre di un’idillica esistenza bucolica. Voglio dire, lui era nato e cresciuto in una zona centrale di Roma, perché amasse e sognasse la campagna sperduta, io proprio non lo so (in realtà, ora che sono adulto, lo so. La campagna, la “vigna del nonno” in Piemonte, gli avevano dato protezione, cibo e sicurezza quando era bambino dopo la recessione del 1929 e agli inizi della guerra). Fino a quell’estate del 1974, non mi era pesato molto vivere per due mesi e mezzo (le altre due restanti settimane d’estate al mare, a Follonica) sperduto tra i campi di granturco. Leggevo, giocavo con Big Jim e le Bruciapista, guardavo la TV dei Ragazzi (finalmente potevo guardarmi “gli spettacoli di marionette elettroniche”, come chiamava la RAI i Thunderbirds e Captain Scarlet, che d’inverno non potevo mai vedere, perché dovevo andare in piscina e in palestra). La grande attrattiva era andare nella vicina “metropoli” (si fa per dire, ma rispetto a Montanera e anche alla mia Asti, tutto era metropoli), Cuneo. Mi ci rifornivo di fumetti e potevo sbavare davanti alle vetrine dei giocattoli di Miroglio, il grande magazzino della via centrale, che oltre all’abbigliamento aveva quello che ricordo come il miglior reparto giocattoli del nord Italia, insieme alla Rinascente a Torino. Era fine luglio, vicino al mio compleanno di agosto, che però ahimè cadeva dopo Ferragosto, quando tutto era chiuso e andava sempre a finire che non mi compravano praticamente mai quello che volevo davvero, perché tanto tutto era chiuso. Avevo imparato a quel punto che nelle visite da Miroglio a luglio dovevo essere ben chiaro ed esprimere i miei interessi ludici in modo particolarmente plateale (noi bambini di inizio ’60/fine ’70 eravamo troppo educati). È stato lì che su uno scaffale l’ho visto, il primo videogioco. Era il Ping-O-Tronic della Zanussi; il cartellino pubblicitario diceva “Grande novità 1974! Il tennis elettronico da attaccare al televisore!”. Mi ricordo anche, però, che il cartellino del prezzo chiariva che sarebbe stato comunque ben al di sopra di ogni possibilità. Ricordo un prezzo assurdo, e per mettere le cose in prospettiva, un giocattolo bello in quegli anni costava mediamente 5-10mila lire. Dall’altra parte dello scaffale, c’era il Vertibird della Mattel, l’elicottero che volava in cerchio, nella scatola blu e rossa della primissima serie, novità assoluta, e costava dodicimila lire. Già quello era carissimo (e io anche un po’ troppo grande per un coso che volava-ma-non-volava-mica-davvero-in-cerchio); e anche se non ricordo il prezzo esatto, quello del Ping-O-Tronic era davvero uno sfacelo. Io ricordo attorno alle centoventimila lire, dieci volte tanto, e in effetti, controllando, pare fosse così. Decisamente inarrivabile. E poi, a dirla tutta, mica capivo bene cosa fosse. Sarebbe stato divertente giocare a tennis sullo schermo? Il ping-pong mi piaceva, quello con il tavolo, racchette e palline, intendo, ma, comunque, bisognava sempre essere in due, e io ero sempre da solo a giocare (mia sorella aveva otto anni più di me, e altro a cui pensare). Così, nel mio ricordo, il Vertibird è chiarissimo (perché’, diciamocela tutta, ero poi già così grande per il Vertibird?) mentre il Ping-O-Tronic è sbiadito. Ma ero comunque incuriosito.
Nulla fino all’anno successivo. Luglio del 1975, avevo finito la prima media, solite due settimane in campeggio a Follonica (GR). Nel baretto del campeggio arriva un gioco nuovo, non è un flipper, non è un calcetto o un tavolo da hockey, si chiama Pong ed è di Atari. Ecco cos’era il Ping-O-Tronic, ma questo sembra meglio, segna il punteggio, il campo da gioco è più definito e attraente. Bisogna essere in due per giocare, chiedo a un bambino più piccolo (avrà avuto nove anni) di giocare con me. Io non tocco la pallina manco una volta, e lo sguardo beffardo di quel ragazzino più piccolo che aveva battuto quello più grande ce l’ho stampato in memoria. Forse mi sarà servito anche quello, d’altronde sono testardo, magari poi coi giochini mi ci sono messo d’impegno anche per quello. Forse ci avrò riprovato una volta o due, ancora con scarsi risultati. Ma era comunque… DIVERTENTE. Era entusiasmante! Giocavo con uno schermo TV! Non ero solo più spettatore passivo, con la TV ci si poteva anche giocare!
Il tarlo del “giochino elettronico = novità di moda, ultimo grido” era stato comunque messo. Del 1975 ricordo solo cocenti delusioni: la Battaglia navale elettronica della Clementoni, che di elettronico non aveva proprio niente, tutto solo elettrico, funzionava come l’Allegro chirurgo, un contatto accendeva la lucina e faceva bip; e il Tennis Elettrico Baravelli, pubblicizzatissimo sulla Bibbia del Giocattolo anni ’60-’70, Topolino, che sembrava un Pong che non aveva bisogno del televisore, e invece altro non era che una schifezzuola elettromeccanica a motore elettrico e lucina. Che poi, per un’altra schifezzuola elettromeccanica a lucina, e manco a motore elettrico, ma a molla (!) ci sono cascato ben dopo, nell’estate del 1979, a quasi sedici anni, quando ho avuto la bella idea di comprarmi quella gran fregatura del Blip della Tomy senza verificare che fosse davvero elettronico.
Estate del 1976, dopo la seconda media. Ricordo una brutta mini-vacanza al mare in Abruzzo, in visita da amici, la prima volta in cui mi sono reso conto dell’esistenza delle sale giochi. Passando davanti a una in passeggiata con le famiglie, il mio amichetto e io abbiamo notato un gioco di sottomarini col periscopio (sapevo più o meno di cosa si trattasse, l’avevo visto due anni prima in un centro commerciale a Innsbruck, in Austria: inserivi una moneta e vedevi passare lucettine a forma di sottomarini, e dovevi “sparargli” quando le inquadravi per fare centro), ma non ci hanno lasciato neanche avvicinarci perché “quello è un postaccio pericoloso”. In effetti ricordo truci “ragazzi grandi” con la cicca in bocca, tavoli da biliardo e una nuvolaccia di fumo. “Le sale giochi sono posti malfamati per poco di buono!” aveva sentenziato la mamma del mio amico, un’insegnante di lettere che mi stava sull’anima come manco quell’arpia della mia prof di matematica delle medie (ed ero discalculico, non diagnosticato dato che all’epoca manco si sapeva cosa fosse, la discalculia).
È durante la mia terza media che un sacco di cose sono cambiate, di colpo. Anzi, alla fine della mia terza media, in primavera/estate del 1977. È cambiata la musica: è esplosa la disco ed è arrivato il punk. È cambiata la moda: ci siamo tagliati i capelli e abbiamo smesso di portare i pantaloni a zampa d’elefante. È arrivato Odeon in TV, su RAI 2, che oltre alle prime tette mostrava le mode giovanili d’oltreoceano, lo skateboard e il frisbee. Noi ragazzi abbiamo cominciato a uscire di più, per andare in skate, per giocare a frisbee, per comprare vestiti e dischi, per andare in discoteca (la prima volta che sono andato in versione light pomeridiana, alla 883, era verso la fine di seconda media, una domenica pomeriggio. Du’ maroni allucinanti. Poi ci sono tornato due anni dopo, esperienza completamente diversa, mi sono divertito un sacco e da allora ci sono tornato regolarmente). E a fine di quell’estate del 1977, qualche settimana prima di cominciare il ginnasio, ho trovato il coraggio e sono entrato in sala giochi per la prima volta. Nella mia città, Asti, ce n’erano due in centro. Una coi tavoli da biliardo e i collaterali ragazzi grandi trucidi, appena intravedibili tra le nuvole di fumo, ma chiaramente tanto presenti quanto terrorizzanti. L’altra, invece, non aveva i biliardi e sembrava avere ragazzi... beh, normali. Era proprio sotto i portici della piazza principale. Ci sono passato due o tre volte, prima di trovare il coraggio di entrarci davvero, mentre intravedevo un intero mondo nuovo. Niente più robacce elettromeccaniche, era tutto elettronico, ma non c’era solo Pong; c’era altro, ma non capivo ancora bene cosa. Ci sono entrato in pieno giorno, saranno state le tre del pomeriggio, c’era un sacco di gente sotto i portici fuori, non mi sarebbe successo niente. Nella prima saletta, calciobalilla, flipper e lui, Pong. Ma era la saletta interna che mi faceva gola, quel “vedo e non vedo” dalle finestre che lasciava presagire orizzonti totalmente nuovi. Nell’angolo, lo vedo. È simile a Pong, ma in verticale, e capisco subito che a questo si può giocare da soli. Breakout di Atari. Capisco che bisogna distruggere il muro là sopra. Al sistema di controllo, lo spinner da ruotare, sono già abituato (beh, si fa per dire). Inserisco le mie cento lire e premo Start, che si illumina. La pallina arriva verso di me e la perdo miseramente. Anche la seconda. Riesco a colpire la terza, e poi ancora, duro per forse quattro o cinque colpi. Ma l’entusiasmo, quello non lo scorderò mai. Avevo giocato “contro il computer”! Per un po’, “avevo vinto!”. Ci ho speso le mille lire che avevo in tasca. E poi sono tornato, il giorno dopo, poi l’altro ancora, fino a fine paghetta, che se non erro era nell’ordine delle cinquemila lire al mese, poco da scialare. Ricordo di aver giocato anche a Sprint di Atari e Sea Wolf, ma il mio preferito restava Breakout. Era come quando ero piccolo e papà mi faceva mettere in piedi su una sedia per giocare a flipper con lui, solo che era meglio.
La grande novità di quel Natale del 1977 erano “i giochi elettronici”. Pong era arrivato in casa, in formati molto più economici, mille e uno cloni diversi di Pong da attaccare al televisore di casa, con le varianti che avevamo già visto nei bar (Ultra Pong, Pong Doubles, ecc.). Ce n’erano un sacco, nei negozi, comparsi come funghi, anche in vendita per posta su Topolino, a prezzi contenuti, dalle diciannovemila alle cinquantamila lire, in genere. Io ero ancora indeciso tra uno skateboard nuovo (il mio Gioca era un giocattolo e avevo già quattordici anni, dopo tutto) e uno di quei Pong, ma quale? Un conoscente dei miei che ci aveva invitato a cena era un rivenditore Philips. Aveva il catalogo Philips di quel Natale. C’era il Pong che avevo già visto in pubblicità, davvero niente di speciale e pure caro; ma tra le novità c’era qualcosa che non avevo mai visto prima. Si chiamava Odyssey 2100 e non era solo Pong, era molto di più`! Oltre al solito pong/hockey e varianti, aveva anche il gioco del flipper, e quello che chiaramente era Breakout, anche se in orizzontale. Il gioco non finiva ai dieci punti, si poteva fare il punteggio record (hi-score sarebbe arrivato parecchio dopo, anche per un anglofilo-ancora-poco-anglofono come me), andare avanti, potenzialmente all’infinito! Oh, le esagerazioni della mente dei quattordicenni, così stupendamente naif. Il concetto comunque era che avrei potuto esercitarmi, diventare davvero bravo, e poi magari riuscire a fare bella figura in sala giochi.
Ah, lo skateboard bello, un Life in legno con le ruote con battistrada, me lo regalò poi mia sorella con il suo primo stipendio a marzo 1978 (grazie, sister).
Quel Natale non ho mica ricevuto l’Odyssey, ma un ben meno caro (ma dignitoso, grazie papà-mammà) Tele-Partner a dieci giochi. Non mi ricordo il prezzo dell’Odyssey, ma mi pare intorno alle settantamila lire, mentre il Tele-Partner era sulle quarantamila. Nella caccia per i regali di Natale nascosti in camera dei miei (come d’abitudine), l’avevo trovato in un angolo dell’armadio. Non sapevo ancora che la scatola dei Tele-Partner era generica per tutti i diversi modelli, e avevo intravisto sulla scatola un gioco simile a Motocross Atari, con un’auto (invece di una moto) che doveva saltare i barili. Il me stesso quattordicenne l’aveva descritto al migliore amico (quindici anni) e al suo fratellino (dodici) in questo modo: “Puoi guidare un’auto sull’INTERO SCHERMO del televisore!”. Non so bene cosa ci trovassi di tanto entusiasmante, ma penso che per noi bambini dei tempi, l’avere un qualche tipo di controllo sull’oggetto magico/feticcio che era la TV dovesse essere di grande impatto. Il mio Pong, invece, era il modello con dieci varianti base del tennis, ma mi è andato bene lo stesso.
Quel settembre, una settimana dopo aver cominciato il liceo, sono entrato nell’”altra” sala giochi, quella “dei trucidi”. Era diventata meno “dei trucidi”, che ora erano relegati insieme ai tavoli da biliardo nella stanza in fondo, sempre fumosa ma meno, mentre avevano ripulito completamente la sala principale, la porta ora sempre aperta, luminosa e non così spaventevole come prima. Proprio accanto all’ingresso c’era una macchina nuova, si chiamava Space Wars. Due astronavi si combattevano nello spazio, con un sole al centro la cui gravità ti risucchiava e bisognava evitare. Ma bisognava essere in due per giocare. Il giorno dopo ci sono tornato con due miei compagni di liceo. Ci siamo divertiti tantissimo e ci siamo tornati quasi ogni giorno per settimane. Uscendo dalla sala giochi, un giorno, ho incontrato il padre (spaccamaroni) di un mio compagno delle medie (spaccamaroni pure lui). “Ma tu vai in quei posti lì?” Adulti che si sentissero in diritto di dirmi cosa avrei dovuto o non dovuto fare (che non fossero i miei genitori) mi stavano sull’anima da almeno quando avevo sette anni. Ho risposto “Si, giochiamo a guerre spaziali”, come un dato di fatto, come fosse la cosa più normale di questo mondo, e me ne sono andato. Noi ragazzi lo sapevamo che le sale giochi erano cambiate, loro ancora no.
Di quanto fossero cambiate non me ne rendevo conto pienamente neppure io, in fondo, fino a un giorno d’inizio estate 1978, quando passando davanti alla sala giochi ho sentito un “Tu-tum-tum-tum-tu” fortissimo. Torno indietro, do un’occhiata dalla porta, e vedo una folla di undici-diciottenni ammassati intorno a un cabinato nuovo. C’è scritto Space Invaders di Taito e non ho mai visto nulla di simile. L’audio, la grafica, tutto è nuovo e diverso. È ancora in bianco e nero, con i fogli di mylar colorati sullo schermo per dare l’illusione di colore, ma non importa, non ho mai visto nulla di tanto entusiasmante. Puoi fermare un’invasione aliena! Capisco subito che non ho speranza di giocare: i ragazzi grandi “prenotano” la loro partita mettendo le monetine da 100 lire in fila sul cabinato, ne avrei almeno dieci prima di me. Mi limito a guardare; e anche il giorno dopo; e anche l’indomani. E passato un mesetto prima che io ci potessi giocare. “I marzianini”, come lo chiamavamo, era il miglior gioco elettronico che avessi mai visto. Ancora in gita scolastica due anni dopo, nel 1980, in un bar vicino all’albergo avevamo trovato “i marzianini”, ancora con la fila di monetine da 100 in “prenotazione”, i miei due compagni videoludici e io e avevamo letteralmente pregato i ragazzi del posto di farci passare, che eravamo in gita e avevamo poco tempo. Erano stati gentili (e avevano anche probabilmente capito che eravamo schiappe e non saremmo durati a lungo. E infatti…). Di fatto, comunque, con l’avvento e il successo di Space Invaders le sale giochi si sono ripulite. Hanno cominciato ad andarci tutti, anche le ragazzine, anche i bambini delle elementari. Certo, nel 1981, dato che ero più grande, mi ricordo che un paio di ragazzi mi avevano avvicinato per chiedermi “se avevo erba da vendere” (la prima volta non ho capito, la seconda si), ma almeno non mi sentivo in pericolo di vita, ecco.
Ad ottobre di quel 1978, con Topolino è arrivato l’allegato che continuavo entusiasticamente ad attendere da quando avevo sei anni, il catalogo Mattel (Mattel Italia aveva aperto quando ero in prima elementare). L’unica differenza è che adesso che ero al liceo facevo finta che me importasse di meno. OK, avevo smesso di giocare con le Bruciapista e Big Jim dall’autunno della terza media, ma i giocattoli mi piacevano sempre e comunque (ancora oggi). E poi, cosa si faceva da adulti se non si giocava? Leggere il giornale tutti i giorni per due ore come faceva mio padre? Du’ maroni. In ogni caso, c’erano due grandi novità, quell’anno, come illustra il certosino lavoro di ricostruzione filologica dei nostri anni Settanta e Ottanta che fa Stengo (e un saluto anche a Doc Manhattan, il cui lavoro è stato anch’esso prezioso come riferimento nella stesura di questo articolo). i robot di Goldrake e company e i primi giochini elettronici portatili. Voglio dire, giochini elettronici che ti potevi mettere in tasca (beh, no, davvero no, erano ancora troppo grandi, si fa per dire) e a cui potevi giocare senza mamma-papà-sorella che frantumassero che dovevano vedere la TV e tu dovevi smetterla di giocare. Del calcio mi importava poco, ma la Corsa Formula 1 (Auto Race) e soprattutto Allarme nello spazio (Space Alert, poi ribrandizzato come Battlestar Galactica) mi facevano parecchia gola. Prezzi relativamente contenuti, sulla trentina di mila lire. Il calcio lo prese subito un mio compagno di liceo. Nel 1979 cominciarono a girare anche i giochi portatili della Entex, che erano meno cari, ma che trovavo molto limitati (il fratellino del mio migliore amico aveva ricevuto Space Battle per Natale); e i cloni. Nella primavera avevo trovato un clone di Hong Kong di Auto Race della Tommy, che costava quindicimila lire di meno di quello Mattel, e sembrava identico. Il mio primo portatile Mattel è arrivato per Natale 1979, era Armor Battle, che ho e funziona ancora.
Il grosso problema, specie per un sedicenne come me, è che questi giochini erano limitati. Pong e i suoi cloni erano limitati; i giochini portatili erano limitati, bastava poco per capire lo schema di movimento e batterli, erano sempre a tempo, non a high-score (per conservare le batterie?) e dopo pochi minuti era tutto finito. Non c’era verso di giocare a casa come in sala giochi, non ancora.
Fine estate 1979. Sono annoiatissimo, sto guardando tutti i cartoni giapponesi che passano su ogni canale possibile, e a un certo punto passa la pubblicità di un nuovo gioco elettronico. Non il solito “È nuovo, è diverso, è Bambino!” che poi di diverso aveva davvero poco rispetto ai soliti giochini elettronici portatili. Nonono. Questo si chiama Microvision della MB, è una vera console portatile con giochi intercambiabili, la cartuccia è il frontalino con il coprischermo, ha uno spinner come controller e dei tasti che cambiano da gioco a gioco. Intravedo una bella versione di Breakout e un gioco del Bowling… potessi, correrei a comprarlo. Non arriva nei negozi fino all’autunno e costa un mezzo schioppo pure questo, mi ricordo oltre duecentomila lire. Nel negozio in centro, intravedo anche un ben più accessibile clone di Breakout portatile della Entex a quarantanovemila, ma quando torno la settimana successiva, dopo aver recuperato i soldini, non c’è più, né sarebbe mai più tornato. Difficile crederci per i meccanismi della distribuzione di oggi, ma allora i giocattoli “di punta” arrivavano in quantità limitate, con i rappresentanti che per far avere ai negozianti i giocattoli “di grido” li obbligavano all’acquisto di quantità ingenti di giocattoli secondari che, come i negozianti sapevano, gli sarebbero rimasti sul groppone. Così il Microvision non l’avrei avuto fino al 1994 (fondo di negozio), mentre il Blast It della Entex l’avrei ritrovato che qualche anno fa su Ebay .
Natale 1980. Verso ottobre, in un negozio di elettrodomestici (!) scopro un nuovo gioco elettronico, si chiama Videopac, è della Philips (edizione “Videopac 80”), e funziona a cassette. Ha una tastiera e sembra un computer. Per un quasi diciassettenne nel 1980, l’idea di poter imparare a usare un computer era estremamente attraente. Costava una bella cifra (ricordo centottantamila), ma mi ricordo anche di aver sfruttato a più non posso l’argomento “ma è un computer, imparo a programmare!”. Ci sono riuscito. I primi giochi erano abbastanza risibili, incluso il clone di Space Invaders, Space Monsters, che manco aveva l’hi-score e funzionava invece come i cloni di Pong; ma c’era un gran bel gioco in quella primissima serie, era Cosmic Conflict, ed era il mio preferito. Era un clone di un altro gioco che avevo visto in sala giochi, Star Trek della Cinematronics. Sembrava di essere in Guerre Stellari, nella cabina di un caccia ala TIE, a combattere i caccia X-Wing. Passavano le astronavi sullo schermo e bisognava inquadrarle nel mirino e sparargli coi raggi laser. Era tutto quello che sognavo di mettere nell’abitacolo della mia astronave di cartone quando avevo undici anni, era quella la simulazione di guerra spaziale che mi mancava allora. Era quello che sognavo, e manco ancora sapevo cosa io stessi sognando.
Fine aprile 1981, sono in giro in centro, in un negozio di elettrodomestici vedo uno schermo acceso e una macchina nuova in funzione. Mi avvicino e lancio letteralmente un urlo. È Space Invaders (o, almeno, una versione di Space Invaders) e gira su un coso che si chiama Atari VCS 2600, importato da Melchioni. Ha dei controller “a levetta”, come dicevamo allora, ma che sembrano molto meglio dei joystick del mio Tele-Partner o del Videopac. Questi sono neri con un pulsante arancione, sembrano fantascientifici. Entro per chiedere informazioni, e, come sospettavo, il prezzo è ben fuori dalla portata delle mie tasche: trecentocinquantamila lire (anzi, le classiche 349.000 lire di una volta, che così ti inganniamo, così ti sembra di spendere meno, come con la camicia dell’Upim perennemente a 9.900 lire), con le cassette extra che ne costano una quarantina. Mi danno un cataloghino su cui sbavo copiosamente per giorni, specie sulle cassette di “Programmazione in Basic” e Superman. Ne parlo a scuola, per giorni e giorni. Ho un compagno di di classe danaroso che è un grande fan di Space Invaders e che convince i suoi a comprarlo. Andiamo insieme a prenderlo, e al ritorno a casa suo padre gli fa un cazziatone epocale perché lui non gli aveva “proprio” detto che avrebbe speso quattrocentomila lire (aveva comprato anche un altro gioco, Breakout). Lo attacchiamo alla TV e lui, già pieno di sensi di colpa, comincia a lamentarsi “ma non è uguale al bar! Io lo riporto indietro!”. Ora, io di tecnologia ne capivo ancora poco, ma gli spiego che i componenti del bar sono professionali e che questa era tecnologia da casa e che evidentemente ci si doveva adattare, ma la meccanica del gioco era come al bar (e non era neanche vero, ma vabbè). Si convince a tenerlo dietro promessa che gli avrei comprato altri giochi per prenderlo in prestito per qualche settimana. Il mio Atari VCS non l’avrei avuto che molto tempo dopo, verso la fine di quella generazione di console, e sarebbe stato proprio quello lì, ma non lo sapevo ancora.
Giugno 1982, sto preparando la maturità, sono stressatissimo, al punto che pur di fare una pausa mi guardo pure un po’ di partite dell’Italia, io che il calcio l’ho sempre odiato e che nel 1978 l’unico motivo per cui ero contento che ci fosse il mondiale era perché così potevo andare in skateboard nel bel mezzo di viale Partigiani sotto casa, quando giocava l’Italia, tanto non c’era nessuno in giro. Arriva una pubblicità Mattel (la Mattel, per noi bambini anni dell’epoca, aveva una tale risonanza che non avremmo comunque potuto fare a meno di prestare attenzione) e al terzo fotogramma mi è cascata la mandibola. Era la prima pubblicità di Intellivision, “by Mattel Electronics!”, come ripeteva, trionfante e martellante, il jingle finale. Corro a telefonare al mio migliore amico videogiocatore come me. “Ma l’hai vista anche tu la pubblicità dell’Intellivision? Il calcio ha gli omini con le gambe e braccia che corrono davvero!”. Ora, per voi sarà risibile, ma per noi “gioco del calcio” significava “quadratini più grandi che danno colpi a un quadratino più piccolo su sfondo verde”, mica omini che correvano. E poi c’era Star Strike, gioco in cui sembrava di stare nella sequenza del tunnel di Guerre Stellari.
Sul Videopac, nei miei ultimi due anni di liceo, erano usciti UFO!, clone di Asteroids, e KC Munchkin, clone di Pac-Man, entrambi pregiati, entrambi meglio per molti versi delle versioni Atari. Ho ricordi bellissimi del giocare a UFO! e KC Munchkin ogni sera, mentre mio papà leggeva il giornale, mia mamma preparava la cena, mia sorella parlava al telefono col suo ragazzo, la mia preoccupazione più grossa era l’interrogazione di matematica il giorno dopo e tutto mi sembrava andasse bene. Ci ho anche vinto il mio primo Walkman (un clone Philips), con il Torneo Videopac di Sorrisi e Canzoni TV dell’aprile 1983, in una discoteca della zona (mannaggia a te, Philips, che hai cancellato la promessa finale). Ma il Videopac e i suoi giochi erano comunque molto limitati.
Insomma, Intellivision doveva essere mio. È arrivato nei negozi in tarda estate, visto la prima volta in vacanza post-maturità coi miei compagni a Follonica, ovviamente costava il solito botto, 349.000 lire. A settembre di quel 1982 (il 12, ce l’ho stampato in memoria, oltre che segnato sulla mia agenda di allora) ho convinto mammà-papà-sorella a farmene gentile cadeau, unendo premio per l’esame di maturità al mio diciannovesimo compleanno. Siamo andati a Torino. L’anno prima, il ragazzo di mia sorella mi aveva detto che aveva aperto un nuovo negozio che vendeva solo “giochini elettronici”, vicino a Porta Nuova, in via Carlo Alberto. Era Play Game, che era stato aperto da una coppia gentilissima e che se ne intendeva parecchio. Ci ero passato un paio di volte e avevano giochi per Atari anche importati dagli USA, e tastiere per giocare a scacchi computerizzate. Ma purtroppo… Purtroppo, mentre ero lì per comprare Intellivision con l’inutile Black Jack/Royal Dealer che chissà perché ci avevano infilato dentro, e Space Armada, clone di Space Invaders, la gentilissima proprietaria aveva avuto la bella idea di passarmi un cataloghino, spiegandomi che erano andati al salone dell’elettronica in USA quell’estate, e che sì, Intellivision era bello, “ma guarda cosa sta per arrivare!” Era il primissimo cataloghino del Colecovision. Altro che mandibola per terra, altro che strabuzzamento di occhi. Arrivato alle pagine di Ladybug, Pepper II e Venture UGUALI AL BAR (che poi non lo erano, ma io mica ancora lo sapevo!), come cappero facevo a portarmi a casa l’Intellivision ed esser contento di averlo??? Quando stava per uscire quella roba lì, che io volevo adesso, e invece chissà quando sarebbe arrivata da noi? Che poi ovviamente dopo due ore a casa ero contentissimo di averlo preso, l’Intellivision (anche se mia mamma non vedeva nessuna differenza tra Space Armada e il brutto clone di Space Invaders senza high-score del Videopac; io sì, ed era tutto quel che m’importava), ma il tarlo del Colecovision mi aveva comunque preso e non mi avrebbe abbandonato. Nell’agosto 1983, per il mio compleanno, i miei amici mi hanno regalato BurgerTime per Intellivision, che per me ancora oggi è il gioco migliore e la migliore conversione dell’arcade, la più giocabile. E il Colecovision non sarebbe arrivato in Italia che il Natale successivo, in versione CBS e a quasi mezzo milione di lire.
Giocare a casa. Come al Bar. Giocare a casa come al bar!
Ottobre 1982, ho cominciato l’università. Ho clamorosamente sbagliato indirizzo (giurisprudenza, liberamente spinto dai miei) ma sono testardo (l’ho già detto, no?) quindi per altri tre anni continuerò a fare finta di niente. Tra la musica Dark/New Wave, comprare ameni vestiti neri da ameni posticini chiamati Inferno e Suicidio, e i giochini elettronici, riesco tranquillamente a distogliere la mia attenzione (e/o a rilassarmi. Evviva le cose belle della vita, no?). In edicola vedo una rivista americana (compro fumetti e riviste americane da quando ero in prima media, per “migliorare l’inglese”), si chiama Electronic Games. La divoro, leggo e rileggo. Vedo cose di cui noi umani peninsulari italiani ignoravamo l’esistenza: Bally Astrocade, Atari 5200, Intellivision II, modulo di sintesi vocale per Videopac, che là si chiamava Odyssey 2. Console, accessori e giochi che noi non avevamo, né avremmo mai visto. Due settimane dopo, in edicola ci trovo Videogiochi della Jackson. Letto e riletto pure quello. È anche la prima volta in cui associo l’essermi reso conto di aver sbagliato clamorosamente percorso universitario con i videogiochi come esorcismo dello stress e balsamo per l’anima, perché delle lezioni di quel giorno ricordo solo il fastidio della voce stridula dall’altoparlante del prof di Diritto Romano in aula magna, che mi distraeva dalla lettura di quel primo numero di Videogiochi.
Ho poi cambiato facoltà, per passare a Lettere – Indirizzo di Civiltà Medievale, ma ci sarebbe voluto ancora un pezzo (e un paio di crisi importanti).
Le sale giochi non erano più luoghi trucidi, ma in città (la situazione era diversa nei posti di villeggiatura) c’erano ancora sale giochi in cui entrando mi sentivo a disagio. La differenza è che ora avevo 20-21 anni, e anche se non ero enorme, non sarei stato preso di mira. Le cose sono totalmente cambiate nella primavera del 1984. A Torino, dove frequentavo l’università, si vociferava di una nuova sala giochi che avrebbe aperto presto in centro, degli stessi proprietari di quella vicino alla stazione di Porta Nuova, che non era trucidissima, ma neanche ‘sto granché. Questa nuova, si diceva, sarebbe stata molto diversa. PlayTime ha aperto in pieno centro in piazza CLN a Torino nell’aprile del 1984. Tre piani (due più un tramezzo, a dire il vero) di fantascienza tecnologico-industriale, pulitissima, ben frequentata da bambini, ragazzini, ragazzi e adulti, con il meglio dei giochi arcade di quell’epoca. Era stata anche presentata su Videogiochi Jackson come tra le migliori in Italia, secondo me di certo tra quelle che avevo visto, insieme all’Astra a Milano. Complice la crisi universitaria, al PlayTime ci sono andato per cinque giorni alla settimana per i tre anni successivi. Ero magrissimo, a quell’epoca, perché invece di andare in mensa, mangiavo un panino al bar per tenermi il resto per giocare. Ero diventato abbastanza bravo, nel frattempo. Ci ho battuto l’hi-score a Xevious, ci ho giocato per la prima volta a I, Robot di Atari, ci ho finito per la prima volta Dragon’s Lair con lo schermo doppio e una piccola folla che guardava il mio (mini, inutile, ma comunque sempre) trionfo. Dragon’s Lair, il primissimo, l’avevo visto all’Impera, un bar e sala da biliardo poco distante in centro a Torino, dove l’intera popolazione studentesca torinese andava a bigiare (tagliare scuola, come si dice in Piemonte) almeno una volta nella vita: un baretto microscopico di sopra, una sala giochi/flipper/biliardo enorme al piano sotto. Era l’ottobre 1983, ho speso un capitale morendo subito miseramente, costava 500 lire a partita, ma non sembrava vero di giocare con un vero e proprio cartone animato (cosa che avevo già detto nell’estate del 1982, giocando per la prima volta a Donkey Kong, ma questo era molto meglio). Solo due settimane dopo sono riuscito a giocarci come si deve, ma perché’ nel frattempo in edicola avevo trovato la rivista americana Joystik (scritto proprio così) che aveva pubblicato la guida, chiarendo che non si controllava “tutto”, ma che bisognava invece fare la mossa giusta al momento giusto.
Il Colecovision non l’ho avuto fino all’estate 1984, quando ho venduto la mia Vespa Primavera (tanto avevo già la patente da un pezzo). Era sceso parecchio di prezzo, quasi la metà, e non avevo ancora capito perché. Un altro negoziante, qualche settimana dopo, mi aveva parlato della crisi del mercato dei videogiochi da casa, e io non ci volevo credere. Mi pareva impossibile. Intanto, anche se non erano ancora perfettamente uguali al bar dal punto di vista della grafica (e, OK, anche del sonoro; e non c’erano le scene di intermezzo), con il Colecovision potevo giocare a casa a Venture, Pepper II e Ladybug, e poi fare bella figura in sala giochi. Almeno le meccaniche di gioco erano uguali. Beh, insomma, quasi. Anche in questo senso, ci sarebbero voluti ancora parecchi anni, per “giocare a casa come al bar”.
Avevo tenuto Intellivision, e a novembre del 1984 ho comprato l’ECS, la tastiera computer, modulo aggiuntivo. Non era assolutamente il modulo computer fighissimo che ci era stato promesso al lancio di Intellivision, ma vabbè, si era capito che tanto quello sarebbe venuto a costare oltre una milionata e il progetto era stato cannato in favore del molto meno costoso e più limitato ECS. Ho venduto il Videopac, altrimenti non ce l’avrei fatta, l’ECS costava quanto un Intellivision; ma volevo imparare a tutti i costi “a programmare in Basic (parole che sembravano quasi una formula magica, a noi dell’epoca) e soprattutto programmarmi i miei giochi. Di giochini ne ho programmati anche due, dopo settimane e settimane a capire il Basic e la funzione GO TO, che mi sfuggiva. Il grosso problema è che l’ECS aveva sì ottime caratteristiche (specie la funzione CALL GRAB, che permetteva di “prendere a prestito” gli sprite dalle cassette per utilizzarli nei tuoi giochi), ma aveva solo 2k di memoria, davvero pochissimi. L’espansione di memoria non è mai uscita, come non è mai uscito Game Factory, che doveva essere un gioco per creare giochi.
La crisi dei videogiochi da casa era arrivata davvero.
L’Intellivision con tastiera ECS.
Succedono cose nella mia vita, tristi, importanti. Nell’aprile 1985, mia madre, anche per sopperire a quel che era successo (e di cui non sto ora a tediarvi, ma immaginate), mi compra il Commodore 64. Tanto ormai anche Videogiochi aveva smesso di uscire in edicola, e le riviste si erano trasformate, erano tutte per gli “Home Computer”. Mi ci sono divertito, col C64, sì, ma, ma, ma. A parte i giochi Atari per C64, la differenza di qualità a livello di giocabilità rispetto alle console, per me, è per lo più enorme. Avevo venduto la tastiera ECS e ho scambiato Intellivision con Atari 2600 col mio compagno di liceo, tanto ormai i giochi belli me li tiravano dietro per qualche migliaio di lire. Compro subito Centipede, Vanguard e Ms. PacMan, e con gli amici sentenzio che anche se Centipede ha una grafica cubettosa, è molto più divertente da giocare che qualsiasi gioco avessi su C64. Esageravo? Forse, come sanno fare tutti i ventenni e dintorni. Su C64 ho bei ricordi di Crazy Comets, pregiato clone dell’arcade Mad Planets, di Shoot’em Up Construction Kit e di Little Computer People di Activision. Intanto sbavavo su MSX, che aveva i giochi su cartuccia della Hal Laboratories, che non sembravano niente male, e poi quelli di Konami.
E poi, e poi, e poi. Un giorno d’autunno 1985, un amico mi passa Alter Ego, su dischetto. Alter Ego permetteva di vivere una vita alternativa dalla nascita alla morte. Io ero lì a farmi pipponi mentali indicibili sul senso della vita e quello della morte, e mi arriva ‘sto giochino, stato dell’arte perché non era solo testuale, aveva anche una novità, icone grafiche, e mi fa vivere vite alternative. Ma era tutto in inglese, e io, come tutti i ragazzi fine anni ’70-metà ‘80 pensavo di sapere bene l’inglese, ma non era affatto così. Per due mesi ci ho giocato ogni giorno, con il dizionarione Garzanti Inglese-Italiano Italiano-Inglese sulle ginocchia. Ogni fottuto giorno che ha esorcizzato il male di vivere. Mio padre era morto di cancro, non sapevo cosa fare nella vita, ma in due mesi ho vissuto mille e una vita alternative, in cui avevo ad esempio scelto di continuare a giocare in casa da solo, invece di aiutare papà in giardino (come avevo fatto davvero mille e una volta), oppure no. Non è cambiato niente, se non il capire che forse le scelte che avevo fatto le avrei rifatte, comunque, nella vita vera. Qualche giorno dopo, ho ripreso in mano un romanzo inglese che avevo comprato alla libreria internazionale sei mesi prima, e che avevo abbandonato alla terza pagina perché non ci capivo niente. Adesso, invece, riuscivo a leggerlo. Magari non capivo tutto, ma riuscivo comunque a proseguire nella lettura, dando un significato plausibile alle parole che non conoscevo dal contesto, limitandomi poi a cercare sul dizionario quelle su cui proprio mi arenavo. Ancora non potevo rendermi conto di quanto quest’esperienza avrebbe influenzato la mia professione futura, molti anni dopo.
1986. Ho fatto un altro mare di cavolate, come si fa intorno ai vent’anni, ma una cosa giusta l’ho fatta: sono passato a Lettere. Do esami, sono contento. Mia mamma, che con gli occhi pieni di lacrime aveva accolto il mio “io passo a Lettere” al grido di “ma con Lettere che cosa ci faaaiiiiii?”, ha pure smesso di rompermi, sarà che mi vede contento (una gran bella novità, deduco, per uno che è Dark nerovestito ad ascoltare musica deprimente dal 1982 in poi). Vado in sala giochi, ma del C64 mi sono proprio rotto. È ottobre, compro l’ultimo numero di Computer + Video Games (o C+VG, come la chiamavamo. Ottobre 1986, numero 60, p. 8), rivista inglese, e ci trovo la menzione di nuove console da videogiochi, il Sega Master System, l’Atari 7800 e un certo Nintendo NES. Vado in fibrillazione, perché quelli sono i giochi che mi piacciono, non quelli da computer. Nel numero di dicembre c’è un allegato di qualche pagina, un cataloghino Nintendo, spiega cos’è il NES, ROB e la Zapper. Voglio, voglio, voglio. Ma da noi quando arriverà? A ottobre, mentre sono in un pub con gli amici, vedo passare su una TV privata anche la prima pubblicità del Sega Master System. Mi sembra pregevole, in particolare Hang-On, anche se non sembra uguale al bar. Invece i giochi del NES come Popeye uguali al bar lo sembrano, eccome. Il 20 novembre 1986, a me e a tutti quelli che erano abbonati alla defunta Videogiochi Jackson (io lo ero solo perché’ avevo vinto le semifinali dell’Imagic Match, ma questa è un’altra storia), arriva una lettera in cui la NBC Italia annuncia l’importazione del Sega Master System. C’era anche il buono d’ordine, console sulle solite 349.000 e giochi sulle solite 40.000. La lettera l’ho tenuta, il buono no. Mi ero stufato dei limiti del C64, non ne potevo davvero più. Avevo comprato Slap Fight per C64 e tutto fiero l’avevo fatto vedere a un amico che amava anche lui il gioco da bar, ma se ne intendeva poco di computer, e lui “ma perché non è uguale al bar?” Eh, vaglielo a spiegare. E soprattutto, davvero, perché era già il 1986 e i giochi non erano ancora uguali al bar?
Aprile 1987, da Play Game a Torino, la sempre gentilissima coppia di proprietari originali mi presenta Roy, che subentrerà come nuovo proprietario. Si parla di NES, gli è appena arrivato, lo attaccano alla TV. Che la versione Deluxe fosse venduta con Super Mario Bros. o non lo sapevo o non ci avevo fatto caso. Il NES è la versione World of Wonders (uno dei marchi Mattel in Italia, ma in USA azienda di giocattoli separata. Ho riflettuto poi sul fatto che, dopo il crash dei videogiochi da casa del 1984, la Mattel Italia esitava a lanciare un nuovo prodotto sul mercato associandolo al proprio marchio). Come scopriremo dopo, quella versione gira a velocità piena e schermo pieno, perché è la versione USA modificata per uscire in PAL. Mettono Super Mario Bros. e accendono, e a me, tanto per cambiare, casca la mandibola per terra. È. Uguale. Al. Bar. È il gioco da bar! (Poco sapevo all’epoca che la versione da bar era in realtà quella da casa, e che il cabinato PlayChoice 10 era un escamotage per convincere la gente a comprarsi il NES, ma tant’è). La proprietaria uscente si mette a raccontare di un cliente, un ragazzo a cui il padre, in viaggio d’affari in Giappone, aveva portato un Nintendo giapponese, e anche il lettore di dischetti, che in Giappone c’era; e si mette a raccontare di questo nuovo gioco famosissimo in Giappone, che si chiama Zelda, disponibile solo su dischetto. Il proprietario entrante la interrompe, sprezzante, “ma figurati se è vero, figurati se ci sono giochi su floppy per il Nintendo, tutte balle, io le console le vendo!”. Oggi, mentre rimiro il mio Famicom Disk System e dischetto floppy di Zelda, in verità, in verità ti dico “Roy, mi dispiace, ma aveva ragione lei, era tutto vero”.
Cosa fa un ventiquattrenne adulto e responsabile per mettere le mani su un Nintendo NES Deluxe Version nel tardo aprile del 1987? Ma vende la sterlina d’oro che la nonna gli aveva regalato per il battesimo, chiaro, no? Le 500.000 lire meglio spese di quell’epoca, anche se ancora adesso ricordo la fifa nel tornare alla mia residenza universitaria con quel malloppo per mano: temevo mi derubassero, me l’ero fatto incartare in carta di giornale. Della sterlina d’oro non me ne sarei fatto niente, dubito che sarebbe salita molto di prezzo, ma il NES mi ha dato cinque anni buoni di felicità videoludica.
Quell’estate ho preso anche il Sega Master System in un ipermercato della mia zona, era la versione NBC in super svendita. Out Run e Space Harrier, comprati da Miroglio ad Alba, non erano uguali al bar, ma era comunque un gran bel giocare. A ottobre esce Xevious per NES, e mi rendo ahimè conto che manco i giochi su NES erano uguali al bar, nonostante tutto. Sega in Italia non sarebbe stata importata ufficialmente che nel 1991, da Giochi Preziosi.
Giochi uguali al bar, io volevo giochi uguali al bar. Nell’aprile del 1988 arriva un barlume di speranza (beh, più che barlume era stato un bel fulmine a ciel sereno). C+VG pubblica un servizio su una nuova console lanciata in Giappone nel novembre passato, si chiama PC Engine della NEC, è bianca e grande come un pacchetto di Fonzie e, soprattutto, fa girare un R-Type che sembra proprio quello del bar. Anche questo non sarà uguale al bar, anche se ci avvicinava moltissimo.
Non è stato con il Megadrive nel 1991, né col PC Engine Core Grafx II qualche mese dopo, né col il Super NES d’importazione dagli USA nella primavera del 1992 che sono arrivato ad avere i “giochi uguali al bar”. Ci è voluto ancora parecchio. La prima volta che l’abbiamo davvero detto convinti è stato con House of the Dead II su Dreamcast verso l’autunno del 1999 (e, sorpresa! Neanche questo era proprio uguale al bar). Di fatto, però, abbiamo smesso di andare in sala giochi. A casa c’erano giochi come al bar, e in alcuni casi meglio che al bar. La sala giochi in casa l’ho avuta per la prima volta, davvero, con il MAME, l’emulatore di giochi da bar per Mac e PC, proprio intorno a quel periodo, e poi in tasca con il Nokia N-Gage, il primo portatile che faceva girare il MAME, verso la fine del 2003. L’ultima volta che ho messo piede in sala giochi è stata al centro commerciale a Hartford, in Connecticut, intorno al 2001. Questo prima che aprisse Up & Down, una catena di pub sale giochi qui in USA che ha aperto una filiale vicino a casa mia a St. Louis, tre anni fa. Come allora, cambio le mie banconote in manciate di gettoni e vado a giocare a Crystal Castle, Zaxxon, Galaga e Centipede. Come allora, ci sono tanti ragazzi insieme a me; solo che hanno tutti più o meno la mia età, il che vuol dire che siamo tutti tra la fine dei quaranta e la fine dei cinquanta. Mi piace pensare che negli occhi abbiamo lo stesso entusiasmo dei nostri quindici/vent’anni, mica solo la nostalgia. Ci sono anche tanti ragazzi “veri”, che provano i giochi “vintage”, che fa figo, ma che per lo più si assiepano intorno al Killer Queen a dieci giocatori. Sarà, ma a me pare una versione di Joust manco molto interessante.
Mi chiamo Simone, ho quasi sessant’anni, gioco ai videogiochi da quando ne avevo dodici, continuano a piacermi, e non smetterò mai.
P.S.
Le Bruciapista, poi brevemente Flyin’ Colors, dal 1978 si chiamano Hot Wheels anche in Italia.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata agli anni Settanta, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.