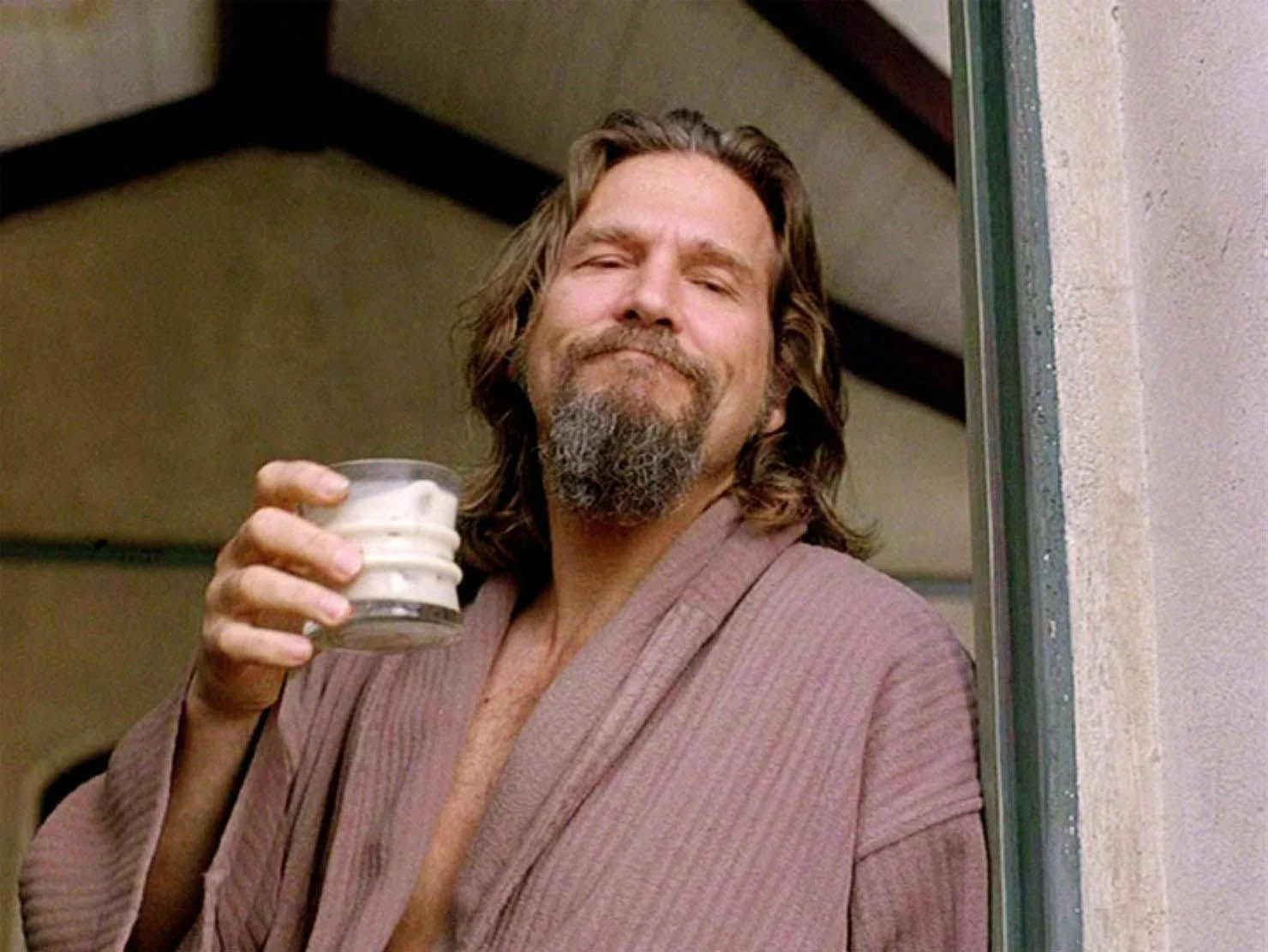Bianco, Rosso e Verdone ormai mi regala più malinconia che risate
Qualche settimana fa, complice il fatto che il primo film di Fantozzi ha compiuto cinquant’anni, una mia collega mi ha chiesto cosa mai potessi trovarci di divertente in un film del genere.
Le risposi che Fantozzi, al netto delle risate che mi ha fatto fare innumerevoli volte quand’ero bambino, è in realtà un film drammatico travestito da commedia.
La maschera portata in scena da Paolo Villaggio, infatti, è il ritratto dell’uomo medio borghese di quel periodo, marchiato da una mediocrità che non si sarebbe mai scrollato di dosso: servile nei confronti dei potenti che lo umiliano costantemente, deriso dai colleghi e intrappolato in una famiglia che palesemente non ama, con una moglie e una figlia che per lui sono fonte di imbarazzo. L’immagine di un uomo infelice. Che poi avesse il tanto agognato posto fisso o la casa di proprietà, non è che lo rendesse meno infelice rispetto all’uomo moderno.
Lo stesso tipo di malinconia, seppur in modo diverso, continuo a vederla in Bianco, Rosso e Verdone.
La pellicola scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone è diventata celebre grazie ai personaggi portati in scena dal regista e attore romano con maestria, evidenziandone debolezze e tic, con dei dialoghi che sono entrati da decenni nell’immaginario popolare.
Il film racconta il viaggio di tre personaggi, tutti estremamente diversi da loro, che devono raggiungere il proprio seggio elettorale per votare.
Pasquale Amitrano, emigrato da molti anni in Germania e sposato con una donna tedesca che si prende cura di lui quasi come una madre, si mette in viaggio da Monaco di Baviera per raggiungere la natia Matera. Durante il viaggio, che compie in completa solitudine e senza dire una parola, il povero Pasquale vedrà la propria auto, un’Alfa Sud rossa, letteralmente sventrata: chi gli ruba il mangianastri, chi le borchie, chi il sedile. E arriverà persino ad essere malmenato.
Mimmo, che praticamente è un bambino dentro il corpo di un adulto, si reca in Veneto per portare la nonna (interpretata da una ruspante Elena Fabrizi, bravissima a portare in scena la tipica nonna italiana, burbera ma dal cuore d’oro, affettuosamente legata al nipote) a Roma per votare. Un viaggio in cui il rapporto fra i due verrà messo alla prova da diversi battibecchi ma in grado di evidenziare quanto fosse forte il legame fra nonna e nipote.
Furio Zoccano è un petulante, logorroico e pignolo funzionario pubblico che si mette in viaggio da Torino verso Roma insieme alla moglie Magda e ai due figli piccoli, dai nomi improbabili: Antonluca e Antongiulio. Le nevrosi di Furio hanno messo per lungo tempo alla prova Magda, ormai logorata da anni insieme a lui, che deciderà di mettere fine a un matrimonio che per lei è ormai un incubo.
Bianco Rosso e Verdone ha saputo regalarmi, durante le visioni lungo il corso di questi anni, molteplici risate: dai siparietti fra Mimmo e “Er Principe”, sublime personaggio interpretato da Mario Brega, impegnato a fare un’iniezione alla nonna - 'Sta mano po' esse fero e po' esse piuma: oggi è stata 'na piuma - fino al personaggio di Furio, diventato un vero e proprio meme vivente, fra telefonate all’ACI, la carta carburante, i sandwich al prosciutto (con il prosciutto di Luciano al posto di quello di Gino) passando per quel Pasquale Amitrano che deve “rifarsi la foto perché peggiorato”.
Così com’è stato per Fantozzi, crescendo, anzi invecchiando, mi sono reso conto di quanto Bianco, Rosso e Verdone sia – seppur in maniera minore rispetto alla pellicola di Luciano Salce – un film malinconico, e in certe situazioni persino drammatico.
Mimmo, così come lo era il suo “predecessore” Leo in Un Sacco Bello, è un ragazzo profondamente solo, in forte difficoltà nei rapporti con le donne, cosa che si evince nella scena dell’Autogrill, in cui la nonna tenta di “accasarlo” con una ragazza russa, e meglio ancora lo si capisce quando, verso la fine del film, lui e la nonna si fermano in un hotel per la notte e Mimmo viene abbordato da una prostituta. Il viaggio di Mimmo e della nonna è senz’altro l’episodio di drammatico del film: la scena in cui si trovano al cimitero per portare i fiori a un conoscente della nonna si trasforma in un concentrato di malinconia, nel vedere quante persone giovani abbiano perso la vita precocemente e nel sentire la richiesta della nonna nei confronti del nipote, cui promette in eredità un casale fatiscente situato a Palestrina in cambio di una bella tomba. Perché “tu sei giovane ma io so anziana e ce devo pensà”. Una scena di una tristezza infinita, che ci ricorda che presto o tardi le nostre vite avranno un termine. Il culmine della tristezza sarà raggiunto nel finale, quando la nonna morirà nella cabina elettorale, nell’indifferenza generale, senza che nonna e nipote abbiano avuto occasione di fare pace dopo l’ennesimo futile litigio.
Magda, moglie del petulante Furio, non se la passa certamente meglio, anzi. Quello che per noi spettatori è un personaggio esilarante e macchiettistico (una sorta di precursore del più moderno Sheldon Cooper), per la sua consorte è un vero e proprio incubo. Oltre al fatto che vivere ogni giorno accanto ad un personaggio tremendamente irritante come Furio l’ha portata a un vero e proprio esaurimento nervoso, con relativa assunzione di farmaci, Magda ha uno sguardo perennemente malinconico e infelice. Al di là delle sue ansie e nevrosi, Furio non mostra mai un minimo segno di affetto nei confronti della moglie, che rimprovera costantemente – seppur in maniera bonaria – per inezie quali la famigerata carta carburante, e sulla quale esercita una sorta di pressione psicologica spingendola a votare per chi vuole lui. Mi stupisco che nessuno oggi abbia ancora additato il personaggio di Furio come simbolo del patriarcato. Comunque, Magda alla fine deciderà di mettere fine alla propria infelicità abbandonando la famiglia per fuggire con l’aitante playboy Raoul. E se abbandonare due figli piccoli può sembrare disdicevole, la scelta deriva probabilmente dal fatto che Magda aveva intuito che Antongiulio e Antonluca sarebbero diventati come il padre, dato che durante il viaggio si sono dimostrati sempre più vicini al padre che alla madre: dal binocolo preso da Antongiulio al posto della madre che se n’era dimenticata, con relativo elogio di Furio al figlio e “bacchettata” a Magda, alla complicità dei figli nei confronti del padre, che assecondano in tutto.
Anche il personaggio di Pasquale Amitrano, nonostante sia quello più debole e meno caratterizzato dei tre, nasconde una profonda malinconia di fondo: a Pasquale manca molto l’Italia, e, rientrato in patria seppur solamente per tre giorni, vede il proprio paese d’origine profondamente cambiato. Derubato, maltrattato e malmenato, alla fine del film si sfogherà in un incomprensibile monologo in basilicato stretto, con tanto di insulto finale.
Nonostante Bianco, Rosso e Verdone sia una delle mie commedie preferite, ogni volta che mi capita di guardarlo non posso che provare una sorta di profonda malinconia. Al di là del fatto che il film racconta un’Italia che non c’è più, i personaggi portati in scena da Carlo Verdone sono intrisi di solitudine e tristezza, anche se in alcuni casi poco percettibile. Sarà anche che l’età adulta ti fa vedere le cose in maniera più realista e consapevole, ma questo film, in un 2025 giunto quasi a metà, ti fa percepire quanto il tempo passi velocemente e quanto, di fronte a determinati avvenimenti come la morte, siamo totalmente impotenti.
La grandezza di questo film, che anche dopo quarantaquattro anni non ha perso lo smalto degli esordi, è la stessa dei primi due Fantozzi: quella di raccontare sotto forma di commedia le amarezze della vita.
Se è vero che, in fondo, siamo tutti un po' Fantozzi, siamo anche, chi più chi meno, un po' Mimmo, Furio e Pasquale.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata al colore rosso, che potete trovare riassunta a questo indirizzo qui.