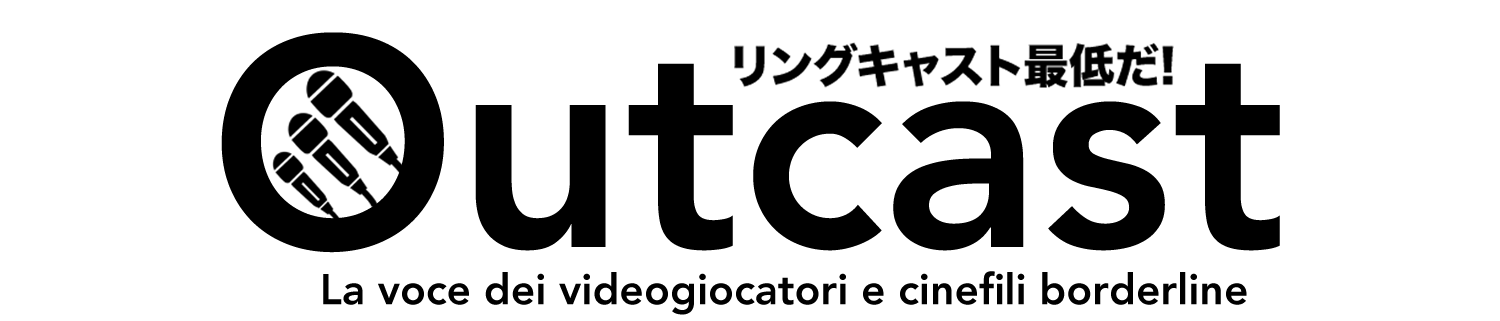Project Zero: sorrisi a denti stretti e scatti fatali tra le rovine della provincia giapponese
Se iniziamo a parlare di survival horror, a tutti verrà in mente la serie di Resident Evil. Qualcuno dirà che Silent Hill è comunque meglio. Inizieremo a dibattere su Alone in the Dark come capostipite del genere (anche se il termine l’ha inventato Capcom) e l’intellettuale del gruppo tirerà fuori Project Zero. Una serie che, nel complesso (uscite regolari, spin-off e remaster), ha venduto meno di 1,5 milioni di copie in tutto il mondo. L’esempio perfetto di orrore videoludico di provincia.
Forse non tutti sanno che, nei piani iniziali, in Resident Evil ci sarebbero dovuti essere i fantasmi al posto degli zombi e che l’azione avrebbe dovuto essere ripresa in prima persona. Ma la conoscenza dell’hardware (PS One) con cui avevano a che fare Shinji Mikami & Co. non permetteva loro di trovare una soluzione soddisfacente. Poi qualcuno ha mostrato in studio Alone in the Dark, e il resto è storia.
Questa storia qua, per la precisione.
Ma è importante aggiungere che l’idea di partenza venne a Tokuro Fujiwara (autore di pietre miliari come Ghosts ‘n Goblins, mica bruscolini), superiore e mentore di Mikami, che gli raccomandò espressamente di prendere a riferimento un piccolo cult pubblicato per Famicom nel 1989: Sweet Home (celebre soprattutto per essere migliore del film a cui era ispirato). In Sweet Home, metroidvania (come lo chiameremmo oggi) con combattimenti a turni, una squadra speciale è inviata a investigare sull’improvvisa scomparsa di un famoso pittore. Intrappolati in una misteriosa villa nel cuore della foresta, i cinque protagonisti possono uscirne vivi solo risolvendo il complesso enigma celato negli affreschi alle pareti. Mentre si dipana la vicenda, e riemergono i cadaveri della squadra investigativa inviata sul posto in precedenza, il fantasma della moglie del pittore e altre figure spettrali cominciano a perseguitare gli investigatori dell’occulto.
Parallelamente, sempre in Giappone, complice in questo caso il boom dei blog online, si stava creando una piccola comunità ben organizzata di esploratori appassionati di siti abbandonati. Un’attività specifica denominata “haikyo” (letteralmente “rovina” - https://haikyo.org/): una sorta di archeologia urbana strutturata in un passatempo con regole e rituali definiti.
Con il senno di poi, fa sorridere il fatto che l’equipaggiamento consigliato dalle guide alla preparazione dell’haikyo riprendesse in maniera pedissequa il campionario di oggetti che avremmo in seguito ritrovato nei nostri giochi preferiti: coltelli multiuso, passe-partout e piedi di porco per scassinare le porte, torce elettriche e accendini, indumenti protettivi, kit di primo soccorso, telefoni cellulari o ricetrasmittenti, binocoli, bussola, repellenti per insetti, ecc. Anche i pericoli che l’esplorazione di luoghi in disuso presenta, così come gli ostacoli da superare, sono materia da survival horror: le guide consigliano di prestare attenzione a pavimenti pericolanti, porte bloccate, cani randagi, sciami di insetti, serpenti, oggetti taglienti e sostanze velenose sparse nell’ambiente. Ovviamente, sarebbe servita anche una fotocamera per testimoniare l’impresa, perché, è bene ricordarlo, stiamo parlando di un’epoca in cui i telefoni non sono ancora così smart…
Bene, fatte queste premesse, è facile comprendere la genesi di Project Zero: gli elementi costitutivi erano già tutti in bella mostra. Più difficile, forse, capire perché, nonostante l’ottima accoglienza da parte della critica, non abbia avuto lo stesso clamoroso successo internazionale delle serie di Capcom e Konami. La saga di Tecmo, va precisato, è mooolto giapponese, e non si vergogna ad esserlo. Anzi, secondo i critici più snob, è proprio questo il vero punto di forza che le permette di raggiungere lo status di cult. Questo e una meccanica inedita nel genere first person shooter: l’uso della fotocamera.
Il gioco più terrificante di sempre
Procediamo con ordine. La saga, che conta cinque uscite principali e diversi spin-off (tra cui un’esperienza interattiva, un gioco mobile e il curioso Spirit Camera per Nintendo 3DS) nasce dall’ossessione per il soprannaturale di Makoto Shibata, game director e sceneggiatore. Insieme al collega Keisuke Kikuchi (con cui aveva lavorato alla grottesca serie puzzle Deception), dopo aver scoperto le potenzialità di PlayStation 2, decide di sviluppare un horror interattivo ispirato alle proprie esperienze spiritiche e all’estetica delle pellicole giapponesi in voga all'epoca (The Ring su tutte). L’obiettivo è quello di creare l'esperienza di gioco più terrificante possibile. Va detto subito che andò meglio al secondo tentativo (Crimson Butterfly, ad oggi è ancora considerato il più riuscito della serie) ma già il debutto mostrava caratteristiche di gameplay capaci di renderlo unico e non derivativo.
Come dicevamo, il gameplay, piuttosto rarefatto, è un mix curioso di walking simulator in terza persona con telecamera fissa e sparattutto tattico in prima. L’unico modo per liberarsi dagli spiriti che infestano la mappa è infatti quello di imprimerli sulla pellicola prima che raggiungano il nostro personaggio (o svaniscano di nuovo tra le pareti) tramite un dispositivo noto come Camera Obscura. Come una vera e propria arma da FPS, la Camera Obscura può essere usata per esorcizzare le creature maligne uno scatto alla volta (più vicina l’inquadratura e lunga la durata, maggiore il danno) e può essere ricaricata con diversi tipi di pellicola.
Una cosa del genere, per capirci.
In varie interviste rilasciate durante la fase promozionale del gioco, Shibata riferì come l’idea di usare una speciale fotocamera gli venne da un aneddoto di infanzia, quando il padre gli regalò una macchina fotografica rotta. Nella fervida immaginazione che si ha durante la pubertà, quella macchina che non poteva fotografare gli umani avrebbe forse potuto riprendere i fantasmi. Shibata bambino aveva troppa paura per sperimentarlo, ma l’idea gli rimase vividamente impressa. Uno strumento del genere, infatti, avrebbe obbligato il giocatore a fissare l’orrore di quei volti spettrali e deformati attraverso il mirino ottico, incrementando così l’intensità di ogni incontro.
Nella mitologia della serie, la Camera Obscura è il lascito più importante di un investigatore dell’occulto vissuto nel XIX secolo: Kunihiko Asou. Grazie alla tecnologia occidentale, Asou inventa alcuni strumenti che gli consentono di mettersi direttamente in contatto con il mondo ultraterreno. Oltre alla fotocamera (presente in tutte le uscite della serie) Asou brevetta una radio spirituale con cui ascoltare i pensieri cristallizzati degli spettri sconfitti e un proiettore che permette di rivedere le immagini di fantasmi catturate sulla pellicola. Nell’articolato worldbuilding della serie, tutte queste invenzioni sono finite in mano ad attenti collezionisti dell’occulto. La Camera Obscura che Miku usa nel primo gioco apparteneva al fratello, che l’aveva ricevuta dalla madre. In Crimson Butterfly, Mio trova un’altra tipologia di Camera Obscura, la stessa che, presumibilmente, finisce nelle mani di Rei Kurosawa in The Tormented, recuperata tra le reliquie del fidanzato morto. E se pensate che sia difficile tenere traccia di come la Camera Obscura sia passata di mano in mano, ancora non avete idea della storia che ruota attorno alla Himuro Mansion…
Tratto da una storia [non] vera
Sebbene Shibata basò l’ambientazione di gioco originale sulle leggende urbane che lo impressionavano da ragazzino, negli USA il marketing non solo cambiò il titolo da Zero a Fatal Frame ma, sulla scia del clamoroso successo di The Blair Witch Project, gli affibbiò anche l’etichetta “basato su una storia vera”. In realtà, per quanto le tristi vicende rese canoniche dal gioco facessero già parte del folclore giapponese, non esistono testimonianze relative alla proprietà degli Himuro (di cui nessuno ha mai conosciuto l’esatta ubicazione) e nemmeno informazioni legali sulla famiglia che lì, per generazioni, aveva presumibilmente compiuto i sanguinari rituali.
Secondo la leggenda urbana, infatti, appena fuori Tokyo, immersa in una rigogliosa foresta, sorgerebbe un’imponente proprietà da lungo abbandonata, appartenente alla famiglia Himuro che, nei secoli, è stata custode di un terribile segreto. La dimora, infatti, sarebbe stata costruita sopra un portale che separa il regno dei vivi da quello degli spiriti. Un varco che, ogni cinquant’anni, deve essere sigillato con un rituale di purificazione per evitare il travaso delle anime maligne nel mondo esterno. Gli Himuro eseguirono il macabro rituale (che prevedeva lo smembramento di una vergine innocente per poi usare le corde intrise del suo sangue come sigillo) con dedizione e circospezione fino agli anni ’80 del secolo scorso, quando qualcosa andò storto e la famiglia si macchiò di uno dei crimini più raccapriccianti mai raccontati della storia giapponese.
Uno dei figli, infatti, visitò la zona proibita della casa, innamorandosi della vittima sacrificale accuratamente prescelta, che così perse la sua purezza. A quel punto, al capofamiglia non restava che una soluzione drastica: passare a filo di katana tutti i presenti, incluso se stesso, per placare la furia degli spiriti. Ma quel varco, purtroppo, rimase aperto, impregnando l’intera area di energia oscura. Per questo la proprietà non è rilevabile con la tecnologia ordinaria ma chiunque sia riuscito a scoprirla e a ritornare vivo riferisce di corde lacerate e resti di cadaveri, schizzi di sangue alle pareti e una visita accompagnata dalle grida delle ragazze innocenti sacrificate nel corso dei secoli. Quelle stesse ragazze che, nelle notti di luna nuova, possono essere osservate mentre passeggiano da sole lungo i confini della proprietà…
Fantasmi in vece degli zombi: e perché no?
Questo, a grandi linee, è ciò che anche la serie di Tecmo ci racconta. Tuttavia, come vuole certa tradizione horror, l’esposizione è frammentaria e non lineare, la dimensione onirica prende spesso il sopravvento sulla cronaca e il tutto è infarcito di numerosi flashback (spesso incomprensibili senza contesto) e boriose annotazioni. Non aiuta poi il fatto che i vari episodi si focalizzino sulle drammatiche vicissitudini personali del cast di personaggi (giocanti e non) e le complicate relazioni intessute lungo la linea temporale - con una pletora di nomi da ricordare per non perdere il filo delle parentele. Ma il template è sempre quello: rituale cannato, spiriti agitati, urge nuovo sacrificio, sia che si esplori una fantomatica magione o un villaggio infestato oppure un’isola intera...
Pent[iment]alogia
In Project Zero (2001), dicevamo, accompagniamo la giovane Miku Hinasaki alla ricerca del fratello disperso, Mafuyu (a sua volta partito per ritrovare l’amico scrittore, misteriosamente scomparso insieme al suo editore e all’assistente, mentre cercava ispirazione per il nuovo libro). L’unica “protezione” di Miku è una torcia elettrica (nelle prime fasi di sviluppo del gioco, proprio la luce avrebbe dovuto uccidere gli spettri!). Esplorando gli angusti locali, Miku troverà la vecchia macchina fotografica della madre, che Mafuyu aveva portato con sé. Ben presto, Miku scoprirà che il fratello è stato rapito dallo spirito di Kirie, a causa dell’incredibile somiglianza con il defunto amante.
Miku ritornerà cinque anni più tardi in Project Zero III: The Tormented (2006), come assistente di Rei Kurosawa, giovane fotografa freelance che perde il fidanzato in un incidente d’auto. La ragazza è tormentata da una serie di incubi e, ad ogni risveglio, un misterioso tatuaggio rituale si espande sul suo corpo. Anche l’assistente e l’amico del fidanzato (Kei Amakura) soffrono dello stesso problema e il trio cerca disperatamente una risposta visitando nei propri sogni la Villa del Sonno. La caratteristica principale del gioco è che, oltre a Rei, in alcuni capitoli si interpretano Kei e Miku, rendendo più vario il gameplay. Mentre Rei è in grado di usare il flash per abbagliare gli spiriti, Miku può rallentarli e Kei può sollevare oggetti pesanti e acquattarsi per nascondersi da alcuni spettri.
Manco a farlo apposta, proprio Kei è lo zio di Mio e Mayu, le sorelle gemelle che incontriamo in Project Zero II: Crimson Butterfly (2003). Quello della “farfalla cremisi” è sicuramente l’episodio più apprezzato dalla critica, merito per lo più di un’estetica raffinata, basata sulla contrapposizione tra lo scenario spento e diafano e gli indizi rosso brillante disseminati dalle farfalle del sottotitolo. Anche la vicenda narrata si muove su binari più accessibili a un pubblico eterogeneo: pone infatti al centro la relazione complicata tra le due sorelle. Mayu, la maggiore, è claudicante per colpa di un incidente provocato da Mio, la minore, che per questo è tormentata dai sensi di colpa. Durante una gita alla foresta in cui passavano tempo da piccole, Mayu si allontana per inseguire una farfalla cremisi, spetta quindi a Mio (controllata dal giocatore) il compito di andarla a recuperare. Le ragazze finiranno disperse in un villaggio maledetto, in cui i fantasmi rivivono costantemente il fallimento del rituale. Per tenere sigillato il portale che conduce all’abisso, infatti, ogni dieci anni una coppia di gemelli deve recarsi al villaggio e quello nato prima deve strangolare il secondo genito, che si trasformerà in una farfalla cremisi.
Il quarto episodio, Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse (2008) è una sorta di prequel realizzato in collaborazione Grasshopper Manufacture (e Nintendo, da quel momento co-proprietaria del brand) che porta la Camera Obscura sull’isola di Rogetsu. Tuttavia, la formula, riadattata per Wiimote e Nunchuck con l’impiego di una telecamera “libera”, comincia a perdere un po’ di smalto; anche la narrazione inizia a scricchiolare, complicandosi con l’aggiunta di troppi personaggi da ricordare e la solita tiritera del rituale che va ripetuto, il tutto condito da una spruzzata di fan service abbastanza fuori luogo.
La novità portata da Project Zero: Maiden of Black Water (2014), sviluppato inizialmente come esclusiva per Wii U, è data dall’impiego del Pad, usato sia come fotocamera per esorcizzare gli spiriti sia come finestra sul mondo di gioco indispensabile per mettere in luce indizi non distinguibili sullo schermo del televisore. Entrambi i titoli sono stati rimasterizzati in tempi recenti anche per formati non Nintendo ma, nel complesso, la saga non è mai riuscita ad evolversi e a sbarazzarsi della sua natura “provinciale”. Soprattutto, passata un po’ la moda del found footage e delle storie di fantasmi giapponesi, l’horror presente nella serie ha smesso di suscitare la stessa fascinazione anche tra i fan più appassionati, tanto in occidente quanto nel Sol Levante.
In effetti il Wii U GamePad si prestava perfettamente alla causa.
La verità è che ogni opera horror è sempre figlia della propria epoca, ne rappresenta metaforicamente ansie e paure. La paura più grande che abbiamo oggi, ossessionati come siamo dalla nostra presenza sui social media, non è certo quella che un fantasma esca dallo schermo, quanto, piuttosto, quella di essere ghostati nelle nostre relazioni online…
E quindi, addio Project Zero… Per un po’ ci hai spaventato come si deve, ma è ora di cambiare schermo, accendere la luce e andare avanti. C’è nessuno online per fare una partita con me?
…
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata agli orrori di provincia e al folk horror, che potete trovare riassunta a questo indirizzo qui.