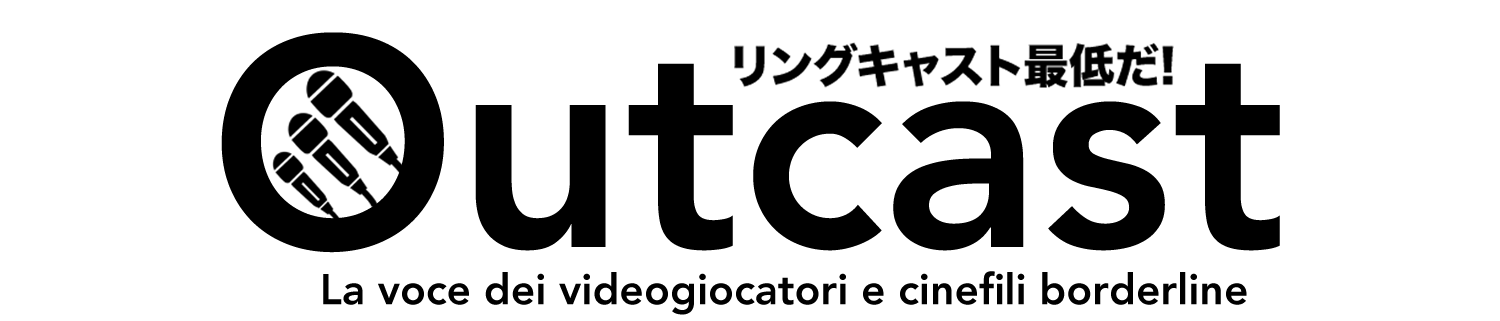Droga, sesso, rock and roll e uccellacci del malaugurio
Chi ha avuto la fortuna di entrare nella stanza di Lewis Finch, ricavata da una barca sospesa in cima a quell’ammasso architettonico sbilenco che è la dimora di What Remains of Edith Finch (qui una riflessione di Vitoiuvara sul gioco), non può non ricordare che amava la psichedelia degli anni Settanta, le canne e tutto ciò che è lisergico e allucinogeno. Ah, e anche i videogiochi (ci sarà una relazione?). Le pareti della sua camera sono tappezzate di poster con foglie di mariuana e mandala dai colori che reagiscono alla luce ultravioletta, su un tavolinetto un narghilè, e un pò dappertutto resti di erba e cenere, oltre a tappi di bottiglia e qualche lattina di birra. Insomma, non si faceva mancare niente. Per cercare di tirarlo fuori da questa dipendenza, la madre pensa bene di trovargli un adorabile lavoretto presso il conservificio dell'isola, dove gli viene assegnato il ruolo di decapitatore di teste ai salmoni. Il lavoro è ripetitivo, alienante, meccanico. Lewis si isola sempre di più e nella sua mente comincia a crearsi una realtà alternativa, che assomiglia tanto ad un videogioco. La cosa non è casuale, perché tra i vari libri che ha nella sua stanza, si possono trovare diversi manuali di game design. L'escapismo è l'unico strumento che ha per non soccombere. Gli sviluppatori di Giant Sparrow utilizzano un gameplay ripetitivo al fine di replicare lo scollamento dalla realtà tipico dell’uomo inserito in una “catena di montaggio”, mentre il virtuale piano piano prende il sopravvento. In quello che per me rimane uno fra i momenti più alti che la narrazione videoludica abbia mai raggiunto, Lewis, e con esso il giocatore, rappresenta al meglio l'alienazione dell’uomo nell’epoca post-moderna. Affranto dalla realtà che non lo soddisfa e privato dalle sue droghe, si rifugia in un mondo illusorio che diventa sempre più dettagliato, accogliente, festante, dove può finalmente scegliere chi essere.
Stessa inquadratura, stessa mansione: scatolame, scatolame, scatolame.
Lewis e Gabriel, il protagonista di A Musical Story, hanno così tanto in comune. Cercano entrambi un modo per evadere dalla quotidianità e dalla routine deprimente, si aiutano con le droghe e, mentre il primo si arma di joypad e tastiera, l’altro imbraccia la chitarra elettrica e, a suon di riff, birre e spinelli, spera di tirarsene fuori. Gabriel è un ragazzo afroamericano dalle sembianze hendrixiane, che di giorno lavora in una fabbrica di fagioli in scatola e il suo allegro compito è di etichettare le lattine con il faccione di un corvo. Naturalmente questo non è il futuro che Gabriel ha sempre sognato per sé. Ma gli anni 70 si sà, sono stati gli anni delle rivoluzioni, della libertà, della trasgressione, delle grandi opportunità. E allora, insieme a due suoi amici musicisti, decide di partecipare al festival di Pinewood, che potrebbe essere il trampolino di lancio per la loro carriera musicale. Rimettono in sesto un furgoncino sgangherato e iniziano il loro viaggio. Solo che all’inizio del gioco ritroviamo Gabriel in un letto di ospedale in coma. Le cose non sono andate bene. Ed è qui che inizia la storia e anche il compito del giocatore.
Anche se non in formissima, a Gabriel è andata meglio che a Lewis.
Sono sempre di più i casi di persone che escono dal coma grazie alla musica. La musica ha il potere di risvegliare i ricordi, di infrangere barriere che in altri modi restano intatte ed inaccessibili. Proprio da queste premesse, partono i ragazzi del piccolo studio francese Glee-Cheese per costruire il gameplay e l'impianto narrativo del loro primo gioco. Con un'interfaccia minimale che ricorda un vinile, il compito del giocatore è quello di ricreare la melodia o il ritmo proposto su schermo. Per fare ciò, si hanno a disposizione solo due tasti: trigger sinistro e trigger destro. A seconda del tipo di melodia e ritmo, bisogna premere l’uno, l’altro o entrambi, andando a tempo con quello che ci viene fatto ascoltare e anche mostrato da alcuni cerchietti che compaiono sul bordo del cerchio principale. Più difficile da spiegare che da mettere in atto. Se prendiamo la nota nel momento giusto, il cerchio si illumina e una sorta di “proiettile” parte per andare a colpire il ricordo e generare un'onda. Insomma, le note che Gabriel suonava insieme al suo gruppo lo potranno svegliare dal coma, ma devono essere suonate bene, altrimenti non arrivano. Il compito, naturalmente, è quello di azzeccare il tempo e non sbagliare neanche una nota, pena la ripetizione in loop del breve fraseggio. Ogni capitolo si compone via via di un numero di fraseggi maggiore, che vanno a comporre il brano legato a quel ricordo. A volte, infatti, possiamo suonare un riff di chitarra, altre una base ritmica, altre ancora le tastiere o la melodica. Il concetto non cambia. Eseguire perfettamente a tempo le note. Quando tutto viene suonato alla perfezione, il ricordo si sblocca, la storia può proseguire e delle animazioni compaiono dove prima c’era il vinile nero.
A voi non ricorda un vinile? Scusa, che cos’è un vinile?
Descritto così, A Musical Story potrebbe sembrare un giochino casual banale ed insignificante. Invece no. Si vede che è un prodotto confezionato con tanta cura e amore. Amore innanzitutto per gli anni Settanta, per la splendida musica che hanno generato e la cui influenza continua ancora oggi a riverberare in alcune band (forse in alcune troppo spudoratamente). Amore per la cultura pacifista, per la vita semplice in armonia con la natura, per quel senso di libertà e di “tutto può accadere” che oggi invece abbiamo perso. È un gioco che consiglio assolutamente a chi ama quel periodo, la sua musica e anche a chi vuol seguire una semplice ma efficace storia di amicizia e amore, raccontata per mezzo di splendide illustrazioni animate senza l’uso di parole. Forse l’unico difetto, se così vogliamo chiamarlo, è che non fa nulla per aiutare il giocatore. O meglio, lo fa ma solo dopo svariati fallimenti. E se più o meno nella prima metà del nostro percorso le cose sono abbastanza facili, da un punto in poi c’è un innalzamento del picco di difficoltà davvero alto. Le ritmiche si fanno sincopate e le melodie dodecafoniche. Anche perché non ci sono aiuti visivi come in molti altri rhythm games. Bisogna “sentire” la musica, andare a orecchio, interiorizzare per poi ripetere. L’aiuto visivo si attiva automaticamente e progressivamente dopo diversi tentativi. Ma per chi vuole ottenere la stella, e quindi sbloccare il finale alternativo, non sono ammessi errori. Bisogna azzeccare tutte le note al primo tentativo, pena il fallimento di tutto il capitolo e quindi ripetere tutto da capo. Un pò di frustrazione arriva, soprattutto se si cerca la perfezione. D’altronde, il gioco è filologicamente onesto. Per riuscire a raggiungere il proprio sogno (Pinewood, in questo caso) bisogna esercitarsi, altrimenti si resta ad attaccare etichette sulle lattine di fagioli. Tutto il gioco è organizzato come un concept album, da ascoltare in fila. Un vecchio vinile che va ascoltato ripetutamente per essere assimilato, traccia dopo traccia, senza soluzione di continuità. Anche perché la musica sottolinea brillantemente gli eventi che capitano ai protagonisti. Si passa da riff potentissimi e ritmati a sintetizzatori cupi e sincopati, da ballate folk acustiche a rock psichedelico. Tutto è coeso e coerente, musica e immagini vanno di pari passo. Strepitoso!
Buddy Miles (1948-2008) R.I.P.
Anche a me questo gioco ha sbloccato un ricordo! Se il giovane chitarrista è chiaramente ispirato a Jimi Hendrix, il batterista ha invece una vaga somiglianza con l'esplosivo Buddy Miles, che è stato il vero batterista di Hendrix dal 1969 con i Band of Gypsys. Sono passati quasi venticinque anni da quando l’ho visto esibirsi dal vivo in un piccolo club di Recanati. Avevo da poco iniziato a suonare il basso e ogni occasione era buona per uscire ad ascoltare un po' di musica live, anche se ad essere sincero, il rock anni Settanta non ha mai fatto troppa presa su di me, pur essendo nato in quel decennio. Invece lo ricordo come uno dei più potenti, veri, galvanizzanti, trascinanti show a cui abbia mai assistito. Buddy aveva sempre il sorriso stampato in faccia, ha suonato la chitarra, la batteria e ha cantato in un lago di sudore tanta era la sua mole, ma non si è risparmiato e, pur avendone il diritto, non ha minimamente mostrato di essere una star, anzi il contrario. Ora non ricordo bene come e perché, ma a fine serata mi sono ritrovato nel backstage. E davanti a me, improvvisamente, si sono palesati tutti, e dico tutti, i cliché della rockstar anni Settanta. Canne, whiskey e groupie a gogo alle tre di notte. Io che non ho mai neanche fumato una sigaretta! Ma anche a questo servono i videogiochi, a vivere mille vite e anche a sbloccare ricordi.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata agli anni Settanta, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.