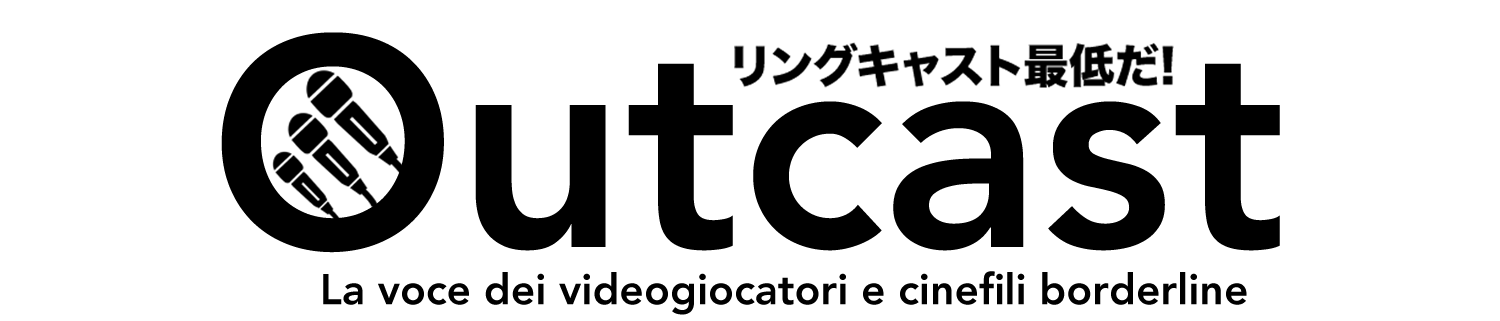The Mark of Kri è un massacro in stile Maori | Racconti dall'ospizio
Racconti dall’ospizio è una rubrica in cui raccontiamo i giochi del passato con lo sguardo del presente. Lo sguardo di noi vecchietti.
2002, la monolitica console Sony comincia ad entrare a regime: è l’anno di Need for Speed: Hot Pursuit 2, Kingdom Hearts (prima che svaccasse), Ratchet & Clank e soprattutto Vice City, appena un anno dopo quel GTA III che avrebbe influenzato la qualsiasi per i successivi cent’anni. Cominciava ad essere una lineup da indietreggiare e chiedere scusa, minacciosa, con le mani in pasta in qualsiasi genere. Eppure qualcosa mancava ancora, qualcosa che neanche quella bomba di Devil May Cry era in grado di soddisfare del tutto. Troppo stiloso, modaiolo e pettinato, il Dante di Capcom. C’era bisogno di un eroe più muscoloso, testosteronico, spietato e animalesco, qualcuno capace di prendere per le palle i nemici, appenderli al muro e ficcar loro una spada di un metro e mezzo in piena faccia: quel qualcuno era Rau Utu, eroe masochista dell’action/adventure moderno.
Accusata di appropriazione culturale “before it was cool” (si fa per dire), l’opera di San Diego Studio pescava dall’immaginario polinesiano, con panorami incantevoli e architetture plausibili (a occhio), costruite con pochi poligoni e tenute su da tanta buona volontà e immaginazione, tirando poi in mezzo la mitologia Maori e giustificando ‘sto mash up con intenzioni ben più fantasy che storico-culturali. Anche per queste scelte estetico-narrative, The Mark of Kri si distingue subito e si impone, con la sua stazza, nel panorama del videogioco di menare dell’epoca. Ma è DualShock 2 alla mano che ci si rende conto di quanto i suoi muscoli non siano pompati da steroidi virtuali; Rau è potenza pura, esaltata da un gusto primitivo per la violenza, incazzato nero per il tradimento subito ma soprattutto incazzato nero perché si! Un’escalation implacabile, efferata, barbarica come i beat ‘em up che venera e reinterpreta a 128-bit con l’etichetta PEGI 18. Eppure, a sorpresa, il gioco di San Diego Studio ha anche una forte inclinazione stealth, sulla scia di Metal Gear Solid, ovviamente (in particolare Sons of Liberty, uscito l’anno prima) ma in anticipo rispetto a Splinter Cell e conseguente deriva mainstream del meccanismo predatorio.
Un’eleganza nascosta dalla corporatura di Rau, usata tanto come elemento di gameplay quanto per esaltare la violenza di un titolo che, in contrasto col suo essere stilizzato e colorato, quasi cartoonesco, prova un piacere sadico nel far rotolare teste e vedere nemici impalati malissimo. Si gode dell’efferatezza del gesto, si gioca costantemente al gatto (ma diciamo anche tigre) col topo, accompagnati da un fidato corvo: Kuzo, spirito guida e occhi supplementari che osservano sbarrati il nemico da posizioni privilegiate, aiutandoci a preparare al meglio gli agguati. Ci si aggira furtivi in aree di dimensioni contenute ma tendenzialmente aperte a diversi approcci e lo si fa soprattutto per vedere l’ennesima fatality contestuale, abbracciando poi lo scontro frontale quando diventa inevitabile. Gruppi di mercenari che nel numero trovano un coraggio da piegare e poi sgretolare, attraverso un combat system che ad oggi propone ancora elementi unici, interessanti da sperimentare. L’analogico destro diventa quindi un radar per mappare fino a quattro elementi del branco, i primi che bagneranno di sangue la terra, ognuno con la condanna di un iconico tasto frontale del DualShock sulla testa, in modo da tenerli a bada contemporaneamente, quasi fosse un rhythm game. Guardia alzata, si indietreggia, si capisce chi è l’anello debole del gruppo e poi VIULENZA, giù botte, atrocità!
“ARGH mi si è incastrata la spada dentro lo sterno di questro stronzo!”
C’è un vagito di action contemporaneo, in questo modo di gestire la folla a fil di lama, qualcosa che oggi troviamo raffinatissimo e sotto due dita di cipria in Assassin’s Creed, estremamente più fluido e coreografico, ma anche nell’ultimo God of War, paragone più calzante per un titolo che, in un certo senso, deve più a The Mark of Kri che ai capitoli “greci”, decisamente figli mai riconosciuti di Kamiya (sempre nei sogni erotici dei game designer). È poi, entrando il possesso dell’ascia, massiccia e letale solo a guardarla, che ogni fendente assume un’inerzia pesantissima, inesorabile, con nemici tagliati in due di netto, armature che si sgretolano e urla disumane ad accompagnare ogni fiotto di sangue. Una mescolanza di generi su sfondo esotico (e pure esoterico, tra magia nera e grandi cattivi che vogliono dominare il mondo), che fanno di quest’opera qualcosa di estremamente giocabile e godibile ancora oggi. È infatti uno dei pochi titoli PlayStation 2 disponibili su PlayStation 4, insieme al buon seguito Rise of the Kasai, al netto di un sapore molto forte e non adatto a tutti, quello dei titoli acerbi, aspri, maturati negli anni sotto altre forme e nomi. Tribale come i tatuaggi che nel 2002 spopolavano tra teenager e ragazzotti - che dopo cinque minuti avrebbero voluto cancellarseli con la carta vetrata – e che dipingono il corpo di Rau raccontando la sua storia, terrificante monito a chi gli si para davanti, consapevole di un significato mortale e tutt’altro che frivolo. Il sangue che ribolle nelle sue vene con un ritmo in crescendo inarrestabile, quello che riesce a imprimere con la sua colonna sonora un Jack Wall ispiratissimo, che avrebbe successivamente composto, tra le altre, le musiche dei primi due Mass Effect. Un’Haka strumentale e culturalmente contaminata, tutta percussioni, gong e cori gutturali, ipnotici, che si adatta alla tensione di gioco e al ritmo dei combattimenti, riuscendo a fomentare oltre misura quella che è una missione sacra che verrà tramandata ai posteri come leggenda. Salvare il quinto “marchio”, salvare il mondo.
Ma si, oh, mettiamoci una croce sopra e amici come prima.
The Mark of Kri è una di quelle robe che mi fanno desiderare un improbabile remake, magari scritturando Jason Momoa per metterci la fazza (che ormai è il template dell’eroe polinesiano/nativo americano/barbaro contemporaneo), anche solo per vedere queste esecuzioni incredibili in 4K e appagare la mia perversione verso i massacri virtuali/cinematografici. Inutile negare il peso degli anni che si porta in spalla, soprattutto tecnicamente (anche per gli standard dei primi anni duemila, eh), eppure rimane un action raffinato, godereccio, che a 14,99€ (sappiamo tutti che ci sono modi ben peggiori di spendere questa cifra) vale tranquillamente la pena di essere scoperto. Una vecchia storia di cui parlano ormai pochi giocatori, persa tra le pieghe del gioco e del tempo ma che è importante non dimenticare, così come quel nome, Rau Utu, che le anime dei suoi nemici continuano a gridare e maledire, perché mazzate come quelle non si scordano neanche da morti.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata ai vent'anni di PlayStation 2, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.