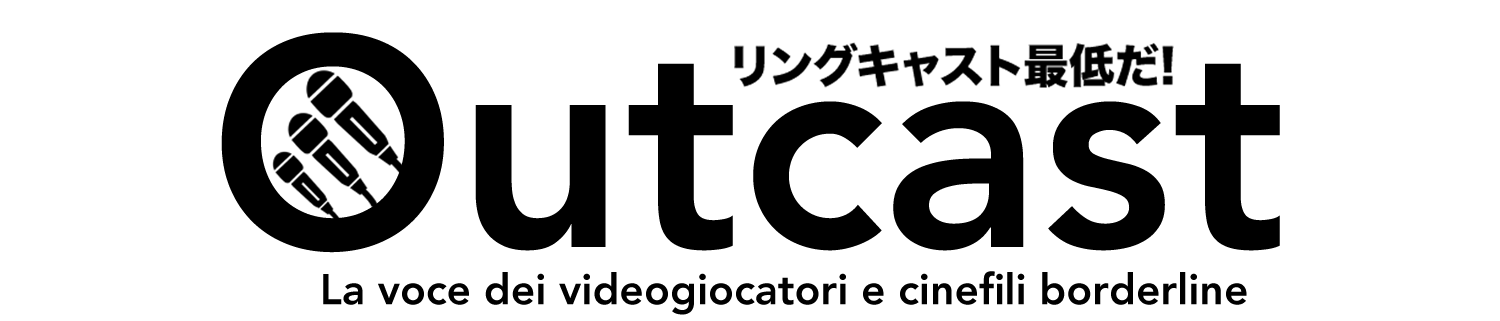Tokyo Mirage Sessions ♯FE: Dai, che anche io faccio il ballerino!
Senza girarci troppo intorno, Tokyo Mirage Sessions ♯FE mi ha annoiato. È un gioco pesante. Nella struttura, nei dialoghi, nelle battaglie, nello scorrere. A dispetto dell’esuberante idea di leggerezza che vorrebbe trasmettere, incastra il giocatore in una sequela di azioni uguali a loro stesse, dall’inizio alla fine.
L’acchito non sarebbe malvagio, dato che dopo qualche ora di gioco si capisce come lo sviluppatore, Atlus, abbia saggiamente evitato di mischiare ferocemente gli universi ludici da cui Tokyo Mirage Sessions ♯FE origina: da una parte Shin Megami Tensei, dall’altra Fire Emblem. Di quest’ultimo in realtà non c’è nulla, se non qualche sfuggevole rimando letterario, la forma degli alter ego che i protagonisti del gioco usano per combattere e qualche modalità di attacco negli scontri. In sostanza, si affronta una variante edulcorata dei noti Shin Megami Tensei: Persona; edulcorata nell’atmosfera, più gaia e meno apocalittica, e nella narrazione, più frivola e meno convincente.
I soliti ragazzi di scuola si trovano nei soliti quartieri di una Tokyo contemporanea, col solito trambusto giapponese quotidiano, a chiacchierare di coetanei elevati a star intergalattiche da un sistema di agenzie di spettacolo che nutre migliaia di fan adoranti. Il mondo degli idol o delle idol, insomma. Qualcosa di apparentemente distante da noi, ma che poi, scorso qualche canale a caso della televisione nostrana, ti ritrovi in essenza riprodotto nei vari Amici di Maria De Filippi e cloni. Mai avrei pensato di citare Amici di Maria De Filippi in una recensione. Qualche secondo di straniamento.
In questo contesto da “Amici” nel Paese delle Meraviglie, in cui meno amor proprio dimostri e più volontà di emergere sprizzi, più possibilità hai di farti infilare in qualche programma top come comparsa speciale, i protagonisti di Tokyo Mirage Sessions ♯FE sguazzano che è un piacere: decerebrati al punto giusto, gommosi quanto basta (“tettosi”, direi, nelle circostanze femminili) e pronti a fare qualsiasi cosa pur di acquisire carisma televisivo, anche osservare le movenze di un gatto per mezza giornata credendo che questo possa sviluppare doti da “gatta morta”, i nostri teletubbies siliconati ricalcano una generazione di adolescenti che, a forza di vederla proposta su schermo, cominci a credere esista veramente!
Un mondo alieno.
In questo mondo alieno, per altro, gli alieni compaiono sul serio: una banda di non meglio specificati spiriti fumosi tutti uguali, assai simili alle ombre di Kingdom Hearts, che avendo ben poco da fare nella vita, hanno bellamente deciso di sconquassare Tokyo, danneggiando in particolare i concerti di qualche pia ragazzina in minigonna, le sfilate pie di bimbe in bikini accompagnate dai papà e i pii pensieri degli uomini cresciuti sbirciando le sottane di Sailor Moon. E dire che la versione occidentale del gioco è pure censurata. Le tette sono più coperte. Anche i deretani, a dire il vero. E le foto osé non sono osé. Da noi questo gioco ha perso il suo unico senso.
Insomma, i nostri eroi vengono ingaggiati dall’agenzia idol di turno, trasformati in divi e, poiché dotati di poteri fantasmagorici, pure mandati a combattere gli alieni fumosi. Ovviamente l’agenzia è una copertura. Lo scopo è sconfiggere il nemico. Almeno in teoria. Perché nei fatti gli allucinanti dialoghi e le stravolgenti scenette di vita quotidiana ruotano per lo più intorno ai deliri del mondo dello spettacolo: si passa dalle vampate emotive di una “lady di ferro vorrei ma non posso”, scaturite dal dover indossare un costume a forma di orsacchiotto per un evento pubblicitario, alle turbe psichiche di un fotografo specializzato in pose erotiche che cerca di catturare l’attimo fuggente (di un sorriso accalappiante o di uno strato di pelle tra gli interstizi del reggipetto). La storia non c’è. Il flusso narrativo si arresta. Il ritmo latita e dopo trenta ore viene voglia di cambiare gioco. Anche molto prima, a dire il vero.
Che poi, per altro, si gioca. Anche bene qua e là, soprattutto quando si entra nei labirinti predisposti per le battaglie. L’esplorazione è persino avvincente: i nemici presenti su schermo garantiscono quel filo di libertà espressiva; gli ambienti tematici (ancora una volta in stile Persona) riescono a smuovere i neuroni incastrati nelle rotondità delle forme e nella stupidità delle parole. Quel che funziona è ciò che funziona da sempre in ogni Shin Megami Tensei: il ritmo delle battaglie, la logica dello scontro, l’alternanza dei colpi (siano essi semplici, speciali o elementali) e, in generale, l’abilità richiesta per vincere, in particolare se si sceglie il consigliatissimo livello di difficoltà più elevato. Atlus ripropone la stessa formula, vista e rivista, modificata e rimodificata, ormai da qualche lustro. Non può e non riesce a sbagliare quando si tratta di imbastire un sistema di combattimento a turni basato su punti di forza e di debolezza: solo che una cosa è reinterpretare lo stesso ruolo dovendo esibirsi in un contesto attraente; una cosa e rimasticare qualche arcinota sequenza di colpi in una cornice deleteria e priva di mordente. Battaglie ed esplorazione da sole non riescono a tenere in piedi il gioco. Anche perché, come spesso accade nei titoli Atlus, dopo un po’ che si gioca, vinte le prime resistenze e acquisita esperienza, si tendono a ripetere gli stessi schemi. Di solito ciò che esalta e spinge a continuare nel gioco, allora, è il tessuto narrativo, il motivo per il quale si lotta. Ma qui c’è ben poco per cui esaltarsi.
Il flusso estetico della battaglia di certo non aiuta. Io capisco tante cose. Capisco che questo benedetto Tokyo Mirage Sessions ♯FE sia basato sulle performance televisive, sugli stacchetti fuori tempo di qualche ballerina con la grazia di una papera, sugli atteggiamenti ermafroditi di ragazzi dinoccolati, sulle paturnie esistenziali di chi vive per piacere agli altri e firmerebbe cambiali per comprare qualche “mi piace” sul formato di rete sociale di turno… capisco. O almeno ci provo. Ma almeno datami la possibilità di togliere, levare, resettare, cancellare, eliminare grazie a un sacrosanto menu tutti quegli inutili bacetti, risolini, ammiccamenti, “smutandamenti”, atteggiamenti micidiali che condiscono ogni mossa prevista dal gioco. E vada per gli ingressi in stile wrestling americano; vada per le mosse super speciali con concertino annesso; vada per i colori sgargianti, i gridolini, e gli strombazzamenti, ma almeno risparmiatemi i colpi concatenati con stacchetto stucchevole, i voli pindarici che si susseguono tra un colpo e l’altro, il moltiplicarsi di cosce che annaspano nei cieli mentre il diligente algoritmo concatena l’attacco uno, e due, e tre, e quattro, e cinque senza che il giocatore possa far nulla, se non prepararsi un the e immergere nello stesso qualche biscotto… rigorosamente di marca, possibilmente di natura finto-biologica, ovviamente pubblicizzato in tv, che in un gioco così, dopo un po’ ti scatta dentro un sacro fuoco competitivo e un brontolio da esibizionista senza pari: prima di sedersi sul water è d’obbligo piroettare ballando con la carta-igienica doppio strato super assorbente, ultra aderente ed esibirsi in un sorriso stitico.
Perché tanto non esce niente. Si resta lì ebeti in attesa che succeda qualcosa di vagamente simile alla piacevolezza. Macché. Si entra in una rutilante sequenza di cose uguali a loro stesse: entra nel dungeon, esplora un po’, esci, guarisci, ritorna, esci, guarisci, controlla se c’è qualche missione opzionale, che ovviamente è lì ad aspettare, inutile a se stessa, e pure orribilmente noiosa, ma ti tocca farla perché sennò il personaggio non prende il potere carismatico previsto, e torna nel dungeon ed esci un’altra volta perché intanto hai abbattuto nuovi nemici e devi necessariamente potenziare le armi con gli “orb” da essi rilasciati, altrimenti non sviluppi poteri e ti si blocca l’audience; e ritorna nel dungeon, ma esci di nuovo, perché altre esuberanti cose da fare ti attendono, e cioè sviluppare ancora il personaggio che, nel frattempo, lottando, ha raggiunto un livello di popolarità inaudita, e magari ha pure guadagnato un vestitino sfarzoso da indossare; e sì, rientra ancora e ancora nel dungeon, ché forse dai è arrivato pure il momento di affrontare il boss… ma no, aspetta, esci un attimo, che dalla regia ti informano esserci ancora altre missioni opzionali, costumi da prendere, simpatici personaggi non giocanti da soddisfare, che ti rimandano dentro labirinti già visti e per altro dimenticati, dentro i quali fare cose simpatiche come abbattere dieci mostri dello stesso tipo sparsi nei quattro angoli dell’universo, e via di questo passo, di rottura di scatole in rottura di scatole. Che non ce n’è mai abbastanza! Corredata, poi, la rottura di scatole, da elefantiaci dialoghi di grandissima consapevolezza umana: “Mi trovi bella?”, “Sì!”, la risposta, “Ah!”, lo stupore, “Molto bella”, la conferma, “Perché?”, l’arguta domanda, “Perché sei bella!”, l’intelligente risposta, “Sul serio?”, la finta modestia, “Si!”, e che dire altrimenti?, “Che bello”, l’ovvia conclusione. O qualcosa di (molto) simile.
La grafica dicono che sia bella. Su altre riviste online, intendo. C’è chi la esalta, chi la trova appropriata, chi si è goduto un mondo. Dev’essere l’effetto mutanda. A me fa rabbrividire. Fatta con stile, eh! Adeguata al contenuto ludico, non c’è che dire. Ma i personaggi, modellati ad hoc per imitare le movenze umane, negli occhi, nel respiro, nelle forme molli e dondolanti, mi danno l’impressione di statue di cera vivificate… zombie di plastilina, qualcosa di simile. Manichini di un negozio che prendono vita. Finti nei contenuti, nei gesti, nelle parole. O per questo dannatamente veri. Chissà. Poi tutto quel colore acido, omogeneo, vistoso, sparato negli occhi… mi infastidisce. Ecco.
Sono costernato. Questo gioco mi ha colpito al volto con un gancio a destra e uno a sinistra: da una parte ritrae una fetta di mondo, un modo di essere umano, che non sai se credere totalmente vero. Se ci credi, ti arrabbi, perché non accetti che possa venire scherzato così, da un gioco che a tratti sembra compiacersi, a tratti pentirsi, a tratti non capire nemmeno cosa voglia dire. E se vuole dire qualcosa. Se non ci credi, ti chiedi a cosa serva rappresentarlo. Quantomeno perché in un modo così frivolo. Vuoto. Manca qualsiasi forma di riflessione. Di spunto. È puro edonismo. Narciso allo specchio. Mutande che volano, seni che fioccano, mercificazione di corpi. Dall’altra, c’è un gioco che non è né questo né quello. Pur attingendo a tante cose, non ha identità. Prende quel che funziona di altri titoli, ti fa credere di poter stare in piedi sulle sue gambe, ti illude, e poi crolla su se stesso. Incartapecorito in tante cose tutte uguali, che si trascinano di capitolo in capitolo, assecondando qualche pretesto.
Già, pretestuoso. Niente più.
Ho ricevuto da Nintendo una copia di Tokyo Mirage Sessions ♯FE sotto forma di contenuto scaricabile dall’apposito negozio online. Ho pure preso una console Nintendo Wii U di quattordicesima mano appositamente per questo gioco. Non l’avessi mai fatto! Quaranta ore spese a fissare un po’ lo schermo della televisione un po’ quello del grande pad, con volto frantumato e sconsolato. Antitesi del divertimento. Comunque, se non vi fidate e volete comprarlo lo stesso, ricordatevi che se acquistate il gioco su Amazon partendo dai seguenti link, una piccola percentuale di quello che spendete andrà a noi, senza alcun sovrapprezzo per voi. Se volete acquistarlo su Amazon Italia, cliccate qui, se invece preferite Amazon UK, cliccate qua.