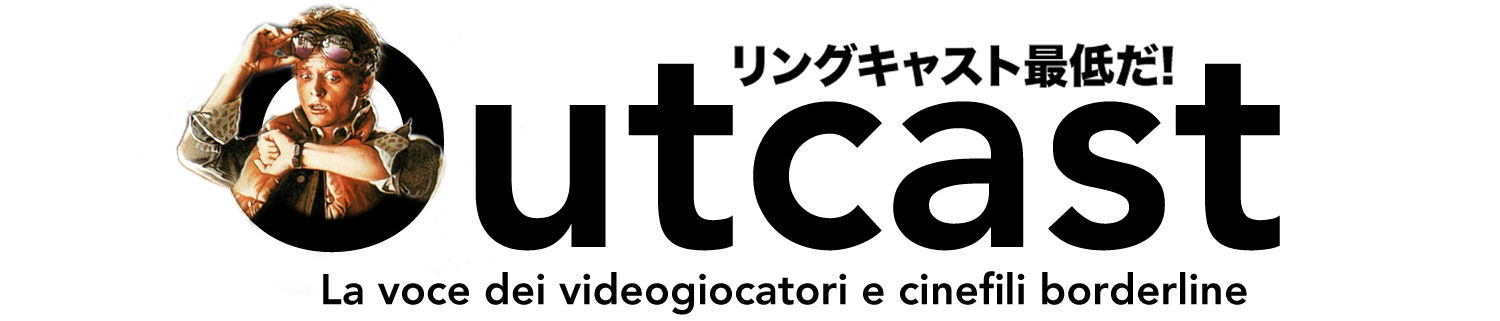L.A. I love you but you bring me down
“L’America non è mai stata innocente.
Abbiamo perso la verginità sulla nave durante il viaggio di andata e ci siamo guardati indietro senza alcun rimpianto.
Non si può ascrivere la nostra caduta dalla grazia ad alcun singolo evento o insieme di circostanza.
Non è possibile perdere ciò che non si ha fin dall’inizio.
La mercificazione della nostalgia ci propina un passato che non è mai esistito.
L’agiografia santifica politici contaballe e reinventa le loro gesta opportunistiche come momenti di grande spessore morale.
La nostra narrazione ininterrotta è confusa al di là di ogni verità o giudizio retrospettivo.
Soltanto una verosimiglianza senza scrupoli è in grado di rimettere tutto in prospettiva.”
Quando parliamo di quella grande nazione creata da uomini liberi che sono gli Stati Uniti d’America, siamo soliti fare una distinzione tra le coste e il centro rurale.
È un discorso che parte da lontano, dalla Cara Vecchia Europa che, una nave alla volta, arrivò con coloni e pellegrini per costituire la testa di ponte di tutto quello che venne dopo.
Caso volle che il punto di approdo per i primi migranti, quando già gli Stati Uniti erano passati dal nucleo originale di colonie ribelli ad essere la “Terra delle Opportunità”, fu un’isoletta che gli olandesi comprarono per 24$ ai nativi.
Manhattan, e quindi successivamente New York, è nata da una truffa.
Possiamo considerare questo il primo crimine della città? È sintomatico di un male intrinseco, di un’attitudine alla frode e alla violenza che dà le basi alla porta che gli Stati Uniti tengono aperta sul Vecchio Mondo.
Le coste sono estremamente differenti dal centro, le città sono diverse, le persone sono diverse, così come sono diversi i lavori e le attività che si svolgono.
Il centro rurale, le campagne, un’immaginario fondato sulla distensione a perdita d’occhio di campi coltivati per soddisfare il fabbisogno nutritivo della nazione con la maggior attitudine al fagocitare le proprie risorse.
Non è un caso che le città più grandi e popolose siano disposte sui confini, territori di passaggio, sul mare come sulla terra.
Le più popolose, come anche le più rappresentative di un aspetto estremo della cultura americana.
Per chi studia lo sviluppo urbano, è peculiare come le due città più popolose degli States siano estremamente differenti per caratteri opposti.
New York e Los Angeles sono disposte ai due estremi del blocco continentale USA, hanno seguito un modello di sviluppo diametralmente opposto (intensivo contro estensivo) ma quello che hanno in comune è la stessa cupa tendenza delle grandi città a favorire il proliferare del crimine e della violenza.
Se la cultura di New York Città violenta è stata ripulita nel corso degli ultimi ventr’anni con amministrazioni illuminate e nuove politiche cittadine, così non è stato per L.A., che mantiene la sua triste fama.
Culturalmente, cosa contraddistingue un criminale? Una necessità che legalmente non può essere soddisfatta e alla quale si ottempera quindi per vie para-legali, infrangendo la legge.
Il vivere di sotterfugi, in una città grande, è più facile.
Chi è nato e vissuto in una società rurale, fondata sulla cultura del lavoro, ha poco da rubare, se non indotto da un sovvertimento naturale o innaturale dell’ordine, che lo ha portato dalla condizione di vita rurale a quella di sopravvivenza per espedienti. Tra questi espedienti, il crimine è solo un’opzione in più.
In un progressivo spostarsi verso occidente delle masse di colonizzatori del nuovo continente, la Città degli Angeli rappresenta idealmente il limite estremo dell’America. E il fatto che sia posta su una faglia tra due placche tettoniche indica che la percezione poi così sbagliata non è.
Los Angeles è una città diffusa, uno sprawl, una distesa a perdita d’occhio di periferie agglomerate, separate tra loro da invisibili barriere di fasce di reddito. William Gibson, nella sua invenzione del cyberpunk, innalza questo scenario a vette poetiche per mezzo di un linguaggio ibrido, figlio dello slang della periferia unito a quello di tecnici del nascente mondo PC.
Lo sa bene chi si è preso almeno una volta il lusso di arrivare a Los Santos dall’equivalente made in Rockstar di Mulholland Dr., al tramonto, con la città nera puntellata di luci elettriche il cielo sconfinato bruciante di tinte arancio di un tramonto virtuale. E potrebbe proseguire così all’infinito. Strade suburbane, villette a schiera dal prezzo di fabbricazione bassissimo, che un genio crudele ha inserito nell’altrettanto criminale sistema di credito e debito che ha innescato la crisi immobiliare del 2009.
Fragili, che basta una scintilla per far divampare il fuoco che ridurrà il vicinato in un’immagine da prima pagina di TG nazionale.
Come a subodorare una costante tensione nel velo che separa il crimine dalla legalità, la narrativa ha esplorato la faccia nascosta della città in ogni modo.
Raymond Chandler, tra gli indiscussi massimi esponenti del genere noir, ambienta i suoi romanzi a Los angeles.
Lo stesso concetto di noir implica una visione del mondo ben precisa: mentre in un romanzo giallo, il crimine e l’omicidio sono una rottura dell’ordine naturale degli eventi, che il detective riequilibra con lo svelamento del colpevole; nel noir, i protagonisti sguazzano in una permanere dello stato di crimine, che l’azione dei singoli non può ribaltare.
Gli esempi letterari si buttano ma tra gli autori ai quali sono più affezionato c’è sicuramente James Ellroy, un altro la cui vita in un altro posto sarebbe stata completamente diversa.
Perdendo la madre molto giovane, rimane ossessionato dal caso simbolo della Los Angeles anni Quaranta, la Dalia Nera, che lo avvicina alla scrittura. Un uomo che macina e rielabora le sue ossessioni per chiudere un cerchio, per mettere un punto alla sua vita.
La tetralogia di Los Angeles è uno fra i migliori esponenti del genere noir della seconda metà del ‘900, erede dello stile asciutto e dei personaggi ruvidi del genere hardboiled, felicemente trasposti al cinema prima da Curtis Hanson (L.A. Confidential, bellissimo e con un cast fuori di testa) e da Brian De Palma (Black Dahlia, forzati nel ruolo di poliziotti anni Quaranta c’erano Aaron Eckhart e Josh Hartnett, un cast che più anni ‘00 non si può). Pellicole solide, tenute su dalla pura forza della potente narrazione che adatta la materia originale dei romanzi e, pur concedendosi fisiologiche sforbiciate alla mole cartacea, restituisce inalterato lo spirito del tempo. Dalia Nera è un po’ meh, a rivederlo adesso, ma L.A. Confidential si piazza legittimamente a fianco del capolavoro sulla Los Angeles noir di Polanski: Chinatown.
Un’ambientazione che, di nuovo, Rockstar ha esplorato nello sfortunato L.A. Noire che all’epoca, infognato come ero nel genere, mi fece impazzire, nonostante alcune ingenuità.
Ma essendo il concetto fondante più forte della forma della città stessa, Los Angeles si presta a manipolazioni e traslitterazioni, cosicché un giovane e semi-sconosciuto Ridley Scott ambienterà a L.A. quello che è il film più citato nelle aule della facoltà di architettura: Blade Runner.
Al di là del contesto futuristico, togliendo le macchine volanti e gli androidi che sognano unicorni elettrici, Blade Runner è un noir, la caccia all’uomo di un detective stropicciato contro le sue prede sintetiche e ribelli.
L’intuizione geniale sta nel comprimere nel tempo futuro, che per puro caso è il novembre del 2019, un avanzamento tecnologiche che possiamo definire low-tech accoppiato a una moda con il gusto del vintage anni Quaranta, andando a cortocircuitare la realtà e trasformando Los Angeles nel non luogo per eccellenza, con buona pace di Marc Augè, che ci arriva dopo. Una sterminata metropoli in fiamme, la cui skyline è dominata da colossali pubblicità olografiche.
Dello stesso trip, ma spostando l’attenzione su altre variazioni nello spettro del reale, fanno parte il revisionismo storico di C’era una volta a… Hollywood di Tarantino e il realismo magico di Under the Silver Lake di David Robert Mitchell. Entrambi i film si muovono in una Los Angeles idealizzata dove l’idea è più forte della realtà e che quindi piega la realtà stessa.
Detective stropicciato declinato al tempo presente
Tarantino lo conosciamo tutti, David Robert Mitchell no, ma dovremmo. È la mente dietro a quella piccola perla di horror indipendente che è It Follows e con Under the Silver Lake si va ad impelagare nella complessa materia del neo noir, sconfinante nel weird alla Vizio di forma di Pynchon e Anderson.
Le due visioni di L.A. hanno in comune la forza immaginifica dell’idea alla quale la realtà deve sottostare, e se da un lato Tarantino, col suo finale, perpetra l’idillio dell’epoca d’oro, dall’altro, con approccio ultra-contemporaneo, estremizza il lato strano e cupo di Los Angeles. La sua città degli angeli è pura apparenza che ricopre un mondo sotterraneo (letteralmente) di vizio, aspirazioni sconfinata e disperazione più nera in un piccolo, bellissimo, film struggente.
Los Angeles, la città di Pulp Fiction, di Heat, di Collateral.
Dove ti può capitare di essere rapito da un sadico proprietario di un banco di pegni, di trovarti nel fuoco incrociato di una rapina o di morire in un vagone del metrò senza che nessuno se ne accorga.
Ancora, sembra che gli individui che ci arrivano perdano la bussola, il fenomeno della californicazione, la cui paternità è contesa tra i Red Hot Chili Peppers e Tom Kapinos.
Nel mondo delle serie televisive post-Soprano, il criminale professionista è diventato il soggetto ideale per la scrittura seriale. Il criminale problematico, traumatizzato, che si mantiene in costante equilibrio su una facciata di sanità mentale, quando non proprio depresso, è un topos narrativo incredibilmente affascinante, che mostra una personalità al limite. Topos che ritroviamo anche in Ray Donovan, protagonista della serie omonima, un fixer di Los Angeles che cerca di scendere a patti con il proprio passato, giostrandosi tra esigenze familiari e professionali, in preda alla californicazione, quella tendenza autodistruttiva che coglie e infetta chiunque inizi a vivere e lavorare a L.A.
Ray è un personaggio affascinante.
Caratterizzato perfettamente da un Liev Schreiber in stato di grazia, è forse la migliore incarnazione televisiva di un personaggio di GTA. Il suo districarsi tra gli incarichi professionali e la sua vita privata è affascinante, la gestione della narrazione è caratterizzata da un incastro di situazioni ingestibili, senza facili vie di uscita, sempre a metà tra la legalità e l’illegalità. Ray rappresenta il ponte tra il mondo alla luce fatto di star del cinema, produttori e divi di Hollywood, con la loro vita patinata da copertina di tabloid, e il mondo di sotto, quello sporco che si accumula per le strade della metropoli, un misto di asfalto, smog, sangue e droga.
Ray è un fixer, un factotum, l’uomo che chiami se devi risolvere un problema.
Non è più il criminale inteso come anomalia ma un’emanazione che il sistema sviluppa per mantenere l’equilibrio.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata a The Irishman e al crimine, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.