Narrazione nei videogiochi: tutto sbagliato? Il vai a sapere di Thomas Grip
Uno fra i primi interventi alla Nordic Game Conference 2017 ha visto salire sul palco Thomas Grip di Frictional Games (Penumbra, Amnesia, Soma), che ha provato a raccontare come sia secondo lui necessario affrontare la narrazione nei videogiochi. E l’ha fatto partendo da lontano, da quella famosa immagine del vestito blu e nero (bianco e oro?) che ognuno vede alla sua maniera. L’ha mostrato sul grande schermo, puntualizzando che quel che stavamo vedendo non era un vestito, ma una serie di fotoni emessi da un proiettore, che si riflettevano sui nostri occhi e venivano elaborati dal nostro cervello. Tutto ciò che vediamo su uno schermo è illusione, è una serie di messaggi per la nostra capoccia, spesso pensati per illuderci e trarci in inganno. E il cuore del discorso fatto da Grip si aggancia proprio a questo concetto.
Ma partiamo ancora più da lontano: come mai a Thomas Grip interessa tanto la narrazione? Beh, perché in un videogioco horror, come sono i suoi, è importante, aiuta a raccontare un contesto, a creare un’atmosfera, a offrire motivazioni. Il problema è che spesso la narrazione nei videogiochi viene portata avanti costruendo spazi di gioco, ma non spazi realmente dedicati al racconto. Manca ancora la consapevolezza di cosa si possa fare per raccontare tramite l’interattività. E qui scatta l’inevitabile parallelo cinematografico: il primo film commerciale era una sequenza brevissima, in bianco e nero, senza audio e senza alcuna vera forma di racconto. Era uno spettacolo per la novità tecnologica su cui si basava, ma finiva lì. Col passare dei decenni, abbiamo aggiunto elementi legati alla narrazione come il montaggio, la gestione delle inquadrature, l’audio, la fotografia e siamo arrivati dove siamo oggi. Il primo film, visto oggi, è ridicolo. Non funziona. Ma non è necessariamente così per i videogiochi: il primo gioco commerciale, Pong, non ha mai smesso di essere divertente, perché il cuore del divertimento che sa dare sta nel competere col sistema di gioco, come del resto accade nella maggior parte dei videogiochi.
Se ti occupi di videogiochi a sfondo narrativo, stai inevitabilmente cercando di sfuggire alle regole tradizionali, ma è complicato, perché se te ne allontani troppo rischi di creare qualcosa che funziona male, che non sa coinvolgere, che fallisce sul piano dell’interazione. È come se chi lavora sui videogiochi incentrati sulla narrazione stesse cercando di salire in cima a una collina rapidissima, allontanandosi sempre più dall’interazione tradizionale, ma fissandosi su questa impresa non si rendesse conto che poco a lato c’è un’altra collina, più alta e soprattutto più bella, più interessante, che non viene mai scalata perché nemmeno ci si prova. E fra le due colline, a separarle, c’è la giungla dell’ignoto, in cui si sta malissimo. Attraversarla mette addosso paura, ma potrebbe valerne la pena. Certo, non è facile. Tornando al parallelo col cinema, il fatto è anche che i film sono nati da un contesto narrativo e sono cresciuti da lì, mentre i videogiochi sono nati altrove, quindi non è facile portarli in quella direzione.
Ma come funziona la percezione umana di quel che vediamo sullo schermo? Beh, lo sapete, è bizzarro, affascinantissimo e ci permette di vedere come oggetti tridimensionali elementi bidimensionali spalmati su uno schermo. Se vuoi riprodurre un palloncino, disegni un paio di linee e hai fatto. Eppure, quel che hai davanti è veramente solo quello: un paio di linee. Ma la nostra testa rielabora ciò che simboleggiano e ci fa vedere un palloncino, ancora di più se al disegno aggiungi qualche piccola linea che dia l’effetto del 3D. Il fatto, spiega Grip, è che nel nostro cervello ci sono tanti omini stupidi che gestiscono tutto quello che facciamo. Sono i moduli del cervello e ognuno è adibito ad interpretare determinati aspetti di ciò che vediamo, dar loro un senso, mescolarli con tutto il resto. Se l’arte funziona è anche perché abbiamo imparato a prenderci gioco di quei moduli, abbiamo trovato degli insiemi di principi e regole da seguire. Nell’arte visiva, ad esempio, per arrivare a una corretta rappresentazione dei volumi, dell’anatomia… per raggiungere il realismo, abbiamo ragionato su come funzionano effettivamente le cose: le luci, la prospettiva, i muscoli, la fisica. Forse, il punto è che bisogna arrivare a quello, ad avere una prassi, delle regole stabilite e realmente proprie del mezzo espressivo.
E di sicuro, nella maggior parte dei casi, non è su quella collina che si cerca di salire. Si segue invece la traccia adottata altrove, puntando su sequenze di eventi, esattamente come si deve fare in un libro o in un film. Ma nulla dice che anche i videogiochi debbano funzionare in questo modo. In fondo, una storia, è costituita dalla somma di più elementi: temi, ambientazioni, personaggi, trama, narrazione… se tutto questo lo infili in un videogioco, cosa ne viene fuori? E, dice Grip, non rompete le palle sostenendo che in un gioco la storia non debba esserci, perché chi la pensa così sta fraintendendo il punto della questione. La storia serve per fare da contesto ed è da sempre che svolge questo ruolo: Asteroids aveva una storia, veniva raccontata dalle immagini poste sul cabinato. Ciò che all’epoca era solo un piccolo spunto di contorno è pian piano cresciuto, per mezzo di cutscene, momenti scriptati, cose che accadono sullo sfondo mentre giochi, registrazioni, appunti, e-mail… ma tutto questo deve mirare a essere ciò che era la storia di Asteroids: un contesto per il gioco. Spesso, invece, si tende a sfruttare la classica alternanza fra storia e gioco, creando questi momenti di improvvisa densità narrativa, poco importa se a base di cutscene o contenuti da leggere sparsi in giro, per poi tornare al gioco vero e proprio. Ma se si vuole puntare sulla narrazione, bisogna provare a far sì che la densità narrativa rimanga sempre costante per tutto il corso del gioco. Alcuni giochi, dice Grip, ci riescono per brevi tratti: la caccia al cervo di The Last of Us, il finale di Brothers: A Tale of Two Sons, alcuni momenti di Firewatch… ma lo fanno appunto solo per brevi tratti, non si riesce ad avere un gioco intero strutturato in quella maniera.
Ma perché inseguire questa chimera? Perché i videogiochi, tramite l’esperienza interattiva, sanno darti qualcosa che altre forme d’intrattenimento non offrono: uno scambio. Non ci si limita a ricevere, si restituisce. E in questo senso, è importante ragionare su come funzionano i modelli mentali, vale a dire gli schemi che ci permettono di interpretare ed elaborare la raffica di informazioni tramite cui percepiamo il mondo. Il motivo, insomma, per cui se osserviamo un paio di righe su un foglio possiamo vedere un palloncino. Quando giochiamo con un videogioco, traduciamo quel che vediamo a schermo secondo i nostri modelli mentali legati al mondo reale e ci comportiamo di conseguenza. Muovendoci nello spazio di gioco, stabiliamo inconsciamente un percorso e ci muoviamo agilmente in una stanza, in un corridoio, senza andare a sbattere contro le pareti. Di fatto, prendiamo continuamente piccole decisioni, ma non sullo schermo: lo facciamo nella nostra testa, elaborando quel che vediamo e agendo di conseguenza, esattamente come facciamo nel mondo reale.
Un obiettivo importante nella creazione di un videogioco e di una consistenza narrativa interattiva, quindi, dev’essere quello di servire adeguatamente questi modelli mentali. Per questo è importante il senso di presenza, la capacità di creare esperienze che risultino non necessariamente realistiche, ma coerenti, credibili, trasparenti. Il giocatore, nel modello mentale che utilizza affrontando il gioco, non vede solo il contesto, vede anche se stesso all’interno del contesto stesso. In pratica, a livello mentale, entriamo letteralmente in una realtà alternativa e, per i meccanismi in base a cui funziona il nostro cervello, ci troviamo davvero a vivere nel mondo di gioco. Ed è fondamentale che chi sviluppa videogiochi possa muoversi all’interno di una serie di regole mirate proprio a questo.
I principi di base sono semplici: servono controlli intuitivi e trasparenti, perché il giocatore non deve “uscire” dal gioco per chiedersi quale tasto premere; servono input costanti, bisogna utilizzare tutto quel che c’è nel gioco per raccontare qualcosa; serve, si diceva, coerenza interna, in modo da non spezzare mai l’immersione; serve un realismo inteso come credibilità, basato anche sulla riconoscibilità di elementi per il nostro cervello (banalmente, la presenza di oggetti o parti del corpo con cui stabilire immedesimazione). Tutto questo va però poi a legarsi a quelli che sono i meccanismi del videogioco vero e proprio: i sistemi, che racchiudono il codice, la simulazione, le meccaniche e le dinamiche; la storia, intesa come messa in scena e racconto; l’affordance, che in un certo senso è la leggibilità degli elementi di gioco, la maniera in cui si lasciano interpretare dal nostro cervello e percepire in base al loro utilizzo.
Tutti questi aspetti si connettono fra di loro, generando un circolo virtuoso che parte dall’input del giocatore, passa poi per i sistemi, il feedback fornito dal gioco, la storia, l’azione, la nostra percezione audiovisiva, i nostri modelli mentali che elaborano le informazioni, la messa in pratica di ciò che decidiamo quindi di fare. E questo vale per ogni istante dell’interazione, ogni micropasso compiuto all’interno del mondo di gioco. Il gameplay, fondamentalmente, è ciò che mescola sistemi e modelli mentali, generando un feedback che noi elaboriamo nel decidere cosa fare, fosse anche solo il semplice camminare in un corridoio. E secondo Thomas Grip, più azioni puoi concatenare nella tua testa e meglio il gioco funziona, perché di fondo il bello dell’interazione sta nella pianificazione, nel decidere cosa andremo a fare per reagire ai problemi posti dal gioco.
Come mai i pesci sono intellettualmente limitati, chiede Grip? Perché, immersi nell’acqua, non vedono una fava, reagiscono solo a ciò che hanno immediatamente davanti. Per questo la pesca funziona. Se un pesce fosse un videogioco, sarebbe un Guitar Hero basato su suoni emessi a caso. L’evoluzione, volendola semplificare al massimo, sta nel pesce che esce dall’acqua, vede quanto di meraviglioso c’è là fuori e cambia in direzioni più variegate rispetto al passato. E del resto, si ritiene che quando osserviamo un bel paesaggio lo riteniamo tale anche perché pieno di elementi stimolanti e interessanti da elaborare.
Quando un videogioco ti offre la possibilità di sentirti competente, autonomo, e di provare un legame con i suoi elementi interattivi, sta facendo il suo dovere. Il fascino del gameplay, si diceva, sta nella pianificazione, e del resto chi implementa componenti da GdR nel suo gioco sta facendo leva proprio su questo, sta aggiungendo pianificazione. Quando affronti un livello di Dishonored, pianifichi. Lo stesso con un Mario. In Dear Esther non pianifichi, cammini e basta, e chi critica la sua natura da walking simulator, in realtà, sta criticando proprio questo: la mancanza di elementi sufficienti per pianificare, l’assenza di quel tipo d’interazione. E quindi?
Come si crea un framework, un insieme di regole, principi e modelli da seguire, per la narrazione interattiva? Servono, come detto fino a qui, il senso di presenza, i modelli mentali e la pianificazione. Per poterli utilizzare e far funzionare, bisogna conoscere il funzionamento delle cose, bisogna sapere come gira il nostro cervello e utilizzare metodi per ingannarlo e rappresentare ciò che vogliamo. Partendo da queste basi, si può ragionare sul concetto di storia all’interno del gameplay. Bisogna creare un mondo narrativo coerente, basato sugli attributi adatti al modello mentale su cui vogliamo agire. Serve evitare che il giocatore ragioni per modelli astratti, bisogna coinvolgerlo dandogli elementi che richiamino i suoi modelli mentali tradizionali. Servono azioni narrative fluide, che diano un feedback leggibile, che spingano verso la narrazione. Il giocatore non deve ragionare sui singoli elementi di gioco, ma su ciò che quegli elementi rappresentano. Ma soprattutto, chi sviluppa deve ragionare su quel che accade nella testa del giocatore.
Ci sono tanti esempi di cose che non vanno perché non seguono queste direttive. I sistemi di dialogo, spesso, non sono coerenti, non ti permettono di sapere cosa accadrà in seguito e viene quindi a mancare la pianificazione. Senza contare che manca la fluidità fra i vari momenti narrativi. E ancora, bisogna sfruttare i buchi narrativi, arrendersi all’impossibilità di creare simulazioni totali e abbracciarla, spingendo il giocatore a lavorare con l’immaginazione. Bisogna controllare la sua attenzione con cura, senza sommergerla di stimoli. È necessario dare la possibilità di gestire autonomamente il movimento e, quindi, la sua pianificazione. E ci sono mille altre questioni, mille altre domande ancora prive di risposta. Le risposte non le ha certamente Thomas Grip, ma d’altra parte siamo appena all’inizio del lavoro di ricerca. Ci sono, però, gli elementi necessari per compiere questa ricerca.
Ma perché lanciarvisi? Beh, innanzitutto, dice Grip, per soldi: ci sono poche storie giocabili e quelle belle tendono a vendere bene, quindi c’è spazio per inserirsi in un mercato florido. E poi, banalmente, perché è un viaggio interessante, un’esplorazione che merita di essere portata avanti, un territorio vergine che, in quanto tale, è affascinante e ricco di possibilità inedite. Perché lanciarvisi? Perché no?
Trovate il blog ufficiale di Frictional Games a questo indirizzo. In diversi post viene affrontato lo stesso argomento di quest’articolo, chiaramente in maniera più approfondita. Un paio di foto le ho prese da lì.
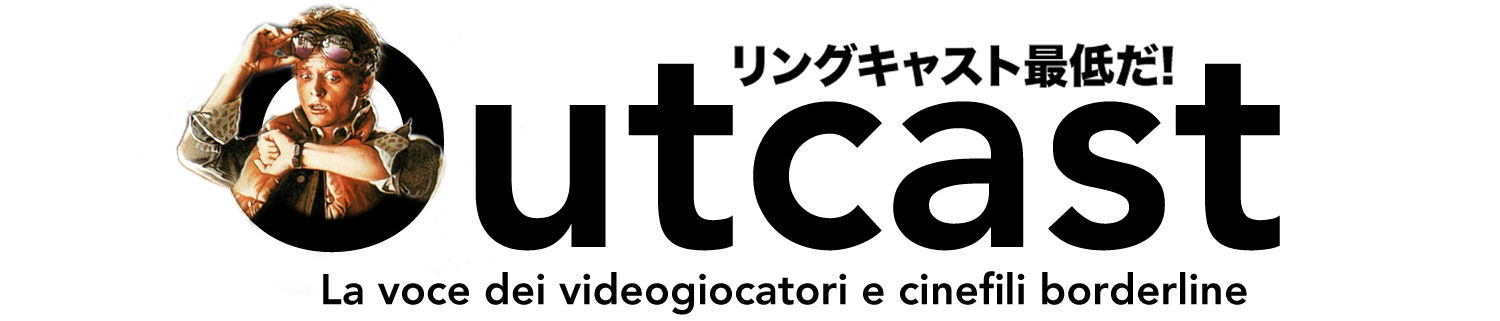





![[Nordic Game 16] Tim Sweeney chiacchiera del futuro](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/574bec3527d4bdfe229ea099/1464788908595-YCIPTWY54RRK0BJFPG3Q/sweeney.jpg)