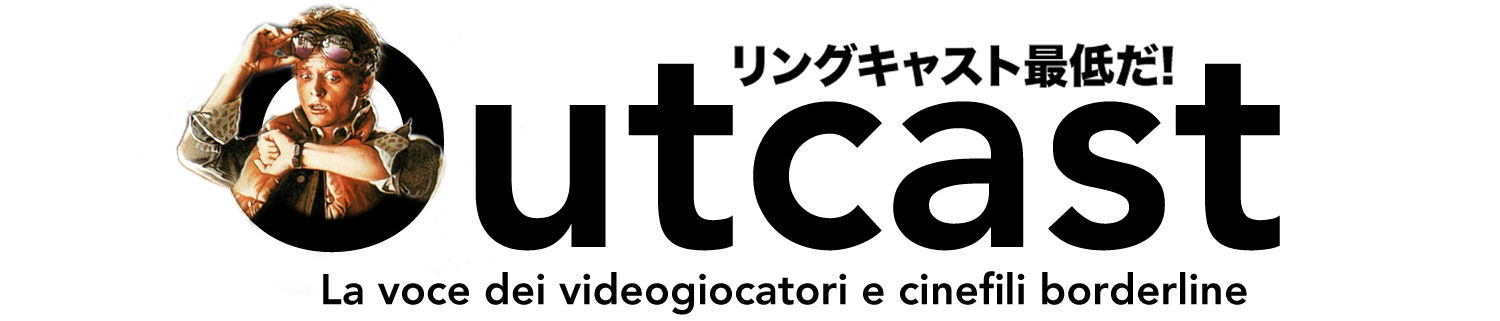Westworld: chi ha pulito lo sfaccimme dal 1973 al 2016?
Qualche sera fa, un po’ per senso del dovere nei confronti della Cover Story corrente, e un po’ perché sono in ballo con la seconda stagione dell’omonima serie TV, sono andato a ripescare il Westworld originale del 1973, passato dalle nostre parti con l’infame titolo Il mondo dei robot. Erano anni che non lo rivedevo. Quando frequentavo le elementari, secoli fa, era ancora considerato un film da prima serata. Ricordo benissimo le suggestive pubblicità con Yul Brynner, e il regolare tam-tam sulle riviste. Poi, piano piano, le comparsate sui palinsesti si sono fatte sempre più rade; gli orari sempre meno felici. Immagino che da un certo punto in avanti, Il mondo dei robot sia proprio scomparso dal radar dei canali generalisti; non posso saperlo con certezza, perché me ne sono andato prima io.
Comunque, fino a qualche giorno fa, del film in questione ricordavo davvero poco, e ne sapevo ancora meno. Ignoravo, ad esempio, che a dirigerlo fosse stato lo stesso Michael Crichton - il papà di Jurassic Park - al quale attribuivo a torto soltanto la sceneggiatura. Né collegavo che uno dei due visitatori protagonisti avesse il volto di James Brolin, il padre di Josh: in effetti, a vederla adesso, la somiglianza è davvero impressionante.
Ad ogni modo, al netto di qualche ingenuità soprattutto nella prima parte e dell’inevitabile invecchiamento dell’iconografia, delle scenografie e degli effetti speciali, ho ritrovato il film solido e tutto sommato semplice che avevo lasciato.
Sì, probabilmente nel 1973 la prolissa introduzione atta a descrivere le meraviglie del parco, i vizi concessi ai visitatori e le liceità sessuali nei confronti degli androidi funzionava meglio a livello di "sense of wonder". Quelle che all’epoca passavano per ricostruzioni sontuose del selvaggio West, del Medioevo e dell’antica Roma, oggi, fanno un po’ sorridere e non distano poi così tanto dai set della serie TV Fantasilandia, andata in onda tra il 1977 e il 1984, evidentemente figliastra dell’opera di Crichton.
La locandina del Westworld del 1973, sulla quale troneggia un cazzutissimo Yul Brynner in versione cyborg.
Eppure, quando nel parco le cose iniziano ad andare in vacca, e soprattutto quando il robot-pistolero (a cui tanto devono i primi due Terminator) inizia la sua caccia, Il mondo dei robot riesce ancora a mettere in gioco un ritmo della madonna. È pazzesco pensare che per trasformare Yul Brynner in un androide perfettamente credibile – anzi, indimenticabile - siano bastate sostanzialmente delle lenti a contatto. Così come è pazzesca, in termini di tensione, tutta la sequenza finale; pure al netto di certi invecchiamenti linguistici.
Detto questo, e nonostante le gigantesche e ovvie analogie, ne Il mondo dei robot ho trovato meno Jurassic Park di quanto mi sarei aspettato. Sì, OK, ci sono il tema del parco a tema fuori scala, e quello del caos. Eppure, tutta la riflessione sul rapporto tra etica e accelerazione tecnologica viene appena sfiorata, a favore di un più prosaico - e, ripeto, solidissimo - inseguimento in pieno stile western. Da un certo punto in avanti, sarà anche per la presenza di un attore connotato come Brynner, la sensazione di avere a che fare con un’opera di fantascienza quasi si dissolve nei colori della frontiera.
Alla poetica di Jurassic Park - direi libro - si avvicina molto di più il Westworld televisivo del 2016, ideato per HBO da Lisa Joy, nota (a me) soprattutto per il suo contributo a Pushing Daisies, e da Jonathan Nolan, che ha collaborato alla sceneggiatura di quasi tutti i film del fratello Christopher. La serie, che ospita nel personaggio del Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins) una versione distopica di John Hammond, si diverte fin dai primi episodi a giocare con i suoi stessi presupposti, sovrapponendo l’uomo in nero di Ed Harris all’androide in nero di Brynner. Analogamente, tutta la parte della scoperta del parco da parte dei “turisti” William e Logan fa pendant con l’attacco del film originale.
Durante i primi episodi, la serie si diverte a mescolare le carte rispetto al film, giocando sulle aspettative degli spettatori.
Il nuovo Westworld è una di quelle opere che si divertono a dialogare con lo spettatore, a sfidarlo sfacciatamente a duello. Credo sia proprio per questo che è riuscito a tirarmi in mezzo: adoro smontare e rimontare le cose.
La serie di Nolan e della Joy è deliberatamente interattiva; alla Lost o alla Twin Peaks, tanto per scomodare un paragone molto ingombrante. Il suo taglio meta-narrativo si srotola, tra le altre cose, sia attraverso la costruzione della timeline, che in via delle insistite allusioni al ruolo e alla responsabilità di un autore nei confronti della propria opera.
Contestualmente, Westworld apre una riflessione tutto sommato non banale sulla possibilità per qualsiasi creatura (soprattutto se artificiale) di affrancarsi dal proprio contesto natale per vivere di vita propria. E questo vale sia che si parli di androidi, che di personaggi di un romanzo di fantasia: i primi sono figli della tecnologia, i secondi del linguaggio. Del resto, lo stesso Ford è un ingegnere, ma anche un narratore; ed è proprio in seno al suo personaggio che si consuma un gioco dialettico tra scienze e discipline umanistiche attorno al tema della creatività.
Poi, per carità, non sempre tutte queste suggestioni si incastrano alla perfezione; soprattutto col passaggio alla seconda stagione (puntualizzo che sono fermo all’ottavo episodio), mi pare tendano un po’ ad annacquarsi. Però, insomma, per quel che vale: la prima mi è piaciuta un sacco.
«E se ci mettessimo i dinosauri?»
Detto questo, e lasciando da parte i segoni mentali miei soliti, forse la cosa che maggiormente separa il film del 1973 dalla serie del 2016 è la definizione del rapporto tra uomo e macchina. Il mondo dei robot dista cinque anni dal 1968 di 2001: Odissea nello spazio, e nove dal 1982 di Blade Runner. Basta una pendenza così piccola per fare tutta la differenza del mondo. Gli androidi della generazione di Yul Brynner sono poco più che degli animatroni che hanno ereditato i tratti assassini del calcolatore HAL 9000 (perlomeno, volendo stare al gioco di una lettura estremamente superficiale - per quanto diffusa - dell’opera di Stanley Kubrick). Non sviluppano una propria coscienza o un istinto di sopravvivenza; si limitano genericamente a impazzire. E una volta impazziti, perseguono obiettivi elementari più o meno legati ai loro copioni di partenza. In fondo, è anche per questa ragione che funzionano così bene a livello di tensione: sono inseguitori/esecutori con cui è impossibile ragionare. Il parco del 1973, con i suoi problemi, rispecchia il timore verso la tecnologia da parte dell’uomo della strada di quegli anni. Va detto che, al di là di questioni di dimestichezza, c’è di mezzo lo spettro della Guerra Fredda.
Gli androidi di Westworld sono una declinazione dei replicanti di Blade Runner.
Diversamente, i replicanti organici di Blade Runner, così come gli androidi del nuovo Westworld o i cyloni del remake di Battlestar Galactica, sono vere e proprie intelligenze artificiali capaci di sviluppare empatia, una coscienza individuale e persino una dimensione sociale. Siamo lontani dalla brutalità del pistolero nero, e decisamente più vicini ai robot dei romanzi di Isaac Asimov. Chiaro che un immaginario non ha negato la prosecuzione dell’altro. Come spesso succede, le due correnti - robot assassini e macchine intelligenti - hanno finito col coesistere dividendosi la scena e influenzandosi a vicenda.
Oggi, a fronte di una tecnologia di uso comune decisamente più complessa rispetto a quella del 1973, la semplificazione progressiva delle interfacce e del design degli apparecchi ha contribuito a fabbricare l’illusione collettiva di “vivere in sintonia con le macchine”. Se durante il giorno “parliamo” con Siri, la sera ci viene più facile accendere la TV ed empatizzare con gli androidi di Westworld o con quelli di Detroit: Become Human. Possiamo persino arrivare a condividerne i moti di ribellione e la rabbia contro il sistema (politico, sociale, eccetera) che li ha creati e messi in schiavitù, sovrapponendo eventualmente le loro storie alle nostre, il loro dissenso al nostro. In fondo, la necessità di rielaborare il presente è una delle molle che hanno fatto nascere alcuni tra i filoni considerati più “puri” della fantascienza.
La risposta alla domanda fuorviante del titolo, nonché all’unico mistero che ha spinto giopep a proseguire nella visione della serie.
Questo articolo fa parte della Cover Story “Jurassic Outcast”, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.
Come al solito, se acquistate i film segnalati nel pezzo (o qualsiasi altra cosa) su Amazon passando dai seguenti link, una piccola percentuale di quello che spendete andrà a noi, senza alcun sovrapprezzo per voi. Se volete procedere su Amazon Italia dirigetevi qui, se preferite Amazon UK puntate qui.