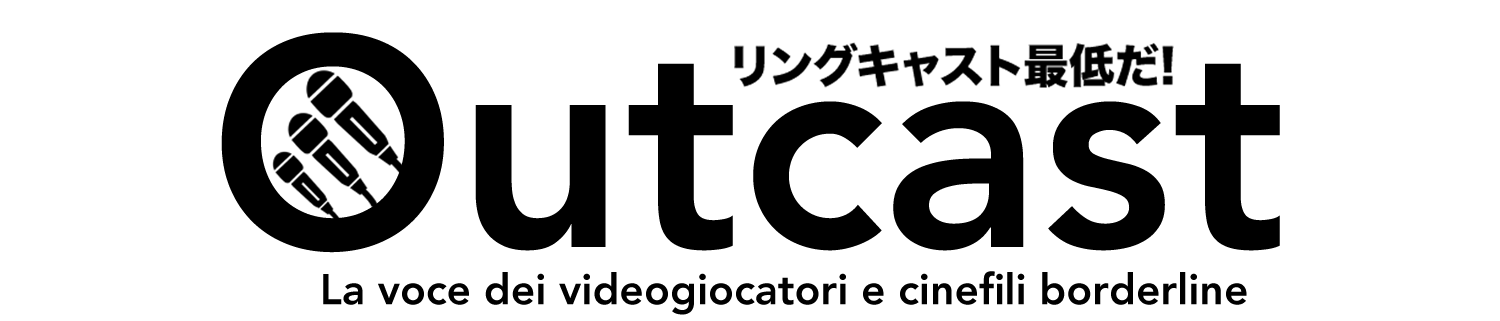Gravity Rush: precipitar m'è dolce in questo mare | Racconti dall'Ospizio
Racconti dall’ospizio è una rubrica in cui raccontiamo i giochi del passato con lo sguardo del presente. Lo sguardo di noi vecchietti.
Il discorso sulla sostanziale inutilità delle esclusive per quanto mi riguarda ha una eccezione, e quell’eccezione ha un nome: Gravity Rush.
Quando Japan Studio programmò Gravity Rush aveva evidentemente un solo mandato: “deve poter girare esclusivamente su PS Vita, anzi, deve avere senso solo su PS Vita e spingere la gente a comprare la nostra console”.
Perlomeno, è così mi piace pensarla, contro l’evidenza dei fatti che la prima piattaforma di destinazione del gioco era stata PlayStation 3. In questo senso, il modo migliore per rendere il coinvolgimento procuratomi da Gravity Rush è quello di paragonarlo ai primi giri con Gran Turismo su PlayStation.
Ricordatevelo: mentre voi affrontate in derapata una curva stretta, Shirley Manson sta affrontando il crescendo di As Heaven is Wide.
“If flesh could crawl my skin would fall from off my bones, and run away from here as far from God.”
E il rettilineo si spalanca di fronte a voi, buttate dentro la marcia e schizzate via!
E vi rendete conto che siete completamente inclinati sul lato destro della poltrona mentre girate il pad come uno sterzo… sembrando anche un po’ dei pirla (parecchio pirla).
Ecco Gravity Rush era tutto così. Un action con combattimenti all’arma bianca a sei gradi di libertà che permetteva di decidere liberamente il verso della forza di gravità. A mollo nella bolla gravitazionale - potere unico sulla cui origine, così come su quella della protagonista Kat, gravava il più fitto mistero - il giocatore puntava i piedi verso il cielo e partiva come un missile verso la stratosfera. Una volta lì, si orientava parallelamente al terreno trasformandosi in un caccia a volo radente. La parete di un palazzo poteva essere il marciapiede su cui camminare o il terreno contro cui schiantarsi se la “caduta” era stata troppo lunga. Tenere i piedi contro una superficie (fosse anche solo un soffitto o il fianco di un treno) e inclinare l’asse di gravità permetteva di surfare su onde di cemento. E se per caso nella nostra sfera di influenza ricadevano oggetti non ancorati al pavimento, ecco che tutto d’un tratto avevamo a disposizione un’artiglieria da scagliare contro gli informi nemici attirati come il miele da questa misteriosa energia.
Il piccolo mostro di Sony, degno erede di PSP, prestava ogni sua specifica al giocatore: l’accelerometro permetteva di orientare la protagonista sospesa nella bolla verso la nuova direzione di caduta, oppure di guidarla come fosse una vettura sportiva tra marciapiedi, scale, panchine, condotte, balconi, tetti e soffitte. Quando invece era saldamente ancorata a una superficie, non necessariamente il terreno, i due analogici consentivano di correre, camminare o dare un’occhiata in giro, mentre ogni tasto aveva una funzione ben precisa.
Apprendere come controllare il personaggio fu un’esperienza così rapida e gratificante che ben presto mi inebriai della libertà di movimento offerta dal gioco e, una volta accumulati i necessari punti esperienza per spingere “l’autonomia gravitazionale” ai massimi livelli, cominciai a non usare nemmeno più la monorotaia che collegava le isole fluttuanti tra loro, preferendo lasciarmi cadere dall’una all’altra. Lunghi voli che in alcuni casi duravano anche qualche minuto e che, sboronamente, concludevo con una caduta libera da centinaia di metri d’altezza riattivando la bolla a pochi centimetri dal suolo. Arroganza icaresca al massimo livello.
Veleggiare in questo mondo (forse l’unico veramente “open” visto che nessuna delle direzioni, cielo o abisso compresi, era preclusa a priori) era particolarmente rilassante e gradevole anche per la scenografia che lo tratteggiava, debitrice di quella scuola di fumetto franco-belga che ha come esponente più conosciuto Moebius. L’influenza grafica di Monsieur Giraud era evidente anche nel design dei protagonisti, nonché nei loro abiti e persino nella lingua incomprensibile che praticavano.
Come per Interstate ‘76 o Alice: Madness Returns, presto mi abbandonai all’esplorazione fine a sé stessa, conseguenza della coesione tra gameplay e ambientazione e non, come negli open world classici, premessa assoluta del gioco.
Esplorazione su esplorazione, alla fine terminai Gravity Rush, lasciandomi alle spalle una trama che nonostante fosse stata partorita da Naoko Sato e Keichiiro Toyama (quest’ultimo il papà di Silent Hill e Forbidden Siren) posso solo definire come “non pervenuta”.
Poi, purtroppo lo sappiamo tutti: Sony come al solito non credette fino in fondo nel suo piccolo mostro portatile e Gravity Rush dovette passare alla sorella maggiore, più potente ma strutturalmente incapace di replicare fino in fondo quella simbiosi tra giocatore e gioco data dall’istintivo inclinarsi, ruotare, ribaltare con la bella ma evanescente Kat.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata alle esclusive, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.