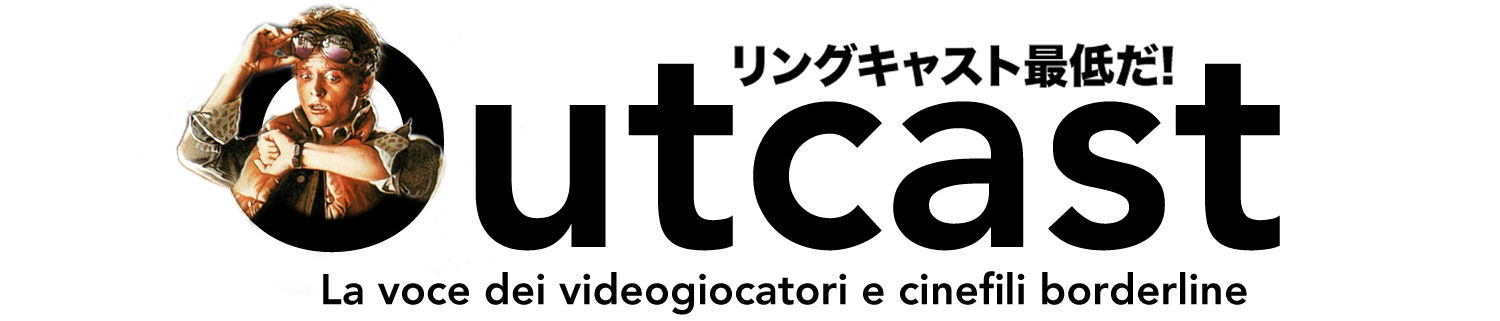Racconti dall'ospizio #220: Strider era bello pure quando faceva schifo
Racconti dall’ospizio è una rubrica in cui raccontiamo i giochi del passato con lo sguardo del presente. Lo sguardo di noi vecchietti.
Ho trascorso l’infanzia a mollo negli anni Ottanta più sfrenati, quelli pieni di brillantini, di giacche con le spalline e di zinnone del Drive In. Ma soprattutto, per quel che mi riguardava, di giocattoli meravigliosi come i Transformers, i Masters, i G.I. Joe e cose così. In più, diversamente da Batistuta, i miei genitori non facevano che viziarmi. Sarà che lavorando entrambi, forse, si sentivano un po’ in colpa a lasciarmi tanto tempo per i fatti miei; resta che ogni settimana finivo sempre a fare il giro dei miei negozi di giocattoli preferiti.
Era, senza mezzi termini, una figata totale. Pure quando non compravo nulla, mi bastava dare un’occhiata alle vetrine, oppure ai cataloghi di GIG o Mattel, per partire a razzo con la fantasia. A un certo punto, poi, si sono manifestati anche i videogiochi. All’inizio, attraverso un clone di Pong della Telesport già vecchio per l’epoca (si parla del 1985, più o meno), dopodiché sono arrivati il Commodore 64, il NES, il Game Boy e l’Amiga. Un paio di anni fa, rovistando nella cantina dei miei, ho persino riesumato un SEGA Master System che nemmeno ricordavo di avere, roba che neanche il ragazzino yuppie de I Simpson, guarda.
Io, all’età di dieci anni.
Sempre tornando a quegli anni, proprio di fianco a casa nostra viveva un mio cugino della mia stessa età. I suoi genitori erano - sono - ottime persone ma un po’ alla vecchia; ai giocattoli di marca preferivano robe educative tipo Il piccolo chimico, cloni filosovietici del Meccano, cloni filosovietici dei LEGO, cloni filosovietici dei Playmobil e certi fantomatici affari modulari in legno.
- A margine, probabile che la mia attuale avversione verso i giocattoli tradizionali sia nata proprio in quegli anni.
Ad ogni modo, con mio cugino siamo venuti su praticamente assieme. Lui passava un sacco di tempo da me, io da lui, e per quanto mi renda conto che sia parecchio strano applicare il concetto della nostalgia al me stesso-ragazzino di dieci anni che si era affacciato al mondo da uno sputo e mezzo, ogni volta che andavo a trovarlo mi pareva di viaggiare nel tempo. Arredamento, luci, tovaglie colori e persino odori di quella casa erano incredibilmente anni Settanta. Non gli anni Settanta della controcultura (che all’epoca manco sapevo cosa fosse), ma piuttosto quelli che emergevano da certi libri di ricette un po’ passé o dalle repliche de La famiglia Bradford.
Anche i pasti che consumavano mi parevano strani: niente Sofficini, Bastoncini Findus, Tegolini o Coca-Cola (alla base della sana alimentazione di un ragazzino degli anni Ottanta), ma piuttosto brocche di tè freddo fatto in casa, gran timballi di riso e, soprattutto, il cosiddetto “pastotto”, una specie di pasta allo zafferano che veniva consumata rigorosamente con la TV spenta. Ché poi, pure quando il televisore era acceso, non è che potessimo guardare i cartoni di Bim Bum Bam o cose così. Al massimo qualche documentario.
I LEGO filosovietici.
Però, adesso non vorrei passare per ingiusto, ché mi piaceva un sacco trascorrere le giornate da mio cugino. C’era qualcosa di accogliente e vagamente consolatorio, in quella famiglia che aveva scelto di chiudere il consumismo fuori dalla porta; solo, un po’ mi spiaceva che un ragazzino di quell’età fosse escluso dal grande flusso della cultura popolare.
Ma mi sono perso, ero partito per parlare di Strider, mi pare.
Uscito in Giappone in versione coin-op esattamente trent’anni fa, giorno più, giorno meno, credo che Strider sia uno di quei titoli che tendono a dividere noi vecchi: c’è chi lo considera troppo lineare e “molto fumo, poco arrosto” e chi invece lo ritiene un buon gioco ancora godibile. Io, tanto per cambiare, faccio parte della seconda categoria.
Se lo chiedete a me, il titolo di Capcom sfoggiava non soltanto una grafica assai stilosa, ma anche un gameplay divertentissimo e dal ritmo pazzesco. Eppoi, andavo pazzo per la faccenda della spada di luce (in realtà era una specie di scimitarra al plasma) che affettava i nemici mentre il protagonista era ancora in volo: credo fosse la cosa più “Goemon Ishikawa” che avessi mai visto un un videogioco.
Nato in seno a una collaborazione tra Capcom e il collettivo di artisti Moto Kikaku, fondato da Hiroshi Motomiya, Strider era parte di un progetto crossmediale che mirava a declinare il medesimo personaggio in un videogioco arcade, un gioco per Famicom e un manga.
Una tavola del manga Strider Hiryū, realizzato da Tetsuo Shiba assieme a Tatsumi Wada e serializzato su Monthly Comic Comp dal maggio all'ottobre del 1988.
Lo sviluppo del coin-op (terzo titolo per l’allora neonata scheda CP System, dopo Ghouls ‘n Ghosts e Forgotten Worlds) venne affidato al team di Tokuro Fujiwara, che a sua volta mise il timone nelle mani di Kouichi “Isuke” Yotsui, lasciandogli ampio margine di manovra. La fiducia si rivelò ben riposta: Yotsui, un giovane artista formatosi alla facoltà di cinema, si fece prendere dal perfezionismo e decise di dare il massimo, nel tentativo di creare un gioco in grado di soddisfare gli utenti ma anche di appagare eventuali spettatori alle loro spalle (in via della passione per i film, credo).
L’ambientazione di Strider, vagamente cyberpunk, proietta il giocatore in un 2048 distopico, dove la terra è stata messa in ginocchio dal misterioso Grandmaster Meio. Il compito del protagonista, Hiryū, il più giovane tra i ninja futuristici Striders, è quello di attraversare un set di livelli dall’aria decisamente filosovietica.
In particolare il primo stage, ambientato nel fantomatico Kafazu, sfoggia cupole bizantine e stelle rosse. I soldati che cercano di farci le penne somigliano a quelli dell’Armata Rossa, mentre il boss è un bizzarro uroboro meccanico, composto da quelli che parrebbero i membri di un soviet, armato di falce e martello.
Il comunistissimo boss del primo livello di Strider, Ouroboros.
Seguono un livello ambientato in Siberia infestato da cinesi inferocite, un’aeronave pirata, una lussureggiante foresta popolata da dinosauri (robot). Su, su, su fino alla base spaziale teatro della battaglia finale tra il protagonista e Grandmaster Meio, preceduta dalla consueta parata di boss redivivi.
Pare che l’idea del background sovietico sia saltata fuori per dribblare le solite ambientazioni giapponesi o americane e, contemporaneamente, per agganciarsi al tema della Guerra Fredda. Per conferire maggiore spessore al suo gioco, Yotsui si avvalse della consulenza di un collega proveniente dalla facoltà di lingue e adottò idiomi diversi a seconda dei vari personaggi: Hiryū si esprime in giapponese mentre Grandmaster Meio in inglese. Di quando in quando, fanno capolino anche il russo, il mandarino e lo spagnolo.
Le musiche, invece, vennero affidate a Junko Tamiya (Final Fight), che compose una colonna sonora in grado di spaziare dal rock progressivo alla musica barocca, passando per la classica e le sonorità tribali.
Ora, lasciamo pure stare l’incredibile verve di ambientazioni e avversari. Mettiamo per un attimo da parte anche i power-up, che da semplici pod à la R-Type si evolvono in un falco e in una pantera meccanica che copre le spalle al nostro ninja, sulla falsariga di Kyashan il ragazzo androide e di L'invincibile Ninja Kamui.
Kamui, il ninja protagonista dell'omonimo manga di Sanpei Shirato, è una tra le fonti alla base di Strider.
Resta che a Strider gli potrai anche dire di essere lineare, sì, ma fino a un certo punto: il level design - ispirato vagamente a quello di Rolling Thunder - non è mica banale, anzi. Tra parentesi verticali, accelerazioni improvvise e un eccellente lavoro di distribuzione dei nemici, spreme fino all’osso tutte le abilità acrobatiche del personaggio.
Poco dopo l’uscita nelle sale giochi, Capcom decise di sparpagliare Strider tra una marea di piattaforme. I port delle versioni destinate ai computer europei furono affidate a U.S. Gold, che all’epoca godeva di un contratto in esclusiva con l’azienda di Osaka, e sviluppate da Tiertex Design Studios. Quella più nota per Mega Drive, invece, fu curata direttamente da SEGA.
Personalmente, ai tempi dell’uscita non ebbi mai la fortuna di incrociare Strider in sala giochi, né tantomeno su qualche console. Ci giocai infinite volte, invece, a casa del mio cugino di cui sopra, in una spartana versione MS-DOS, visualizzata in grafica EGA su un monitor monocromatico in fosfori verdi. Ah, ovviamente da tastiera, senza joystick.
Tipo così, ma con meno colori.
Può darsi che il padre di mio cugino, al momento dell’acquisto di quel computer «buono per studiare», fosse stato attirato dal lore filosovietico di Strider, vai a sapere. Resta che, persino in quella sfigatissima versione, il gioco ci pareva fantastico. Sarà che era tutto quello che passava il convento, ma preferisco pensare che Kouichi Yotsui avesse messo a punto talmente bene la sua formula che nemmeno una cattiva conversione e un hardware di merda erano riusciti a bruciarne il nucleo.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata a Devil May Cry e alle pizze in faccia alla giapponese, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.