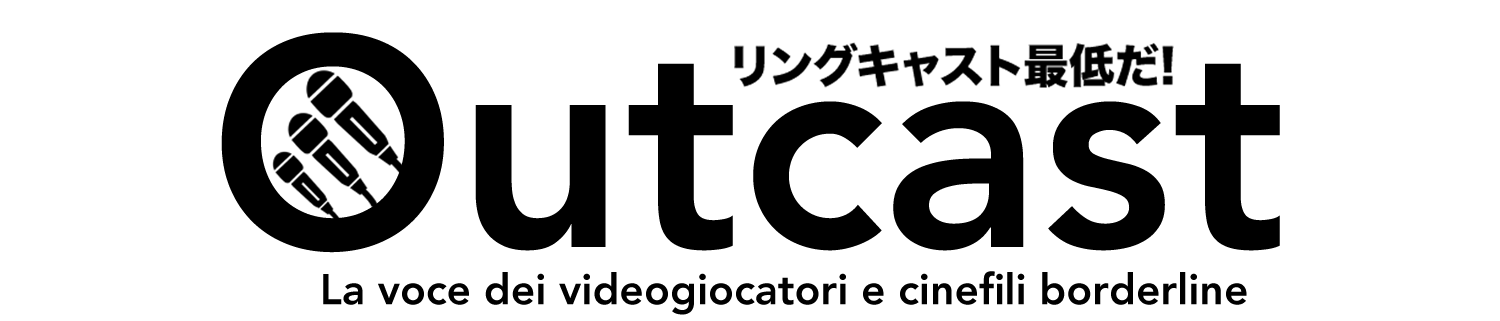C'era una volta a... Hollywood - Quando un hippie incontra un uomo con la camicia hawaiana, l’hippie è un uomo morto
C’è questa sequenza fantastica, nella prima mezz’ora di C'era una volta a... Hollywood, in cui il personaggio di Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt, scende dalle colline di Bel-Air a bordo della sua Volkswagen Karmann-Ghia del 1966. Dopo aver scodinzolato sull’ultima curva, lo stuntman prosegue a tutta manetta lungo la Beverly Boulevard, dribblando macchine su macchine, giù giù giù come un matto fino a un drive-in per spolverare, infine, la roulotte dove vive, in omaggio a una scena analoga del secondo volume di Kill Bill.
Ecco, a Tarantino basta questa cosa qui per mettere subito in chiaro un paio di cose. La prima: Cliff si annoia. Da quando gli gira male col cinema, e per guadagnarsi da vivere gli tocca lavorare come autista e tuttofare per l’attore (e suo amico) Rick Dalton, non può sfogare la sua fame d’azione. Nonostante vada pazzo per il rischio e non si tiri indietro di fronte a un combattimento - e in questo condivide più di un tratto col pugile Butch Coolidge di Bruce Willis - Cliff non è esattamente un drogato di adrenalina, ma piuttosto un giocatore che non riesce a stare fermo.
Avevo un compagno di classe così, al liceo. Il tipo di persona che ti infila una piccola sfida o qualche abracadabra acrobatico anche nelle azioni apparentemente più insignificanti, tipo dare da mangiare al cane o salire sul tetto per riparare un’antenna, e che non si pente di aver fatto qualcosa di stupido, fintanto che si è divertito a farlo.
Ma Cliff non è soltanto questo. È anche un supereroe invincibile e il tipo più pericoloso nei paraggi.
Qualcuno, una volta, ha osservato come la poetica di Spielberg consista grossomodo nell’infilare persone ordinarie in situazioni straordinarie. Ecco, quella di Tarantino sta praticamente all’opposto. I suoi sono personaggi straordinari alle prese con situazioni assolutamente pazzesche che, tuttavia, tra una botta e l’altra, trovano il tempo per cazzeggiare, scoprendo lati di normalità capaci di prendere lo spettatore alla sprovvista (cioè, dopo tanti anni un po’ meno, ma insomma, eh). Penso banalmente alle chiacchierate tra Vince e Jules in Pulp Fiction, che in questo film riecheggiano negli scambi tirati su da alcuni membri della Manson Family poco prima di entrare nei personaggi.
Quei due o tre momenti tra Pitt e Margaret Qualley sono deliziosi.
Ad ogni modo, Cliff, dicevamo. Cliff è un supereroe, perlomeno nell’economia di C’era una volta a… Hollywood. Viene presentato come invincibile, persino più forte di Bruce Lee, avvolto da un costume - l’inconfondibile camicia hawaiana - e addirittura dotato di un “superpotere”, se vogliamo tener conto del cane. In un film dalla vocazione se non corale, perlomeno tripartita tra lo stuntman, il suo tribolato doppio Rick Dalton e la Sharon Tate di Margot Robbie che, ovunque passa, proietta una crepuscolare spiritualità in via dello status di morto che cammina, il personaggio di Pitt spicca sia per la quantità di tempo che passa in scena, sia per la qualità. È a lui, infatti, che Tarantino lascia le chiavi delle situazioni più tese e riuscite del film.
Su tutte, l’incursione allo Spahn Ranch in chiave horror-western: sorta di degenerazione della sequenza girata poco prima da Dalton, dove un Cliff in versione “straniero senza nome” si confronta con la banda di Manson: in parte spinto dal desiderio un po’ paterno di tenere d’occhio una giovane autostoppista, in parte per vedere come se la passa il suo vecchio amico George. Ma soprattutto per il puro gusto di rompere il cazzo.
Oltre a pasticciare con i generi, la sequenza del ranch permette a Tarantino di esprimersi in uno dei numeri che gli riescono meglio, quello di spingere poco per volta la tensione fino al limite senza rivelare allo spettatore se ha in mano il punto o se sta solamente bluffando.
Detto questo, torniamo a Cliff che rientra a casa dal lavoro a bordo della sua Karmann-Ghia del 1966.
Rieccoci qua.
Mentre l’auto sfreccia per le strade con la radio accesa, intrecciando lo sfondo un livello alla volta, giocando con il parallasse e disegnando delle geometrie pazzesche al limite del possibile (se non deliberatamente impossibili), a un certo punto il mio vicino di posto, un giornalista svizzero pratico di videogiochi, mi tira il gomito e mi fa: «Oh, ma sembra GTA V!». Oh, sì, caspita, sì.
Per quanto non sia la prima volta che Tarantino mette in scena una roba del genere (mi viene in mente, toh, l’inseguimento per Tokyo del primo volume di Kill Bill), la sensazione di essere davanti all’ultimo Grand Theft Auto e, in generale, a una roba di Rockstar, è fortissima. E OK, lo so che è un cortocircuito pazzesco, che le influenze del cineasta di Knoxville sul lavoro degli Houser non si contano. Che l’attacco di Red Dead Redemption 2 fa un sacco The Hateful Eight (che, a sua volta, fa un sacco La cosa di Carpenter) eccetera. Ma, come dire, ho avuto la sensazione che Tarantino certe immagini le abbia messe lì apposta per il gusto di mescolare le cose e depistare lo spettatore.
Tipo quando prende la struttura di un genere e ci butta sopra la casacca di un’altro, qui potrebbe essersi divertito a impicciare i linguaggi fino al paradosso di far parlare il suo “film sul cinema” quasi come un videogioco. E non un videogioco qualsiasi, ma un open world di quelli che la gente ci vede dentro le cose di cinema, si tira le pippe del giocatore/regista e ci fa persino i machinima, senza contare che pure in GTA V l’azione è spalmata su tre personaggi. Oddio, sarebbe sublime, ma probabilmente sovrainterpreto (così come sicuramente sovrainterpreto la faccenda dei piedi nudi e polverosi di Margot Robbie/Sharon Tate che mi tirano in ballo certe teorie sepolcrali sulla presunta morte di Paul McCartney e che fanno pendant con l’“Helter Skelter scenario” della Manson Family fermatemi vi prego fermatemi).
Il poster di Inception.
Fermiamoci, sì. Ed entriamo un po’ più nello specifico della tripartizione. Piuttosto che tessere una sorta di disegno coerente come in Pulp Fiction o nei 22 cortometraggi di Springfield, la scrittura di C’era una volta a… Hollywood è po’ menefreghista. Tarantino, che probabilmente sa di non avere niente da dimostrare, si diverte a seguire uno alla volta i suoi personaggi, preoccupandosi più dell’atmosfera che delle dinamiche di causa e effetto, ma con una misura e una delicatezza che non gli vedevo uscire dalle mani da un bel po’.
Cliff, come ho detto, si spara il suo viaggio da eroe, mentre Rick tenta di venire a capo della sua crisi professionale e personale, aiutato da una ragazzina che ricorda (e sfotte?) certe redentrici felliniane. E poi c’è la Tate di Margot Robbie, che cammina sul crepuscolo della vecchia Hollywood quasi sospesa da terra, benedicendo la vera Sharon Tate, che passa sullo schermo dove proiettano The Wrecking Crew (mi rifiuto di riportare il titolo italiano del film)
E parlando di Bruce Lee, non so quanto sia verosimile la Sharon Tate di Margot Robbie. So soltanto che, nell’economia del film, è impeccabile.
Tra la potenza del lato di Cliff e la debolezza di quello di Dalton, con la Tate nel mezzo, le tre storyline di C’era una volta a… Hollywood procedono per le loro strade, incrociandosi solo di tanto in tanto, proprio lo stretto necessario. Consegnando alla messa in scena, più che alla sceneggiatura, il compito di mantenere un’unione di fondo.
E consegnandolo pure alle aspettative dello spettatore, con le quali il regista si diverte a giocare dall’inizio alla fine del film, arrivando a scomodare il metaforone finale sul cinema di genere che, per poter essere accolto nei salotti buoni, deve fare letteralmente l’impossibile. Metaforone sul quale si sarebbe anche potuto glissare, se lo chiedete a me, soprattutto per la caciara che tira in ballo. Ma a Tarantino la caciara piace, ormai è chiaro. E che gli vuoi dire?
C'era una volta a... Hollywood uscirà nei cinema italiani il prossimo 18 settembre. Io ho avuto la fortuna di guardarlo in anteprima all’ultimo Locarno Film Festival, per di più graziato da una proiezione stampa in lingua originale con i sottotitoli in francese, in un tripudio di Royal con formaggio, le Big Mac e cose così.