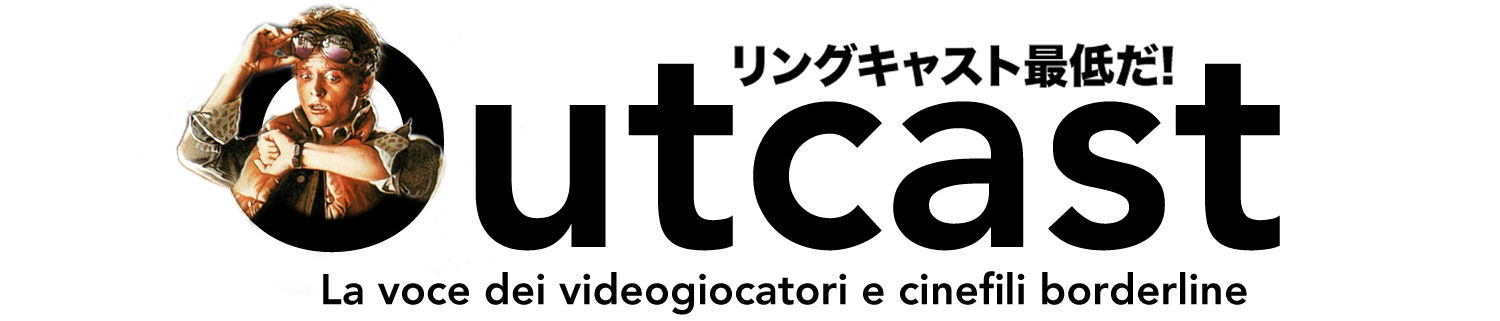Cuphead: testa di tazzina, cuor di frustata
Della veste grafica di Cuphead s'è già detto e scritto di tutto, e con ogni probabilità avete già sentito e letto di tutto. E a ben donde, dato che il lavoro di Chad e Jared Moldenhauer, fondatori di Studio MDHR, merita tutte le lodi sperticate che sta raccogliendo e tutti i dietro le quinte che riuscite a setacciare. Specie quando alle spalle c’è una storia di profondissimo amore per il medium, di enormi sacrifici e, a un certo punto, anche di meme e diffidenza dell’Internet, che ha avuto la fortuna di culminare con un lieto fine da manuale dei fratelli Grimm. Se avete bisogno di un recap, per comodità vi linko la bella recensione di un amico, che si prende la briga di raccontare il necessario con la passione di chi per mestiere fa il grafico e quella di chi s'era preso strabene per il gioco sin dalla sua primissima comparsata.
Cuphead, vivaddio, non è però solo la sua formidabile estetica, né tantomeno materia buona giusto per un nuovo Indie Game: The Movie con più senso di un Blade Runner 2049. È un gioco dall’armonia invidiabile. A dare anima al suo mondo ora caricaturale, ora grottesco, ora surreale, dove la fantasia si ritrova a galoppare, sfrenata e incosciente, nell’esatta maniera con cui era solita farlo nei cartoni animati anni Trenta verso cui grida a squarciagola il suo amore, c’è una giocabilità cristallina. Il gameplay è di una reattività inappuntabile e di una precisione millimetrica, faccende nient’affatto scontate, quando la baracca è stata costruita mediante tecniche di animazione ibride e ospita una travolgente parata di elementi in movimento, di ogni foggia e dimensione, di cui si potrebbe facilmente scazzare qualche collisione. Nel mezzo, ma anche un po’ sopra, sotto e tutt’intorno, si infila una colonna sonora di matrice jazz poliedrica e di classe, non solo anche lei perfettamente in grado di carpire lo spirito di quell’immaginario, ma anche e soprattutto capace di puntellare con invidiabile perspicacia e puntualità il tono di ogni tipo di situazione. Tra coretti in bassa fedeltà, fanfare, jingle, swingate, soli di pianoforte, cavalcate da big band e canzoni che non sfigurerebbero in un nuovo spot della Tabù, se oggi non fossimo - giustamente - sensibili a certe tematiche, l’accompagnamento musicale piazza sempre il pezzo giusto al momento giusto. Cuphead è insomma un gioco superbamente orchestrato. Una considerazione triviale, me ne rendo conto, valevole per moltissimi altri titoli, e a cui si può arrivare già dopo pochi instanti di gioco, ma che in realtà ne coglie l’essenza più profonda e distintiva.
Cuphead è un action 2D, un po’ platform, un po’ run’n’gun, un po’ SHMUP, tanto boss fight. Come sapranno anche i muri, il nocciolo e la polpa della faccenda è proprio l’ultimo tipo di dimensione, a cui successivamente è stato appiccicato dell’altro. Le meccaniche sono quattro in croce, ma le situazioni che ne scaturiscono una miriade e spesso inimmaginabili.
Quale che sia il vostro livello di bravura ed expertise con il genere o in particolare con il gioco, direi che siam tutti d’accordo nel definire Cuphead rigoroso e impegnativo. Rigoroso, perché non concede assolutamente nulla. Toh, qualche secondo di invulnerabilità nel caso si venga colpiti, accompagnati da un salto automatico grazie al quale venire ributtati in campo se si era pure finiti in un precipizio. Stop. Anche un frangente catartico come il lancio di una special o una super non concede niente, dato che nel primo caso si innesca un micro-spostamento del protagonista, mentre nel secondo, a spostarsi sotto le vostre chiappette, potrebbe essere il mondo, se sta scrollando, due evenienze che, se non preventivate, possono portare a spiacevoli conseguenze. Impegnativo, perché esige applicazione. Non può essere giocato distrattamente o col pilota automatico, mentre pensate al GOTY della prossima settimana o a quale misconosciuto titolo 16 bit assomiglia di più, in attesa di citarlo la prossima volta che fate a chi ce l’ha più lungo in una discussione sui social. Il gioco richiede di essere lì, presenti e attivi. Ma c’è dell’altro, ancora. È inutile che gli estimatori (tra cui sono in prima fila, spero si sia capito, a questo punto) provino a nascondersi dietro a un dito, timorosi che qualcuno scopra l’elefante nella stanza e se ne esca con un accostamento solitamente ritenuto infamante: il gioco ha una forte natura trial & error. Chad e Jared Moldenhauer non hanno difatti speso tutti gli anni dello sviluppo a farsi le seghe di fronte a una collezione di rodovetri della Fleischer Studio mentre ascoltavano 78 giri dell’anteguerra, lo hanno anche investito per escogitare una ricchezza di soluzioni di gameplay a dir poco fenomenale. È così tanta la varietà e fantasiosità delle situazioni che si parano davanti, che nella maggior parte dei casi non si hanno gli strumenti per superarle alla prima botta. Ogni stage è un nuovo spartito che tocca studiare, metabolizzare e su cui applicarsi. Non si scappa.
Cuphead riconosce la possibilità, entro certi limiti, di scegliere l’ordine con cui affrontare i nemici, ma una volta in campo è lui a dirigere le danze, con fare metronomico, inflessibile, impassibile. Non ci sono checkpoint, shortcut o altri metodi per mediare con la sua progressione ferrea: vieni tirato in ballo e ti tocca ballare, dall’inizio alla fine, senza sconti, aiuti da casa o spazi per negoziare con uno “Scusa, vengo da sedici ore di lavoro e tengo famiglia, non è che potresti chiudere un occhio?”*. I boss randomizzano molti dei loro pattern di attacco, per cui una certa elasticità c’è, non si sta giocando a un laser game spastico tirato come la corda di un violino, ma a parte due eccezioni microniche e circoscritte, non sono strutturalmente flessibili. Cioè, per intenderci, quando il nemico è fiancheggiato da un gemello o simile o presenta degli arti indipendenti, non si può decidere di far fuori prima questo o quell’altro, influenzando l’evolversi della battaglia, come capita di vedere altrove, ma occorre limitarsi a infliggere genericamente quanto più danno possibile, per farlo passare alla fase successiva. Un pentagramma che non si può riscrivere, dunque, da seguire sotto l’occhio sempre attento del direttore d’orchestra, fino a che morte non vi separi.
Ed è a furia di sgridate, scappellotti, bacchettate sulle mani, ceffoni, umiliazioni e pugnalate alla propria autostima, tra morti che si contano a centinaia e opzioni di “retry”, che tante volte ci si riscopre a pigiare compulsivamente, paonazzi, sull’onda della foga e di una scarsa lucidità, che magari sei secondi dopo esser ripartiti si è già sotto di 2 HP, che Cuphead insegna a entrare in sintonia con questo musical tanto sfolgorante ed esaltante quanto severo ed esigente. Man mano che si prende confidenza con la partitura di ciascun livello, si riesce ad accorciare i tempi per raggiungere la fase successiva. O a permettersi improvvisazioni o veri e propri cambi radicali di tattica, grazie a qualche power-up che modifica significativamente l’approccio. Ma anche in quest’ultimo caso, no pain, no gain: occorre imparare, imparare, imparare, alle sue condizioni, guadagnandosi le monete necessarie all’acquisto dei potenziamenti in livelli run’n’gun che non sono meno implacabili, imprevedibili e impietosi degli altri.
In Cuphead non si interagisce con la musica, che non è nemmeno dinamica, e non vi sto dunque dicendo che ha componenti rhythm. A dirla tutta, non sto neanche sostenendo che il discorso che ho provato a intavolare sia intenzionale, previsto in qualche modo dai Moldenhauer. Resta il fatto che è uno dei titoli che riescono a fornire una fra le più grandi lezioni sul ritmo a cui mi sia mai capitato di giocare. E anche sull’apprendimento. E sul provare a controllare le proprie emozioni, sforzandosi di trovare il giusto equilibrio con un metodo, nell’accezione più accademica possibile, stando magari attenti a non mettere il piede due centimetri troppo in là, scivolando verso l’ossessione. E sulla voglia di migliorarsi. E sulla convivenza con l’idea di fallimento, prevista istituzionalmente attraverso una conta delle morti e un grafico che visualizza quanto ci si è riusciti a spingere, subito dopo ogni tentativo. E di succedere. E di superare quelli che di primo (ma pure di secondo, terzo, quarto, sedicesimo…) acchito possono sembrare limiti invalicabili. E un po’ anche una lezione di vita. Esattamente come quelle impartite dall’insegnante-mostro interpretato da J.K. Simmons in Whiplash, che è gli valso un meritatissimo Oscar, a cui a questo punto Chad e Jared potevano dedicare una boss fight. Anche se in realtà è già lì, inserito da qualche parte nel codice del gioco, ispirandolo nella sua interezza, grazie a qualche magia. L’ennesima e forse più importante del capolavoro firmato da Studio MDHR.
* Cioè, in realtà uno spioncino c’è, è la modalità Simple, ma non l’ho mai provata, non mi interessa provarla e non è a chi gioca in quel modo che mi interessa rivolgermi.
Ho sbloccato gratuitamente Cuphead grazie al mio account Steam Press, datomi qualche anno fa da Doug Lombardi di Valve per permettermi di svolgere più agilmente il mio operato di attivista del PC gaming. Che è morto nel 2006, ricordiamolo, ma vi sotterrerà tutti. Ho finito il gioco in ventiquattro ore, secondo quanto dichiarato dal contatore di Steam (di cui verosimilmente sei o sette alt-tabbato, a fare i cazzi miei), e attualmente sto dando una sgranocchiata alla modalità Expert, anche se non so se la completerò o quanto a fondo mi dedicherò al miglioramento autistico delle mie valutazioni, come mi capita puntualmente con i titoli che mi prendono veramente bene, dato che fra poco arrivano in doppietta (mannaggia a Bethesda!) gli unici tripla A a cui ho davvero voglia di giocare da qui alla fine del 2018, e forse oltre: The Evil Within 2 e The New Colossus. Vabbé, ve lo farò sapere tramite Twitter o le mie storie di Instagram. Ah, Cuphead è disponibile anche su Xbox One.